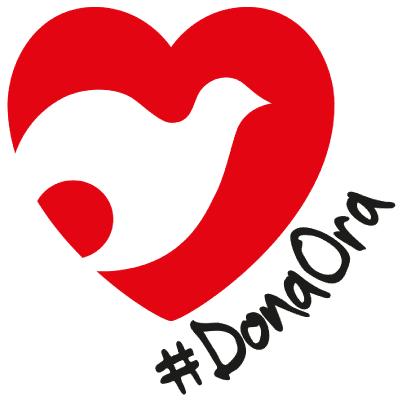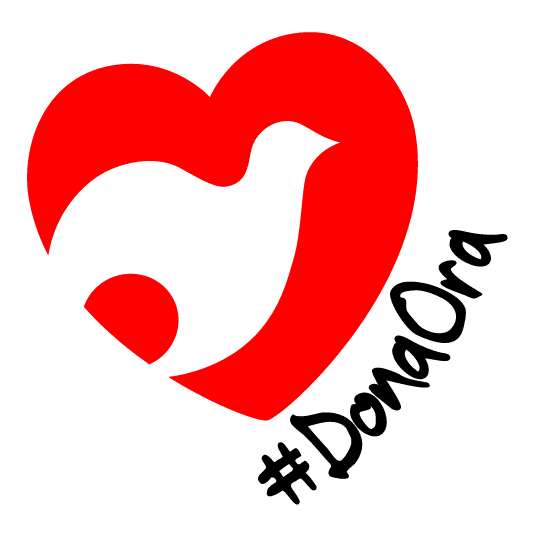Chi siamo
SPIRTO GENTIL – ARIE D’OPERA
Guida all’ascolto con cd. Relatore: Ermanno Calzolaio. Moderatore: Pier Paolo Bellini.
PIER PAOLO BELLINI:
Buonasera e benvenuti al primo incontro del ciclo che ormai ricorre negli anni, dedicato a Spirto Gentil. Abbiamo voluto proporre una serie di tre incontri che aiutino in maniera specifica e particolare ad approfondire il titolo del Meeting. “Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno?” Questi tre incontri saranno dedicati, alle arie d’opera – oggi; alle musiche del chitarrista Villa Lobos, che verranno eseguite dal vivo domenica; infine, mercoledì prossimo, ascolteremo l’Arpeggione di Schubert. Per il momento ci limitiamo a spiegare il perché della scelta delle arie d’opera. La domanda del titolo del Meeting è po’ paradossale: essere pieni di una mancanza. Non so se Luzi avesse in mente anche una famosissima poesia di Lagerkvist che dice: “Chi sei tu che riempi il mio cuore della tua assenza?” Questi versi descrivono la struttura umana come una mancanza da riempire e la percezione, la nostalgia di qualcosa che deve riempire questa mancanza. Proprio perché parliamo di una collana di cd immaginata e diretta da don Luigi Giussani, vorremmo partire dall’ipotesi che quella mancanza sia intuibile in maniera particolarmente efficace e intensa, attraverso l’esperienza della bellezza. Oggi sentiremo degli esempi molto convincenti. La bellezza come il riverbero di ciò che veramente manca è una dimensione intuita da tutti i grandi poeti. Leopardi è straordinario in questa capacità. Io vorrei partire da un suggerimento all’inizio dell’esperienza artistica, estetica e anche religiosa di don Giussani, legata in maniera strana a un’intuizione nata proprio durante l’ascolto dell’aria d’opera da cui poi ha preso il nome tutta la collana, Spirto Gentil. Era giovanissimo, forse neanche 10 anni: “Quando il bravissimo tenore [parla di Tito Schipa, che ascolteremo anche questa sera] intonò “Spirto gentil, ne’ sogni miei…”, al vibrare della primissima nota io ho intuito, con struggimento, che quello che si chiama “Dio” – vale a dire il destino inevitabile per cui un uomo nasce – è il termine dell’esigenza di felicità, è quella felicità di cui il cuore è insopprimibile esigenza”. Teniamo questo suggerimento perché poi don Giussani aggiunge che da quel momento tutta la sua vita futura, dal punto di vista estetico e dal punto di vista religioso è cambiata, sentendo l’intensità di un canto d’amore per una donna, dove si intuisce che la risposta adeguata deve essere qualcosa di molto più grande che quella donna stessa. È la comunicazione di una Bellezza più grande che passa attraverso l’esperienza della bellezza di quella donna. Don Giussani dice che Dio deve essere la risposta a questa intuizione vertiginosa. Mi fermo qui. Passo la parola al nostro ospite. Non è un musicista, ma Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato all’Università di Macerata. Non è semplicemente un amatore – anche se ha avuto la possibilità di dare una profondità paragonabile a quella dei suoi studi universitari all’ascolto della musica lirica. Ermanno Calzolaio, oltre ad aver collaborato alla stesura del libretto del cd delle arie d’opera che oggi ascolteremo della collana Spirto Gentil, scrive per riviste specializzate tra cui L’Opera, italiana, e Operà, francese; è un uomo del mestiere. È soprattutto un amico e una persona di grande sentimento, capace di condurci nella profondità umana che ci testimonierà la musica di oggi. Lo ringrazio e gli lascio la parola.
ERMANNO CALZOLAIO:
Ringrazio Pier Paolo e ringrazio tutti voi, perché ci vuole coraggio a venire alle sette di sera ad ascoltare le arie d’opera, quindi insomma complimenti per questo coraggio. Stasera vorrei introdurvi all’ascolto di alcune arie d’opera, in particolare della romanza che dà il titolo a tutta la collana, Spirto Gentil. Io non sono un esperto, perché nella vita faccio altro, ma sono da sempre un appassionato di opera lirica. Vorrei partire proprio da qui, perché ascolto questa famosa romanza praticamente da sempre, e da buon melomane ho sempre apprezzato la sua linea musicale, andavo a cercare le interpretazioni migliori, il tenore che faceva l’acuto e che lo teneva più a lungo; cercavo, insomma, quello che riusciva meglio a comunicare. Mi sono accorto che io guardavo questa romanza, come tutta l’opera e come poi tutta la vita, secondo degli stereotipi. In quel caso era lo stereotipo del melomane. Non so se voi avete mai conosciuto il melomane-tipo, che è quello che va all’opera per stare lì e guardare se il cantante becca la nota giusta, se stona, se la tiene più a lungo. Mi sono accorto che questo stereotipo non aiuta a cogliere la realtà, a cogliere la bellezza di quello che uno ha davanti. Me ne sono accorto quando mi sono imbattuto nella lettura che ne ha fatto Giussani: mi ha veramente suscitato un colpo, paragonabile al colpo che ho avuto stamattina leggendo il messaggio che il Papa ha inviato attraverso Parolin al Meeting. Non posso non partire da qui perché Giussani, ascoltando questo brano in prima liceo, a 14 anni o forse prima, ha capito che cosa era l’esistenza di Dio. Dice: “Ho capito in quell’istante che cos’era l’esistenza di Dio. Ero in prima liceo classico, in seminario e facevamo lezione di canto. Normalmente per il primo quarto d’ora il Professore spiegava storia della musica, facendoci anche ascoltare alcuni dischi. Anche quel giorno si fece silenzio; incominciò a girare il disco a 78 giri e improvvisamente si udì il canto di un tenore allora famosissimo, con una voce potente e piena di vibrazioni, quando ha cominciato a cantare un’area del quarto atto della Favorita di Donizetti. Dalla prima nota a me è venuto un brivido. Fu per me quel primo istante il brivido in cui ebbi la percezione di quello struggimento ultimo che definisce il cuore dell’uomo quando non è distratto da vanità che si bruciano in pochi istanti”. Che impressione rileggerlo adesso per la centesima volta! Mi fa rivivere quell’esperienza che cercavo di descrivere prima, perché mi accorgo che mentre guardo la realtà, vedo delle cose ma non le vedo veramente, non vedo niente. La sorpresa più grande, invece, è accorgersi che tutta la mia vita, appesantita e sofferente, grida questo desiderio di felicità. È per questo che a Giussani questa romanza parlava, mentre a me (e credo a tanti) non parla così come parla a lui. Per questo citavo prima il messaggio del papa, in quanto è partito dicendo: “Nessuno di noi può iniziare un dialogo su Dio, se non riusciamo ad alimentare il lumino fumigante che arde nel cuore”. Questo lumino fumigante che arde nel cuore è quello che io sfido voi di accendere, di tener vivo, perché noi cercheremo di ascoltare queste aree e queste aree ci diranno qualcosa se le paragoniamo con quello che desideriamo noi con la profondità della nostra vita. Mi permetterete di ricordare due righe di Julián Carrón: “L’uomo contemporaneo, cioè ciascuno di noi, sembra diventato straniero a se stesso; niente è meno evidente del contenuto della parola ‘io’, delle sue dimensioni essenziali e questo è il grande dramma: non c’è più un evidenza reale se non la moda”. Questa in fondo mi sembra la sfida del Meeting di quest’anno: di che cosa è mancanza questa mancanza che impercettibilmente ma prepotentemente uno la sente al mattino quando si alza e la sera quando va a letto, nella tristezza o nella noia che ti assale durante la giornata? Questa è una risorsa e per me è stato il colpo più grande della vita; che Giussani l’abbia presentito ascoltando una romanza d’opera mi ha sfidato, non solo nell’ascolto della musica ma nella vita. Allora cercheremo di avvicinarci nell’ascolto di alcuni brani con questo spirito. Io cercherò semplicemente di aiutare a entrarci dentro. Il primo brano è lo Spirto Gentil di Donizetti. Cerco di immedesimarmi con chi magari conosce già l’opera o con chi ascolta una romanza d’opera da neofita. Tante volte la difficoltà che si percepisce quando si ascolta un’opera è il non capire quello che il cantante dice. Occorre, come in tutto nella vita, un’educazione, un aiuto. Il mio è un umilissimo tentativo di aiuto per cercare di sintonizzarci su questa linea d’onda. Mi perdonerete se ricordo in due parole chi è l’uomo che ha scritto l’opera dove c’è questa romanza così bella. Gaetano Donizetti a mio parere è il più grande compositore d’opera che abbiamo conosciuto in Italia. Vive nella prima metà dell’Ottocento, è un bergamasco. Nasce nel 1797, muore nel 1848. La sua è una storia personale molto travagliata: era un grandissimo compositore, componeva molto per vivere. Era richiesto; riadattava, rimescolava, riprendeva un pezzo, una romanza. La cosa interessante è infatti che la romanza che riascolteremo non è de La Favorita: l’aveva scritta per un’altra opera che però non era riuscito a rappresentare, e quindi l’ha trasportata ne La Favorita. Queste cose erano molto frequenti all’epoca. Al colmo del successo, sul finire degli anni Trenta, sposa una donna, Virginia, che lui amerà tantissimo. Virginia partorisce un bambino che però morirà a soli dodici giorni dalla nascita; muore anche una figlia di lì a poco. Virginia stessa muore a ventotto anni, tanto che lui scriverà: “Senza padre, senza madre, senza moglie, senza figli. Per chi lavoro dunque? Tutto. Tutto ho perduto». Sentiva la sua drammaticità. Ha avuto una vita avventurosa. Poco dopo questi fatti si trasferirà a Parigi perché Parigi era la capitale dell’epoca. Affermarsi a Parigi era molto importante. Era molto richiesto e molto criticato. I grandi critici dell’epoca, come Berdiot, scrivevano cose terribili su di lui: che era un maneggione, che allestiva tre opere diverse in tre teatri a Parigi per colonizzarla. Era quindi anche molto osteggiato. Allestisce La Favorita in francese; questa romanza non è stata quindi scritta in italiano ma siccome l’italiano è la lingua franca dell’opera, venne tradotta e da lì si è affermata. Fu allestita trionfalmente all’Opéra di Parigi. Per dirvi che Donizetti è un uomo vero, in ogni opera c’è personaggio maschile, il tenore, che ha grande profondità. Lo troveremo anche nell’ultimo brano che ascolteremo. Era anche un tipo avventuroso: muore in circostanze tristissime perché contrae la sifilide, e pare che anche la moglie fosse morta di sifilide. Lo riterranno pazzo, lo interneranno in un manicomio, lo separeranno dai familiari. Una storia molto sofferta. Per cercare di entrare dentro La Favorita vorrei raccontarvi brevemente la storia, perché il personaggio che la canta è un tipo che ha vissuto e sofferto profondamente. Fernando è un novizio del seminario di Compostela, che vede una fervente, Leonora, una bella donna, che si reca a pregare. Comincia a parlarci, la conosce e se ne innamora follemente. Va a parlare con il priore e gli dice: “Lascio il convento”. Nonostante il priore gli dica: “Cosa fai? Sei folle, è un’infatuazione, una cosa passeggera”, lui segue questo incontro decisivo per la sua vita e abbandona il convento. Essendo nel XIV secolo, in tempi di guerra, combatterà per il suo re, Alfonso IX. Gli salva la vita e quindi il re lo vuole ricompensare; gli viene proposto di sposare Leonora e lui, chiaramente molto contento, accetta. Ma lei declina in tutti i modi questo invito. Il re si impone, vuole favorire queste nozze, perché in quel giorno il re era stato raggiunto da una scomunica papale dovuta al fatto che Alfonso voleva ripudiare sua moglie perché si era invaghito di una donna. E chi era questa donna, la sua favorita? Leonora. Fernando viene a sapere questa notizia in pubblico: arriva il padre superiore e dice: “Ma che fai? Tu non sai chi è questa. È la favorita del re”. Quel presentimento di felicità, tutto quello che lui aveva seguito fino a combattere in guerra, a lasciare tutto, perché aveva intravisto quel compimento, in un minuto crolla. Per questo, nel quarto atto ritorna in convento. Lo fa con uno spirito molto triste. Cerchiamo di immedesimarci in quest’uomo, che avendo presentito il suo desiderio di felicità lo vede crollare, e dentro la sua stanza pensa a questo spirito gentile, che nei suoi sogni era brillato. Un presentimento di felicità che si è perduto. La scrittura musicale di questa aria è semplicissima: sono quattro note discendenti, quasi una banalità. Eppure Donizetti riesce a rendere lo struggimento. Quando riprende la romanza vi accorgerete che c’è una variazione nell’accompagnamento. Ci sono degli archi pizzicati, che esprimono il turbamento. L’oggetto della felicità è perduto ma quella mancanza è gridata come oggetto presente, e non assente. Per questo mi sembra che questa romanza ci possa aiutare ad entrare dentro la tematica del Meeting di quest’anno. La scelta che avevamo fatto nel cd era quella di raccogliere i cantanti che Giussani aveva potuto sentire. Nel testo del libretto del cd, Giussani parla di Tito Schipa come l’esecutore di questa aria. In realtà accurate ricerche hanno portato a dire che non si trova il nastro di questa romanza cantata da Tito Schipa. Nel cd è stata perciò proposta quella di Enrico Caruso, che comunque rende bene lo struggimento di cui parla Giussani. È però un’incisione di oltre un secolo fa, fatta con mezzi di fortuna per l’epoca. Non è un suono limpido, ma non lasciamoci fuorviare. Cogliamo la purezza del canto di Caruso.
Musica
Cito dal libretto: “In quella prima liceo in quel timbro di voce avevo percepito il brivido di qualche cosa che mancava, non al canto bellissimo della romanza di Donizetti, ma alla mia vita, c’era qualcosa che mancava e che non avrebbe trovato poggio, compiutezza, risposta, soddisfazione da nessuna parte. Eppure il cuore esige una risposta non vive che per essa”.
Il secondo brano che ascoltiamo è una sorpresa perché non è tratto dal cd, ma da un’opera di Bellini, che era un compositore coevo a Donizetti, morto molto più giovane. Il brano che vi vorrei proporre mi sembra che descriva proprio l’esperienza che Giussani racconta. Il cuore esige una risposta, per cui tutto parla di questa risposta. L’opera si intitola I Capuleti e i Montecchi, la storia di Romeo e Giulietta. Il momento che ascoltiamo fotografa Giulietta da sola, vestita con l’abito nuziale e destinata a sposare un altro e non il suo Romeo. Giulietta canta: “l’alba mi sembra un raggio del tuo viso l’aria che spira intorno mi sembra un tuo sospir, tutto mi parla di te”. Ascoltiamo.
Musica
Cito dal libretto: “Il successivo sviluppo della mia coscienza religiosa è stato influenzato da quella esperienza che ebbi in prima liceo. Quel primo impatto fu la comunicazione di un brivido inevitabile che rese vero il mio soggetto nell’istante, cioè il mio io, la mia persona come sete di felicità pur nell’incerta risposta, anzi nella risposta incapace di sostenersi se tratta solo dalla carne”. E sotto la luce di questo primo impatto che accadde a Giussani, tutto, racconta, “si è colorato di analogia, con il rapporto colorato e grande che ebbi con mio padre”. Per questo, il brano che ho scelto adesso è utile anche per capire che l’opera non è solo una cosa pesante come può apparire; ci sono anche opere molto divertenti, tra cui senza dubbio Il barbiere di Siviglia di Rossini. E Giussani racconta in un suo testo che il padre, quando le situazioni in casa diventavano tempestose, era solito sdrammatizzare citava un brano di un’opera, o La donna è mobile, oppure, diceva “Donne, donne, eterni dei, chi vi arriva a indovinar?”. O donne, ma chi vi capisce? Questo verso è tratto dal duetto tra Rosina e Figaro ne Il barbiere di Siviglia. La storia parla di Rosina affidata alle cure di un tutore arcigno, Bartolo, che voleva semplicemente sposarla per impossessarsi delle sue ricchezze. Ma sotto la sua finestra, il conte di Almaviva, che si faceva chiamare Lindoro ed era vestito da giovane povero, le canta una serenata e chiede al suo amico Figaro, il barbiere che aveva accesso alle stanze della casa dove Rosina era rinchiusa, di fare da intermediario. Il dialogo tra Rosina e Figaro si svolge così: “Io sono Figaro, tu mi conosci, qui c’è Lindoro, che ti vorrebbe parlare però, poverino, lui aspetta un cenno del vostro affetto, se questo giovane non vi è indifferente insomma fate qualcosa”. “E io, no, non potrei non conviene, non si deve fare”. “Ma su non ti preoccupare, ma buttati, no?” “Ma per esempio cosa potrei fare?”. “Per esempio, scrivigli un biglietto, scrivigli due righe”. “Ah, un biglietto! Eccolo”. E allora Figaro dice: “Io il maestro faccio a lei”, e pronuncia quella famosa frase “Donne, donne eterni dei, chi vi arriva a indovinar?”
Musica
Abbiamo solo altri due brani. Il primo è una preghiera – ritorniamo al repertorio del cd Spirito Gentil – tratta dall’Otello di Verdi, l’Ave Maria cantata da Desdemona. Otello è il moro di Venezia che a Cipro sposa Desdemona che è una dolcissima donna innamoratissima ma poi con le trame di Iago, Otello si ingelosisce. Desdemona capisce che si è rotto qualcosa dopo l’idillio della prima notte di nozze, capisce che si è insinuato un tarlo. Lei è innocente ma non riesce a dimostrarlo all’uomo a cui aveva dato tutto. È sola, in attesa che Otello la raggiunga in camera, come sappiamo per ucciderla, ed è piena di presentimenti. In preda a questi presentimenti decide di pregare, ed è interessante perché nella prima parte la preghiera viene quasi recitata: “Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose e le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, o benedetta, di tue materne viscere, Gesù”. Non sembra neanche cantata, come se lei fosse distratta, per dire che c’è qualcos’altro a preoccuparla. Il canto vero e proprio inizia sulla parola “prega”: “prega per chi adorando a te si prostra, prega pel peccator, per l’innocente, e pel debole oppresso e pel possente, misero anch’esso, tua pietà dimostra. Prega per chi sotto l’oltraggio piega la fronte e sotto la malvagia sorte; prega per noi, per noi tu prega”… E poi Desdemona si raccoglie in preghiera, per cui dice: “Ave Maria” e poi tace. La musica lascia pensare che stia recitano nel suo cuore la preghiera, fino a riprendere alla fine con il grido: “Ave”, che ascende verso l’acuto in modo un po’ vertiginoso. Ci lascia sospesi fino a quando c’è l’”Amen” conclusivo su due note centrali che esprimono certezza. Dalla domanda che lascia quasi sospesi, che sembra quasi un grido incerto, Verdi conclude in un modo che imprime la certezza da lei raggiunta.
Musica
Ci ha scritto il papa che la vita non è un desiderio assurdo. La mancanza non è il segno che siamo nati sbagliati ma, al contrario, è il campanello che ci avverte che la nostra natura è fatta per cose grandi. E quando uno si accorge di questo a me sembra che niente come la romanza di Nemorino tratta da L’Elisir d’amore di Donizetti possa documentare che cosa accade quando non si mette a tacere il proprio cuore, ma si comincia a guardarlo come una risorsa. Racconto brevemente la storia de L’elisir d’amore. È la storia di uno scemo del villaggio che si chiama Nemorino, che è innamoratissimo di Adina, che invece è istruita. Sa leggere, ma in questo villaggio di contadini semplici è veramente una che ha studiato! Lui è attratto dal fatto che lei sa leggere, che è bella, che capisce tutto, invece lui dice: “Io sono sempre un idiota, non so che sospirare, non so fare niente”. Dopo una serie di vicissitudini, arriva un sergente d’istanza in quelle zone che fa il gradasso, e Adina gli promette che lo avrebbe sposato. Nemorino comincia a preoccuparsi; arriva un ciarlatano che vende del vino di Bordeaux spacciandolo come un elisir che guariva ogni male! Nemorino è incuriosito e chiede se tale prodigiosa bevanda possa anche far innamorare. Il mercante ovviamente risponde che l’elisir funzionava anche in quel senso, ma che ne occorreva di più e quindi se ne doveva comprare una quantità maggiore. Nemorino però non ha i soldi e per pagare i vino si fa arruolare come soldato e, ricevendo un anticipo in denaro, può pagare. Un grande tormento, fino a quando capisce che Adina non è interessata a lui. Anzi, il matrimonio col sergente viene anticipato il giorno stesso. Quel giorno però accade un fatto strano. Nel villaggio si comincia a mormorare che Nemorino ha ereditato una grossa somma da uno zio morto, e quindi è diventato improvvisamente un buon partito. Tutte le donne gli si fanno incontro e lui pensa che il merito sia dell’elisir! In quel momento arriva Adina: è colpita dal fatto che tutte le donne del villaggio circondano Nemorino, perché lei in realtà, sotto sotto, era affascinata da Nemorino. E quindi le sfugge una lacrima; lui da lontano scorge quella “furtiva lacrima”: “Una furtiva lacrima dagli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidiar sembrò”. Nemorino non ha più niente da cercare, “M’ama!”. Da questo piccolo indizio, la realtà comincia veramente a parlare. Da questo piccolo indizio lui capisce che lei lo ama. “Poter sentire solo un istante i palpiti del suo bel cuore, poter confondere, per poco anche, i miei sospiri con i suoi sospiri, sentire i palpiti, confondere i miei con i suoi sospiri. Si può morire? Non chiedo di più”. Quest’aria nella sua semplicità è impressionante perché non c’è niente come il rapporto affettivo che documenti quello a cui ci stiamo introducendo. Adesso la ascoltiamo cantata nella più bella versione che esista. Quest’aria in genere è cantata in modo molto sguaiato, il tenore coglie l’occasione per fare sfoggio di sé. Qui è cantata da Tito Schipa. “Una furtiva lacrima” è rimasta incisa e conservata in un momento d’oro della sua voce. Lui cesella ogni frase, si immedesima nella semplicità del personaggi e ci fa capire che per Donizetti il bambino, il semplice, non è uno stupido, ma colui che ha capito tutto, che non ha niente e per questo può solo domandare tutto. Niente come quest’aria esprime tutto questo.
Musica
Cito Giussani: “Nella musica, nel panorama della natura, nel sogno notturno, come scrive nel suo “Canto notturno” Leopardi, è a qualcosa d’altro che l’uomo rende il suo omaggio, da cui aspetta, lo aspetta. Il suo entusiasmo è per qualcosa che la musica, con tutto ciò che è bello al mondo, ha destato dentro. Quando l’uomo presente questo, immediatamente piega l’animo ad attendere l’altra cosa. Anche davanti a ciò che può afferrare, attende un’altra cosa. Afferra ciò che può afferrare, ma attende un’altra cosa”. Grazie.
PIER PAOLO BELLINI:
Nel ringraziare il professor Calzolaio, non posso fare altro che riconoscere con meraviglia come il cuore sia qualcosa di universale e di eterno, che ci permette di attraversare i secoli, di attraversare gli Stati. Forse l’italiano è studiato nel mondo, fino in Cina e in Giappone, per la lirica, perché dice qualcosa che è proprio di chiunque. Io vi ricordo solo che vorremmo approfondire ulteriormente, il nostro percorso, proponendo un ascolto di musiche che raccontano la nostalgia della bellezza intravista, come segno dell’assoluto. Il prossimo appuntamento sarà domenica, con le musiche di Villa Lobos eseguite dal vivo, con la possibilità, quindi, di ascoltare Piero Bonaguri che ci introdurrà ai pezzi. Vi ringrazio per l’attenzione. Grazie e arrivederci a domenica.