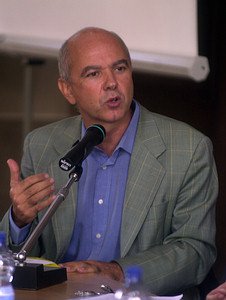Chi siamo
NEUROSCIENZE: IL MISTERO DELL’UNITÀ DELL’IO
Partecipano: Giancarlo Cesana, Docente di Igiene all’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Michele Di Francesco, Preside della Facoltà di Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Introduce Andrea Moro, Docente di Linguistica Generale presso la Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale IUSS di Pavia.
NEUROSCIENZE: IL MISTERO DELL’UNITÀ DELL’IO
Ore: 11.15 Salone B7
ANDREA MORO:
Buongiorno a tutti, benvenuti. Mi trovo nella situazione, per me non insolita, di dover presentare persone che non hanno alcun bisogno di essere presentate, casomai varrebbe il viceversa.
Abbiamo con noi Giancarlo Cesana, Presidente della Fondazione Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano. Il suo ruolo nella storia del Movimento è chiaro e noto a tutti, così come è chiaro e noto a tutti il suo contributo scientifico. In questa discussione di oggi, in questa giornata, il contributo che ci darà il Prof. Cesana sarà sostanzialmente centrato sugli studi che lui ha fatto della relazione tra fattori sociali e malattia. Di queste cose ne ha parlato in un libro, che a me ha affascinato, che si intitola Il Ministero della Salute, che ha ben poco di ministeriale e di burocratico. In realtà ci sono delle pagine luminose che fanno vedere come nella storia dell’assistenza al malato il cristianesimo abbia un ruolo centrale, un ruolo senza il quale noi non concepiremmo probabilmente nemmeno l’ospedale in senso moderno.
Abbiamo poi con noi Michele Di Francesco, Professore Ordinario di Logica e Filosofia della Scienza e Preside della Facoltà dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Presidente uscente della Società di Filosofia Analitica Europea. Si è occupato anche lui di filosofia della mente, dell’io, ha scritto un libro che si chiama L’Io e i suoi sé, tanto per giocare immediatamente con le parole e mettermi in crisi. Uscirà tra poco un suo libro, La mente estesa, dove affronterà alcuni temi che tratteremo oggi insieme.
Il mio ruolo qui è fare da evidenziatore, come i pennarelli giallini che si usano per mettere in luce le cose, e spero di non sbavare nel senso che certe volte, sapete, gli evidenziatori si usano troppo e alla fine non sai più che cosa andava evidenziato. Il primo punto che vorrei discutere con voi, che poi giudicherete se ce l’ho fatta o meno a mettere in luce le cose nel modo giusto, è capire che, quando si parla del mistero dell’unità dell’io, c’è un mistero e questo non è affatto ovvio. Il punto è che tutte le volte che noi vediamo una cosa in qualche modo unitaria, che riconosciamo fatta di parti ma non sappiamo spiegare come mai le parti stanno insieme, si presenta il mistero di quella unità. I fisici lo sanno bene, conoscono le particelle, ma poi quando si tratta di capire come le particelle stanno insieme non sanno, non c’è una teoria completa che riesca a descrivere questo collante magico che tiene insieme appunto le particelle. Una cosa simile accade proprio con l’io. Io è un pronome che noi utilizziamo e sappiamo benissimo identificare le parti che lo compongono. Quando parliamo di io, pensiamo ai nostri affetti, alla nostra dignità, alla nostra unicità, alla nostra tensione verso la libertà, alle nostre sensazioni. Solo che se pensiamo come tutti questi elementi si tengono insieme, ci troviamo sperduti. Addirittura i neurofisiologi e i neuropsicologi sanno che non è facile capire come le sensazioni uditive e quelle visive si mettano insieme nel cervello per raggiungere una percezione unica.
Beh, potreste dire: forse l’incontro di oggi sarà noiosissimo, filosofico, troppo arduo, perché è un incontro per neurologi, filosofi, teologi. Sarebbe tutto vero se non fosse che “io” ha una caratteristica particolare, è una delle prime parole che pronunciano i bambini e non solo: il sistema pronominale nasce e fiorisce nella testa di un bambino secondo una sequenza particolare tutt’altro che scontata. “Io” compare come primo elemento e quasi subito dopo compare “tu”, a grande distanza compaiono i pronomi di terza persona. In certo qual modo è come se la nostra coscienza anticipasse, a livello linguistico, il problema dell’unità dell’io, dandoci questa sensazione miracolosa di qualche cosa che noi percepiamo come integro, ma che integro non è. Carlo Emilio Gadda, quando parlava dei pronomi, li chiamava i pidocchi del pensiero. Non so se avesse ragione o meno, ma sta di fatto che questi sono testimoni rivelatori sorprendenti dell’anticipo, appunto, con cui la coscienza dei bambini coglie immediatamente questo fatto. Allora come si fa per indagare gli elementi che compongono queste sottoparti dell’io? Bisogna procedere razionalmente come siamo abituati a fare da sempre ed esistono almeno due vie maestre, che sono poi proprio rappresentate dagli studiosi che oggi interverranno. Da una parte noi dobbiamo in qualche modo vivisezionare l’io, dobbiamo chiederci quali sono le sue proprietà fondamentali. Ce n’è una tra tutte che il Prof. Di Francesco ha esplorato, che è sorprendente, è una domanda che sembra quasi banale ed è questa: dove sta l’io?
Si dice: “Beh, sta nel cervello”. E’ vero? Siamo così sicuri che possa essere localizzato nel cervello o in un punto del cervello? Vedete, questo problema sembrerebbe banale se non fosse che c’è un contrasto impressionante tra due fatti, che noi non possiamo disconoscere: da una parte, l’io è in grado di riconoscere l’infinito e di utilizzarlo, anzi, se andiamo a guardare le strutture delle lingue umane, e solo umane, noi sappiamo che le nostre lingue fanno un uso infinito di mezzi finiti. Lo si sapeva dal ’800 e oggi, con la matematica moderna, possiamo anche manipolare queste cose. Dunque, da una parte abbiamo un io che riconosce l’infinito, ma sappiamo che viene da noi che siamo finiti, siamo finiti perché siamo organismi finiti innanzitutto. Dunque il primo problema è un problema di contrasto, tra il riconoscere l’infinito generato in qualche modo da qualcosa che, in realtà, infinito non è; e poi c’è un’altra strada da percorrere, una strada alternativa, radicalmente alternativa, che è la strada di vedere come funziona una cosa quando si danneggiano le sue parti. Il problema, quindi, è immaginare di capire, di approfondire il mistero dell’unità dell’io, vedendo cosa succede quando l’io si guasta. E’ di fronte alla dissoluzione dell’io che, tra l’altro, come facevi notare nello scritto, nel libro di cui parlavo, che, in modo ancor più ineluttabile e drammatico, il paziente, il malato reclama un senso radicale, totale, ancora di più di quando si ammala un pezzo del corpo, se si ammala l’io. E dunque questa richiesta di senso può essere anche un indicatore notevole per farci capire cosa intendiamo noi come mistero dell’unità dell’io. E a tutti deve essere ormai chiaro che chiedersi qualche cosa sull’io, in fondo, è chiedersi qualche cosa sulle nostre origini. Sembrerebbe con questa frase di sigillare, di chiudere, di accantonare il problema, dire “beh…il problema dell’io è un problema di origini”, se non fosse che delegare alla nozione di origine il problema dell’io è cadere non dalla padella nella brace ma almeno dalla padella nella padella, nel senso che ci troviamo di fronte a un problema ancora più complesso. Mi piace ricordare una citazione da uno dei testi più importanti della letteratura di tutti i tempi. Sofocle fa dire a Edipo nella prima tragedia della Trilogia questa frase: “Accada quel che deve accadere. Io voglio vedere il seme da cui provengo, anche se è umile. Sono stato generato così, non potrei diventare altro, dunque voglio andare fino in fondo nel conoscere la mia origine”. E’ davvero un peccato che la maggior parte delle traduzioni, sia italiane che straniere, appiattiscano due termini che Sofocle usa, e che sono “il seme” e “l’origine”, e di solito vien tradotto in tutt’e due i casi con “origine”. E’ un peccato, perché è chiaro che quando noi parliamo della nostra origine, parliamo di due cose: dell’origine nostra, individuale, della nostra carne, di come siamo fatti noi oggi, della nostra fisionomia, e invece della catena di “io” che ci hanno preceduti, cioè la nostra stirpe. E son due problemi di origine diversi. Ed è ovvio che, nel secondo caso, il problema dell’io non si può sganciare dal problema del tu, perché riconoscere l’appartenenza è riconoscere un tu, anzi una catena di tu. Dunque il mistero dell’unità dell’io è, per così dire, un mistero almeno doppio, ed è il mistero della mia origine materiale e genealogica. Forse Gadda, che come tutti i grandi era pieno di contraddizioni, non s’è accorto che invece di un pidocchio l’io era diventato per lui il sinonimo della vita stessa, se praticamente in chiusura de La cognizione del dolore, quando parla della morte della madre, scrive questa cosa: “Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo recupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana incoscienza dell’impossibilità di dire io”. Ecco, capire il significato del nome dell’”io” ci rende, in qualche modo, disponibili a dare il senso vero al nome del “tu” e all’origine della vita stessa.
Ed ora do prima la parola al Prof. Di Francesco e poi al Prof. Cesana, che certamente ci illumineranno col loro parere su questo problema. Grazie.
MICHELE DI FRANCESCO:
Bene. Grazie, buongiorno a tutti, una sola parola brevissima per ringraziare per questo invito. E’ la prima volta che partecipo a questo Meeting e sono colpito e doverosamente impressionato sia dalla quantità di gente in sala ma anche dall’atmosfera, che mi sembra un’atmosfera di genuina ricerca, diciamo, della verità forse è una parola grossa, ma, insomma, della comprensione dei problemi, e penso che questo tema che è stato scelto per questa mattina effettivamente pone un problema molto difficile, molto interessante. E’ stato molto bene illustrato da Andrea Moro. E’ stato detto più volte che la filosofia occidentale non è altro che una glossa a Platone e, facendo le debite proporzioni, la mia relazione sarà una glossa a Moro, per cui alla fine spero di riuscire a seguire questo sentiero, perché effettivamente ci sono alcune cose da chiarire preliminarmente.
Per esempio, una cosa importante è che lo sviluppo delle neuroscienze contemporanee ha dato vita ad una grande rivoluzione, una rivoluzione il cui impatto forse non è ancora ben assimilato, cioè una rivoluzione a mio parere paragonabile a quella galileiana e post galileiana. Come l’universo fisico è stato indagato con metodi, con strumenti, con idee, concetti che erano profondamente diversi da quelli utilizzati in precedenza, analogamente l’universo mentale, negli ultimi decenni, è studiato, analizzato e approfondito in maniera altrettanto innovativa. Questo, chiaramente, per chiunque voglia pensare, filosofo, teologo ma anche uomo comune, è una grande sfida. Ricordiamoci quanto è cambiata l’immagine del mondo dalla scienza fisica del ’600 ad oggi: bene, dobbiamo aspettarci forse che, anche per quanto riguarda le scienze della mente i cambiamenti saranno, già adesso e soprattutto nel futuro, altrettanto rilevanti. Questa è una grande sfida intellettuale. E alcuni cambiamenti forse possono passare inosservati, hanno a che fare con cose fondamentali per tutti, la ricerca clinica, la linguistica, la psicologia sperimentale; altri toccano la vita di tutti noi. E il tema dell’io, dell’unità della mente, della persona, della soggettività è un tema di questo tipo.
Noi siamo abituati a pensare a noi stessi, in maniera intuitiva, come a delle entità continue nel tempo, unitarie, tutto sommato bene integrate, e però impariamo e stiamo imparando sempre di più che siamo il prodotto di processi che invece sono discontinui, che non sono integrati, che sono addirittura specializzati e che, con un’espressione tecnica, che però oramai è molto usata, sono di natura sub-personale, cioè avvengono a un livello sottostante a quella che è la conoscenza che le persone hanno della propria mente. Ora, come fanno le persone a venir fuori da qualcosa di sub-personale? Come fa tutto quello che per noi ha senso a originarsi da questo tipo di livello? Fino a che punto questo è compatibile con il nostro modo di vedere? Ma non solo la scienza, la neuroscienza, la psicologia, ma anche il diritto si basa sull’idea di responsabilità, la società si basa sulla promessa, il denaro non è altro che una promessa istituzionalizzata, e la promessa, e qualunque tipo di attività, presuppone che io sarò lì a mantenere la mia promessa. Ma “io” chi?
Come potete vedere è qualcosa che si estende dal campo dello specialismo alla vita di tutti noi. Allora la questione che vorrei, appunto, presentarvi è come si arriva a questa sfida e in che modo la nostra immagine intuitiva di noi stessi può sopravvivere, o addirittura essere, volendo, anche confermata o no dagli sviluppi della ricerca scientifica sulla mente.
Un punto di partenza importante – andrò per flash, naturalmente, perché il tempo è quello che è – è un aspetto essenziale, che conferma già delle intuizioni che erano già state presentate nell’ambito della letteratura, dell’arte, e quindi in vari settori, cioè un ridimensionamento drastico, quasi drammatico, del peso della coscienza, nel senso della consapevolezza, dell’autoconsapevolezza nell’ambito della mente. La coscienza per la scienza della mente contemporanea è la punta di un iceberg; sotto la coscienza esiste una miriade di processi che non sono coscienti ma sono essenziali perché la nostra mente sia quello che è. Una volta chiarito questo fatto, certi fenomeni anche quotidiani ci diventano più significativi. Faccio due o tre esempi per cercare di non essere troppo astratto. Pensate a quando si guida discutendo un po’ animatamente: noi guidiamo, magari a un certo punto superiamo un incrocio dove avremmo voluto girare, ci rendiamo conto dopo un po’ che l’abbiamo superato e torniamo indietro. Un fenomeno normalissimo. Com’è possibile però che non siamo stati consapevoli dell’incrocio e non ci siamo schiantati contro un albero, contro le altre auto? In realtà noi, in qualche maniera, avevamo una qualche forma di controllo della nostra azione, ma non era una piena consapevolezza. E questo è un fenomeno quotidiano, ma lo stesso fenomeno, se cambiamo il background, se cambiamo la cornice, assume un peso teorico diverso: quello che era una curiosità diventa un problema.
Altri piccoli esempi, due ve ne do, e poi finisco. Salite sulle scale mobili: normalmente si sale sulle scale mobili e basta; immaginate che la scala mobile non funzioni. Avete quella curiosa sensazione che c’è qualcosa che non va, i vostri muscoli non sono pronti per la sensazione di immobilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi normalmente abbiamo già predisposto degli schemi motori che ci devono far muovere sulla scala mobile, che non sono gli stessi che noi utilizziamo se saliamo su delle scale normali, che non sono gli stessi che utilizziamo se camminiamo sulla sabbia, e così via. Ma questi schemi vengono attivati inconsciamente, tanto è vero che siamo sorpresi quando le cose non vanno. Non è la mia consapevolezza che guida questi atteggiamenti, è tutto un lavorio importantissimo che avviene in maniera, appunto, non accessibile alla mia autoconsapevolezza.
Ultimo esempio – almeno, questo è un esempio forse più personale, ma forse sarà capitato a qualcuno di voi – quella sensazione di totale vuoto mentale che vi succede, o che a me succede: apro il frigorifero e…”cosa stavo facendo, che cosa stavo cercando?” E’ come se mi svegliassi da un sogno. In un certo senso è così, nel senso che io stavo facendo qualcosa, magari stavo pensando alla lezione che devo preparare per domani, però ho anche sete, vado al frigorifero, apro e a quel punto qualcosa si interrompe in questo meccanismo automatico, forse perché il mio cervello riceve tanti stimoli – c’è il latte, la Coca-Cola, cosa voglio davvero? – e allora viene chiesto aiuto alla mia coscienza: “Cosa stavo facendo? Ah, già!”, e tiro fuori la bottiglia d’acqua.
Pensate, adesso mi fermo ma, come esercizio, vedo che ci sono anche molti giovani in sala, pensate a tanti casi di questo tipo: provo a infilare le chiavi, non succede… afferro il cartone del latte che penso che sia pieno e invece è vuoto e lo sollevo più in alto del normale perché? perché io avevo già pensato inconsciamente al peso del… potremmo andare avanti tutta la mattina.
Ridimensionamento della coscienza vuol dire che, sotto il livello della mente che noi possiamo esplorare, esiste una quantità di fenomeni che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, ma rispetto ai quali non abbiamo accesso.
Questo sembra contraddire, anzi, in realtà, contraddice, una visione tradizionale dell’io, almeno da Cartesio in poi. Cartesio, nel 1641, scrive: “Io non sono dunque, per parlar con precisione, se non una cosa che pensa”, ma per lui “una cosa che pensa” che cos’è? E’ una cosa totalmente trasparente. Per Cartesio, quando io guardo, conosco me stesso, ho la forma di conoscenza più certa che esista: è più certa la conoscenza di me stesso che la conoscenza del mondo esterno. E’ l’argomento del cogito, naturalmente.
Non solo Cartesio pone la coscienza come il centro, anzi, il confine dell’io è il confine della coscienza, lo fanno molti altri filosofi. John Locke, pochi decenni successivi, scriverà, parlando di identità personale, che “per quanto riguarda la coscienza, per tanto che questa consapevolezza può essere portata al passato, a qualunque passata azione o pensiero, fin là giunge l’identità di quella persona”. Cioè la mia identità personale arriva fin dove arriva la mia coscienza, dove finisce la mia coscienza non c’è più l’identità.
Come vedete, questo modello è un modello di un io cosciente, consapevole di sé, che si estende nel tempo finché arrivano i miei ricordi; al di là di questo esiste qualcosa che è il non-io, qualcos’altro.
Ora, questa immagine è stata messa in discussione dai filosofi, naturalmente, non è che sono state le neuroscienze per prime a porre il problema. Giusto per finire questo micro elenco di citazioni, il più noto tra coloro che hanno messo in discussione questo tipo di immagine è David Hume, grande filosofo scozzese, che, nella seconda metà del ’700, sosteneva che l’io non è altro che un fascio di percezioni, un insieme di percezioni. Lui scrive esattamente: “Noi non siamo altro che fasci o collezioni di differenti percezioni che si susseguono con inconcepibile rapidità in un continuo flusso e movimento. Non c’è nessuna semplicità in un dato momento, né identità in tempi differenti”. Qui Hume si sta contrapponendo in maniera frontale all’immagine di Locke. Noi siamo che cosa? Una “società della mente”. Questo termine non è di Hume ma è di uno dei padri dell’intelligenza artificiale, che si chiama Marvin Minsky, che scrisse questo libro La società della mente.
Allora, come vedete, l’io non c’è più: c’è una società, un Commonwealth, una repubblica, ma questo soggetto unitario sembra svanire.
Anche chi, come Kant, l’ultimo filosofo che cito di questo illustre micro gruppo di pensatori, anche Kant, quando difende l’importanza dell’unità della mente, dice una cosa molto importante, dice: “L’unità della coscienza, peraltro, è soltanto l’unità del pensiero. Mediante questa sola non viene dato alcun oggetto”. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che l’esperienza del pensiero è unitaria e integrata, ma non è esperienza dell’io di Cartesio, cioè di questa sostanza che pensa e rimane identica nel tempo. Questa noi nel pensiero non la troviamo, non riusciamo a esperire noi stessi. Quando faccio lezione, ma oggi non c’è tempo, do qualche secondo ai miei studenti per cercare di esperire se stessi, ma non i propri pensieri; “adesso sto facendo una cosa stupida che mi ha detto di fare il Prof. Di Francesco”, questo, se io guardo dentro di me, lo trovo, quello che io non trovo mai è il me stesso che sta pensando e io lo penso mentre sto pensando: questo cerchio non si chiude mai. Non è possibile trovare noi stessi in questo modo.
Allora la domanda è: e se lo trovassimo, e lo cercassimo, utilizzando, appunto, i nuovi strumenti della scienza contemporanea? Riusciamo a trovare questo io analizzando il cervello, mettendo le persone nelle macchine per la risonanza magnetica funzionale? Riusciamo a individuare, attraverso le tecnologie dello studio della mente, questo io?
E qui ci sono altrettanti problemi. I problemi sono numerosi, perché più noi aumentiamo la nostra conoscenza del funzionamento cerebrale, meno è facile trovare quello che un filosofo molto critico nei confronti dell’io, che si chiama Daniel Dennett, chiama “lo spettatore del teatro cartesiano”. La nostra mente possiamo concepirla intuitivamente, in modo sbagliato per Dennett, come un teatro: c’è questo teatro e questo teatro ha uno spettatore, l’io. Allora mettiamoci a cercarlo: non lo troviamo.
Esistono molti, molti esempi di ricerche che mostrano quanto è difficile trovare questo spettatore del teatro cartesiano. Daniel Dennett – ed è l’ultima citazione che vi infliggo – scrive, e scrive molto bene: “Nel nostro cervello c’è una aggregazione un po’ abborracciata di circuiti cerebrali, tutti specializzati, che, grazie a svariate abitudini, cospirano insieme al fine di produrre una macchina virtuale più o meno ordinata o più o meno efficiente, più o meno ben progettata”. La macchina virtuale di cui parla Dennett la chiama “la macchina joyceana”.
Questa macchina virtuale, questo software nel cervello, crea un comandante virtuale dell’equipaggio.
L’idea è molto chiara: noi abbiamo nel nostro cervello un software che produce che cosa? Un comandante virtuale. Un comandante virtuale non esiste. Lui userà anche l’espressione “un centro di gravità narrativo”. Sapete, i centri di gravità sono molto comodi per i fisici: i fisici trovano utile, per motivi anche di calcolo, postulare all’interno di un corpo un punto dove si possano applicare tutte le forze gravitazionali. Ma non è che c’è come oggetto reale, fisico, il centro di gravità: è una costruzione, una finzione teorica anche utile. Allora, secondo Dennett noi abbiamo una macchina joyceana (da James Joyce, lo “stream of consciousness”, il “flusso di coscienza”) che viene costruita nel cervello e produrrebbe questo “comandante virtuale”, apparenza però, non realtà. La realtà è un’altra.
Come facciamo a sapere se Dennett ha ragione o ha torto? Beh, alcuni studiosi di impostazione, per semplificare diciamo, riduzionistica, pensano che ci sono molti elementi in favore, per esempio rispetto al tema che è stato accennato, della libertà. Beh, rispetto al tema della libertà noi possiamo, in qualche senso, fare appello a delle ricerche che mostrano con dati di laboratorio che, quando noi prendiamo una decisione come schiacciare un bottone, piegare un dito, eccetera, il nostro cervello inizia la preparazione dell’azione – “io piego il dito”- qualche centinaio di millisecondi prima che io ne sia consapevole. Questi sono gli esperimenti di Benjamin Libet. Questi sono esperimenti che sono stati discussi, eccetera, hanno fatto sobbalzare sulla sedia delle persone perché qualcuno è giunto (frettolosamente, bisogna dire) alla conclusione “ma allora non c’è il libero arbitrio!”, perché se io, prima di essere consapevole, ho già cominciato a mettere in moto, con dei processi inconsci che è il mio cervello che sta organizzando, il movimento, allora io non c’entro nulla nella genesi del movimento. Poi, si potrebbe parlare a lungo dell’interpretazione di questi testi, ma è solo per darvi un esempio del tipo di ricerche che potrebbero mettere in discussione quest’idea, appunto, e avvalorare le tesi di un filosofo, molto bravo del resto, come Dennett: cioè che c’è questo software, questa macchina virtuale che produce un’apparenza di un io, ma l’io è soltanto…a cosa ci servirebbe? Mah, grosso modo, per scopi sociali, interazione, eccetera.
In realtà la psicologia, anche sperimentale, prima ancora delle neuroscienze, ha mostrato quanto spesso noi ci inganniamo nel giustificare le nostre azioni. Ci sono molti studi, la gente tende sempre a razionalizzare il proprio comportamento: io faccio un’azione irrazionale ma gli trovo una spiegazione razionale. Prima ancora la psicoanalisi, si possono citare i famosi “maestri del sospetto”: Marx, Freud e Nietzsche, come questa triade di detrattori dell’io.
Ma il problema è che oggi non stiamo più tanto parlando di teorie filosofiche – io sono un filosofo, le rispetto moltissimo – o di teorie psicologiche ma non pienamente sperimentali, come la psicanalisi, ma stiamo parlando di risultati di laboratorio, per cui c’è tutto il peso della scienza sperimentale, che talvolta è un peso molto ingombrante: “Questa cosa qui è stata dimostrata in laboratorio”… Sempre a lezione ricordo che la parola “dimostrata” non si può applicare alle scienze naturali. Si dimostrano i teoremi. Però l’unico ambito in cui si può tollerare un “è scientificamente dimostrato” è, non so, sulla pubblicità dei dentifrici, questo lo ammetto, “è dimostrato che in tre settimane lo smalto diventa bianco”, va bene, si sa che si sta un po’ facendo propaganda, però metterlo in articoli scientifici, parlare di dimostrazione… Però diciamo, ci sono delle prove, delle evidences, delle evidenze sperimentali che dicono: accidenti, bisogna prendere sul serio questi aspetti.
L’unità: è stato accennato, ci sono una quantità di sindromi di dissociazione della coscienza che mostrano come l’unità dell’io appare tutto meno che un qualcosa di scontato. Sono stati famosi degli studi sui cosiddetti “cervelli divisi”, gli “split brains”: i cervelli divisi sono il risultato di interventi chirurgici, che venivano fatti per affrontare casi molto severi di epilessia, veniva separato il corpo calloso, una parte che mette in contatto i due emisferi del cervello. Quello che è interessante è che in situazioni sperimentali si è visto che i due emisferi lavorano l’uno separatamente dall’altro, il che produce degli esiti anche spettacolari dal punto di vista del comportamento, perché, per esempio, l’emisfero linguistico, normalmente il sinistro, ha accesso alle informazioni e può esprimerle verbalmente, mentre l’emisfero destro, che non ha accesso alla componente linguistica, non le può esprimere verbalmente ma può indurci, per esempio, a disegnare. Quindi è come se in una persona ci fossero dei flussi di coscienza separati. E’ vero che questi sono pazienti che hanno subìto un’operazione, ma la domanda che si pone è: cosa succede in noi? Cos’ho, una mente nell’emisfero destro e una mente nell’emisfero sinistro, che poi si mettono insieme e collaborano e fanno una specie di super-mente senza che io ne sappia nulla? Perché io non ho la minima idea, prima della ricerca scientifica, di avere due emisferi che lavorano in questa maniera e vi sono tantissimi altri casi, ma il tempo corre e arrivo brevemente verso, non ad una conclusione ma, insomma, a un’impostazione di come, secondo me, andrebbe affrontata questa sfida, perché è davvero una sfida grande. Spero di essere riuscito a chiarire che, se dobbiamo rinunciare alla nostra visione di noi stessi come soggetti integrati, almeno approssimativamente integrati, effettivamente molte delle nostre, non solo intuizioni, ma delle cose che per noi hanno più importanza, più valore, finiscono anche per essere sovvertite, cambiate profondamente. Mi è piaciuta moltissimo la citazione che ha fatto Andrea Moro, quella finale da “La cognizione del dolore”: la morte come l’impossibilità di dire “io”. Sapete, in una visione disaggregata dell’io, che è fatta di tante “agenzie” sub-personali, sotto la soglia della coscienza, come tanti piccoli zombie che agiscono in noi, eccetera, la morte è come un club che si scioglie, un po’ di agenzie, ognuna se ne va per conto suo, e pazienza, non c’è veramente una perdita.
Ma per me è davvero difficile pensare, forse non tanto alla mia, ma anche alla morte delle persone care, che possa essere pensata così.
Va presa con molto rispetto quest’altra alternativa, non voglio dire che è impossibile solo perché per me è difficile pensarla, ci mancherebbe altro, ci sono anche culture al di fuori della cultura occidentale che hanno messo al centro l’idea dell’illusorietà dell’io, quindi tratto tutto ciò con molto rispetto. Però devo anche ammettere che ho un forte interesse a vedere se queste conclusioni seguono. Perché, capite, il problema di qualunque tipo di argomentazione filosofica che legge dei dati scientifici è: “Le conclusioni seguono dalle premesse?” E, a mio parere, non è così scontato che le conclusioni seguano dalle premesse, prima di tutto perché non è affatto scontato che l’io vada cercato tutto nel cervello, questo è il punto che era stato anch’esso anticipato. Perché questo? Perché esiste una neurobiologia dell’io: in questo momento ci sono un sacco di libri che vengono pubblicati sull’argomento, è un tema molto “caldo”.
Però la neurobiologia dell’io tocca un aspetto dell’io, quella componente dell’io che, appunto, viene prodotta dal cervello, che fa parta di quella dotazione naturale che ci serve per affrontare il mondo. Noi siamo un organismo complicato e, anche soltanto per camminare, dobbiamo coordinare, mettere avanti prima un piede e poi l’altro, e quindi ci vuole un centro di controllo.
Questo centro di controllo è l’antenato del nostro io biologico.
Ma poi, guardiamoci intorno: a parte quelle piante, che spero siano naturali e non siano di plastica, che vedo davanti a me, penso di sì, ma normalmente in un’aula universitaria non c’è quasi mai nulla, allora dico: “Indicatemi qualcosa di naturale” perché non c’è quasi mai niente. Noi siamo qui, siamo seduti, siamo vestiti, parliamo un linguaggio, tutto il nostro io riflette questa nostra caratteristica, e questo aspetto è una componente sociale, è una componente culturale, è una componente chiamiamola psicologica in senso lato, e questo aspetto, il fatto che non si trova nel cervello un centro di unificazione, non vuol dire che non esistano dei meccanismi di unificazione, di costruzione di questa nostra identità.
Sempre Andrea aveva parlato dell’io-tu: beh, l’io-tu è forse il meccanismo più forte di costruzione delle nostre identità che noi conosciamo, e questo è assolutamente qualcosa di legato alla dimensione sociale dell’interazione dell’io. Quindi, appunto, volendo arrivare verso una provvisoria conclusione, bisogna distinguere tra la scoperta della fragilità di questa immagine di noi stessi, la scoperta dei limiti della coscienza, e la tesi che allora di questa nozione di noi stessi, di persona, di persona dotata di un io, di una soggettività, eccetera, se ne possa fare a meno così facilmente. Si può parlare di una tendenza frettolosa ad eliminare quest’io; dobbiamo, secondo me, stare attenti a non essere un po’ troppo frettolosi. Poi, naturalmente, chi vivrà vedrà, la ricerca scientifica ci ha sempre dato delle sorprese, ma al momento attuale non mi sembra ci sia una necessità per andare in questa direzione, fermo restando, e vorrei concludere con questo, che ribadisco l’importanza straordinaria che le neuroscienze, che lo studio della mente ha per la nostra immagine di noi stessi.
Ma c’è bisogno di molta buona filosofia, di molta teologia, di molta scienza umana per dare una interpretazione di questi risultati che non impoverisca la natura umana, che effettivamente è qualcosa di prezioso e secondo me va preservato. Grazie.
ANDREA MORO:
Grazie a Michele di Francesco che ci ha spiegato che, quando eravamo bambini, avevamo ragione a dire “io”, e basta. E invece adesso sentiamo cosa ci racconta il Prof. Cesana.
GIANCARLO CESANA:
Edoardo Boncinelli, che è un importantissimo divulgatore scientifico, scienziato e ricercatore lui stesso, sul Corriere della Sera del 13 settembre dell’anno scorso, dice: “Utilizzando le tecniche del cosiddetto brain-imaging o neuro-imaging – cioè le macchine che sono in grado di rilevare l’attività cerebrale – si può osservare quale parte del cervello di una persona viva, sana e sveglia sono in attività, mentre quella esegue un particolare compito. In questa maniera si è potuto individuare l’area del linguaggio, parlato o ascoltato, del riconoscimento delle forme, dell’orientamento spaziale, dell’esitazione, dell’incertezza, dell’auto-approvazione, dell’auto-riprovazione e via discorrendo. Si è così potuta ottenere una mappa molto articolata delle varie funzioni mentali e più in generale psichiche che non ha uguali nella storia. Una delle critiche che viene più comunemente mossa a questo approccio verte sul fatto che localizzare non vuol dire spiegare, cioè localizzare che una certa area funziona in un certo modo quando si fa una certa attività, non vuol dire spiegare tutti i meccanismi. Verissimo: localizzare non vuol dire spiegare, ma non riuscire a localizzare vuol dire che si sta dando la caccia a qualcosa che non c’è. Una delle cose che non si riesce a localizzare è, ad esempio, la coscienza o addirittura l’io. Ciò potrebbe anche voler dire che a queste parole venerande non corrisponde niente di concreto”. “Kaputt”. L’io è spento. In effetti, io avevo detto ad Andrea Moro che avrei affrontato il tema parlando delle mie ricerche sull’adattamento e sul rapporto tra i fattori sociali e la malattia. Ma appunto, avendo visto questa citazione, non ce l’ho fatta perché ho capito che le mie ricerche sono insufficienti. E quindi siccome non posso aspettare l’esito del RNM o del brain-imaging per decidere se esisto, ho deciso di parlare della mia esperienza. E la mia esperienza non accetta che ci sia una conoscenza senza l’autore, che ci sia una conoscenza che ho senza me, cioè senza l’io. Anche se, purtroppo, la considerazione fatta da Boncinelli è una considerazione molto diffusa in ambito scientifico, che è, insomma, la considerazione molto banale degli anatomici positivisti che, sezionando i cadaveri, non avevano mai vista l’anima, per cui l’anima non esiste. Tant’è che Victor Von Weizsacker, che è un neurologo e antropologo tedesco vissuto nella prima metà del ’900, constatava questo: “Il fatto che la medicina odierna non possegga una propria dottrina sull’uomo malato è sorprendente ma innegabile”. Cioè la maggioranza dei medici non ha idea dell’oggetto su cui lavora. Ma non solo, proprio la concezione medica in cui normalmente si è introdotti non dà un’idea, perché di questo non si parla mai, nelle facoltà di medicina non se ne parla. E mi ricordo che a una domanda sul significato della vita, eccetera, che ho fatto a uno studente, lo studente mi ha risposto “ognuno può pensarla come vuole”, appunto. Soprattutto capite che questo è importante quando si affrontano aspetti decisivi del fenomeno umano che sono la mente, la psiche, il modo di ragionare. Allora, partiamo da capo, perché i casi sono due: o l’io non esiste, appunto non ha concretezza, è un’associazione casuale di fatti biologici, di proteine, di acidi, o l’io è questo, oppure l’io è un mistero, come dice il titolo, cioè l’io è un’evidenza che io non posseggo, che è oltre la mia misura; come tutta la realtà, perché dice “la natura dell’uomo è rapporto con l’infinito”, il rapporto con l’infinito non è il rapporto con gli spazi siderali, il rapporto con l’infinito è il rapporto con tua moglie, cioè perché tu non la possiedi, non è tua. È il rapporto con la tua vita, con la banalità della vita, con tutto quello che è dato senza che noi l’avessimo cercato né l’avessimo previsto: questo è il rapporto con l’infinito. Teilhard de Chardin, che era un gesuita evoluzionista, i cui libri sono stati messi all’indice per un certo periodo, perché lui sperava, insomma, ipotizzava che a un certo punto l’evoluzione da biologica si sarebbe trasformata in evoluzione sociale e finalmente il mondo si sarebbe compiuto secondo il disegno di Dio – un meccanicismo di questo genere è inaccettabile all’esperienza, perché vorrebbe dire che il mondo si salva da solo, mentre il mondo da solo sembra andare in rovina più che salvarsi; comunque, Teilhard de Chardin, il suo libro fondamentale si chiama Il fenomeno umano, e lui per descrivere il fenomeno umano, cioè quello che si vede dell’uomo, dice che ad un certo punto l’evoluzione della natura si è centrata su se stessa, si è riflessa su di sé ed è diventata coscienza. Tra l’altro, tenete conto che la parola coscienza significa sapienza, scienza, che si possiede insieme. Non è qualcosa di semplicemente individuale. Tanto è vero che si dice “devi agire secondo coscienza”, cioè “devi”, devi rispondere con una sapienza a un consapevolezza che non è solo tua. Ecco, la natura, ad un certo punto, evolvendo è arrivata a questo; e Giussani dice praticamente la stessa cosa nel Senso Religioso, perché dice: “L’uomo è quel livello della natura, in cui la natura prende coscienza di se stessa”, cioè prende coscienza del significato, prende coscienza dei rapporti che ci sono tra le cose, dei rapporti che ci sono tra me e il mondo, dei rapporti che ci sono tra le cose del mondo, del rapporto tra questo microfono e voi, questo tavolo, questo palco, questo…di tutto; oppure della mancanza di questi rapporti. E la gioia è la consapevolezza del rapporto e il dolore, la mancanza del rapporto. Da questo punto di vista, la coscienza dell’uomo, addirittura, come ha detto benissimo don Francesco Ventorino su un articolo de Il Foglio di un po’ di mesi fa, a questo punto l’uomo è un errore dell’evoluzione, perché ha la coscienza che deve morire. Cioè ha la coscienza che il significato, il rapporto tra lui e le cose, a un certo punto cesserà definitivamente. Ed è così, e lo dice anche la Bibbia, come diceva Giussani, quando descrive il peccato originale, è come se nell’uomo fosse entrato un veleno che uccide tutte le cose della vita, che uccide i rapporti. Pensiamo a come viviamo noi i rapporti, a quanto li distruggiamo e ci rendiamo conto di quanto significato noi sistematicamente aboliamo e di quanta morte, cioè sofferenza, mancanza di senso, mancanza di rapporto noi produciamo. Così, noi che, come dice sempre la Bibbia, siamo fatti poco meno degli angeli, siamo destinati a morire, con la coscienza di esserlo. E questo introduce l’altro mistero della vita e questo non ci piace, non ci sentiamo fatti per questo. E il Papa ha detto al Bundestag: “Vorrei però affrontare con forza ancora un punto che oggi come ieri viene largamente trascurato, esiste anche una ecologia dell’uomo, l’uomo è una aspetto della natura ed è soggetto alla natura, anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare, che non può manipolare a piacere, l’uomo non è soltanto una libertà che si crea a piacere, non mi sono fatto io. L’uomo non crea se stesso, egli è spirito e volontà ma è anche natura e la sua volontà è giusta quando egli ascolta la natura, la rispetta, quando accetta se stesso per quello che è, che non si è creato da sé”.
A questo punto, però, potrebbe essere tutto dominato da una incognita, da un ignoto, e l’ignoto fa paura, l’ignoto non è il mistero perché l’ignoto è il buio, quello che non si vede, la presenza che non c’è, è quello di cui hanno paura i bambini quando entrano nella stanza dove non c’è la luce accesa, è quello di cui hanno paura i bambini quando va via la mamma; il mistero invece è l’evidenza, è la chiarezza, è la luce che non sai da dove viene: questa è la differenza. Potrebbe ancora essere tutto dominato dal caso, ma proprio la presenza della coscienza, cioè l’io, è obiezione a un destino che potrebbe essere cinico e baro, perché sente ciò che manca, sentendo ciò che manca lo cerca e quando lo trova lo grida a tutti come segno di speranza. L’immagine che a me piace di più della coscienza è quella delle ultime statue di Michelangelo, nelle quali si vedono proprio le figure venir fuori dal sasso, dalla materia, con un volto: finalmente il mistero, la misteriosità della vita, come diceva giustamente lui prima, si identifica, si identifica in te, si identifica in me, l’infinito cammina su questa terra.
A questo punto, secondo me, si introduce la parola, la parola che definisce di più la natura dell’ io come esperienza, ed è la parola libertà, definire la quale non è affatto facile, però si può provare a descriverla. La libertà, innanzitutto, si manifesta nella impossibilità ultima di possedere l’altro o di essere posseduti se l’altro non vuole, come disse don Giussani. Di don Giussani mi ricordo due frasi sulla libertà, la prima quando ha detto alle suore, non mi ricordo più di dove, “finalmente ho capito perché Dio ha creato l’inferno, perché ha amato di più la nostra libertà che la nostra salvezza”; la seconda frase è stata, mi pare, agli esercizi della Fraternità qui a Rimini, quando disse: “Dio ci ha fatti in modo tale per cui il nulla” – perché noi siamo creature, siamo nulla, strutturalmente noi siamo apparenza, qualcosa che si vede per un po’ e poi scompare, prima c’era, adesso c’è, poi non ci sarà più – “Dio ci ha fatto in modo tale che il nulla, quello che è niente, Lo amasse”, cioè lo cercasse. La libertà è sinonimo di amore, è sinonimo di affezione, non esiste l’intelligenza astratta, per capire bisogna desiderare, bisogna cercare, noi non siamo un computer. Normalmente la libertà viene identificata con la possibilità di scegliere, che non è sbagliato, però questa è una idea fuorviante; pensiamo al fatto di essere di fronte a una scelta drammatica, in cui ci impegniamo molto, mettiamo tutta la cura, mettiamo tutti i nostri pensieri: la scuola per i figli, o un progetto di lavoro per noi; e poi la cosa va male, quindi abbiamo scelto ma abbiamo avuto un esito della nostra scelta che ci contraddice. Questo non ci lascia più liberi, ci rende più oppressi, e quante volte succede così, quante volte la ricerca della libertà si traduce in una frustrazione! La scelta è espressione della libertà, ma è espressione della libertà come tensione, non come realizzazione, perché la realizzazione della libertà è una esperienza, la scelta è resa necessaria dal fatto che la vita è ambigua, la realtà è storta, le cose non sono chiare e allora bisogna decidere: tu nella nebbia vedi un ombra, non capisci se è un toro o se è casa tua, devi decidere, se no finisci male. Don Giussani suggeriva che per capire le parole astratte, cioè per capire la parola libertà, bisogna usare l’aggettivo, bisogna domandarsi: ma quand’è che sono libero? E ci sono allora tre considerazioni da fare su quando sono libero: la libertà è un mezzo, è una struttura che noi abbiamo, è un quid che c’è dentro di noi e che noi utilizziamo per cercare di raggiungere la felicità, cioè per cercare di raggiungere il compimento della vita, il compimento più pieno possibile della vita. Noi possediamo questo organo, la libertà, che è l’organo che ci fa camminare, tuttavia quando arriviamo, dove arriviamo non ci basta: il bambino vuole il trenino, dopo vuole il cavallo a dondolo, così noi vogliamo un certo lavoro, dopo ne vogliamo un altro, non basta mai, come se dentro quello che cerchiamo noi cercassimo sempre qualcosa di più, appunto il non misurabile, quello che non è previsto da noi, perché se io cerco quello che è previsto da me ce l’ho già, quindi non mi compie, per essere compiuto devo trovare quello che non è previsto da me, quello che è più grande di me, che è appunto l’infinito. L’innamoramento, con la sua fugacità, è proprio l’esperienza di ciò: uno fa di tutto, dice addirittura io vivo per te, ma è un esempio chiarissimo di come ci si possa impegnare allo spasimo, ottenere e lasciare. Ormai i matrimoni, quelli che si celebrano, finiscono male due su tre, entro sette anni. Quindi la libertà è rivolta alla felicità, ma è rivolta a cercare un risultato che non si possiede, allora è importante sia il modo con cui si cerca questo compimento, sia l’identificazione di chi può compiere, di chi questo compimento può darlo, perché se io non lo possiedo, se non è mio, vuol dire che c’è qualcuno che me lo deve dare, cioè vuol dire che il compimento della vita non dipende da me. Qui si introduce l’altra questione: la definizione dell’io, la definizione della coscienza non dipende solo da me, non esiste per il fatto che esisto io, perché io esisto come rapporto, come legame e quindi per dare la definizione di me devo dare la definizione di ciò che mi compie come legame. Per cui il problema della vita, il problema dell’io, non è di raggiungere quello che voglio, ma il problema è che cosa voglio, perché, è un esempio cretino che faccio sempre, se tu vuoi volare e vai su una rupe alta trecento metri e ti butti giù, ti ammazzi, non è che voli, non è che ti compi. Quindi il problema è che cosa vuoi, e se quello che vuoi lo puoi avere e soprattutto se c’è qualcuno che te lo dà, perché non è tuo. Il sentimento di onnipotenza è l’errore più antico dell’uomo, è l’errore del peccato originale e poi l’errore della torre di Babele, cioè che io sono capace con la mia misura di salire all’infinito. Noi non ci pensiamo mai, perché noi pensiamo che la vita va bene, va male, che ci sono tante difficoltà, ma non pensiamo il dato fondamentale e cioè che noi siamo vivi perché c’è l’aria, perché c’è l’acqua, perché c’è il cibo, perché ci sono i rapporti; noi siamo vivi perché non siamo da soli, così noi viviamo nel tempo e nella tribolazione ma finalmente comprendiamo che la libertà è il mezzo che abbiamo per affrontare la condizione della vita.
Ma da cosa è messa in moto la libertà? Questo, per esempio, è un fattore fondamentale nell’educazione. L’educazione ormai è ridotta a una specie di psicologia minore, tanto è vero che tutte le facoltà di pedagogia, di scienze della formazione, sono molto legate allo studio della psicologia, c’è poi la pedagogia generale che è una specie di fisiologia della mente e la pedagogia speciale che è la patologia della pedagogia generale, quindi il modello è medico. Ma la psicologia mette in moto la libertà? Se la psicologia fosse capace di mettere in moto la libertà, gli psicologi dovrebbero essere i migliori educatori, mentre noi sappiamo che i figli di questi signori, poveretti, hanno le pene dei loro padri e a volte anche peggio. Ciò che mette in moto la libertà è un altro dato, di cui non si ha più il coraggio di parlare perché non si sa più cos’è. Ciò che mette in moto la libertà è la verità, il vero. “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”, perché ciò che compie è la verità, la verità è quello che compie, lo diceva San Tommaso, “adaequatio rei et intellectus”, la verità è la corrispondenza che esiste tra il mio desiderio, intellectus, e la cosa, e la realtà. Don Giussani diceva che questa è la definizione di verità più laica che avesse sentito, e la traduzione di intellectus in desiderio è giusta, perché altrimenti sarebbe troppo intellettualistica, sarebbe una traduzione di una ragione che sarebbe scarica affettivamente, perché l’intelligere, il comprendere è carico affettivamente, se non è carico affettivamente non comprende, non si attacca, non capisce, se non si lascia colpire non capisce. Il famoso esempio che faceva don Giussani, palando ai ragazzi, diceva: mi sembrate come quelli colpiti dalle radiazioni di Chernobyl, siete belli, sani, forti, eccetera, ma siete affettivamente scarichi, non ve ne frega più niente. In San Tommaso, questa definizione della verità, l’adaequatio rei et intellectus, sconfigge il problema, che secondo me è alla radice di questa paura dell’io, letterale paura dell’ io, che è il soggettivismo: “esisto solo io”, la realtà è un accessorio, è una propaggine di me, mentre non è vero, tu esisti perché c’è chi ti dà la vita, perché c’è chi ti tiene in vita, perché c’è la struttura che ti tiene in vita. Mi ricordo che Bino, che è qua davanti, una volta parlando con don Giussani disse che avevano fatto degli studi per cui il battito d’ali della farfalla sostiene l’universo: non c’è niente che è a caso, niente. Ed è così, ma è così anche per la scienza, altrimenti è una conoscenza superficiale, perché tutti hanno visto cadere la mela, una mela, un sasso, ma è Newton che ha percepito che cadeva perpendicolarmente, che quindi doveva andare in una direzione, ed andando al fondo di questo ha scoperto la legge della gravità universale. Se non c’è questa profondità, questa profondità di osservazione, questa percezione dell’altro, della cosa, del reale, come componente, come costituente il sé, non c’è più l’io, l’io si squaglia, proprio nella misura in cui l’io si afferma. Lo vediamo anche nella patologia mentale, per esempio nella schizofrenia: l’io si totalizza, diventa un fattore onnipotente, la realtà non c’è, l’io si disintegra, si disintegra, lo vediamo nell’autismo.
Questa corrispondenza tra realtà e desiderio è proprio una definizione di verità popolare, cioè che tutti la possono vedere, laica, cioè del popolo, perché laico, come diceva sempre don Giussani, l’unica definizione che io conosco di laico è non-prete, cioè non-chierico, non-intellettuale, non uno che ha studiato, non uno che la sa la verità, ma laico viene da “laos” popolo, popolare e ciò che ci rende certi è proprio il principio di corrispondenza che è il principio fondamentale della natura e del rapporto tra noi e la realtà. Così, concludendo, la vita è rapporto, l’io è rapporto, il rapporto è fatto di desiderio e di libertà, cioè di tensione e di libertà per seguire questa tensione, di ricerca della cosa che compie. Il primo, cioè il desiderio, senza la libertà, senza il protagonismo del soggetto, sarebbe semplicemente quello che oggi si chiama un “drive”, un istinto, una specie di binario in cui tu ti infili e poi vai dritto e segui direttamente questo istinto che praticamente è un percorso obbligato. Infatti oggi il problema della libertà è un problema gravissimo, perché tanto quanto si sottolinea la libertà fino a farla diventare licenza, tanto praticamente, in sostanza, la si abolisce: la ricerca scientifica stessa, almeno nel linguaggio, concorre a questo.
Vi faccio un esempio di una cosa positivissima: adesso hanno visto, soprattutto nelle terapie contro il cancro, che le terapie funzionano diversamente, cioè più o meno efficacemente a seconda di alcune strutture genetiche del paziente, e allora hanno cominciato a parlare di medicina personalizzata, di medicina che tenga conto della persona, cioè che tenga conto della sua struttura genica, primitiva. La conclusione, la scoperta è importantissima, è che allora la persona è definita dai geni. A parte che questo non è vero, anche scientificamente, perché c’è l’epigenetica che dimostra che l’ambiente cambia i geni e poi dopo c’è tutta la struttura dell’educazione, eccetera, ma soprattutto la saggezza della Chiesa chiama “dies natalis”, cioè il giorno in cui si nasce, quello in cui si muore, perché è quando uno muore che si vede chi è, perché la morte è l’aspetto centrale della vita, è quello che conclude quello che tu sei, e quindi è lì che vedi l’io, non nella composizione genetica. Ma tutto il pensiero va in questa direzione.
Torniamo a quello che ho citato prima, di Weizsäcker. Quindi noi siamo in questo destino di cercare qualcosa di più perché altrimenti tutto quello che troviamo ci annoia, cioè l’io emerge, appunto, in questo rapporto, in questo rapporto con l’infinito, in questo rapporto col più, che è la questione basilare della sua consapevolezza, della consapevolezza che ha di sé, come diceva Efrem il Siro, VIII secolo mi pare: “E’ meglio che la fonte soddisfi la tua sete piuttosto che la sete esaurisca la fonte”, perché se non fosse così tutto sarebbe già saputo e tutto sarebbe vanità e la coscienza non servirebbe a niente, perché non avrebbe niente da scoprire.
Come dice spesso Julián Carrón “è necessario un lavoro”, perché tutta questa scoperta è sicuramente un avvenimento, è qualcosa che succede nella vita ed è più grande di tutto quello che ci si può aspettare, perché scoprire la vita è veramente un fatto grande e imprevisto, scoprire il senso delle cose è un fatto grande e imprevisto, che allieta perché fa vedere il destino più grande per cui siamo fatti, però ci vuole un lavoro, perché se la conoscenza è un avvenimento, l’educazione è il lavoro per far scoprire questo avvenimento, è il lavoro che devono fare soprattutto gli educatori, è il lavoro che cerca il significato nella sua profondità.
Un titolo di un Meeting di qualche anno fa era appunto “Protagonisti o nessuno”, definendo l’alternativa tra la tragicità della vita e la felicità, e poi uno deve trovare la strada!
Per chiudere, mi rifaccio ad una immagine: nell’ambiente sanitario, uno sport nazionale è la lamentazione, si lamentano tutti, infermieri, medici, amministratori, eccetera. Gli infermieri si lamentano molto anche perché è un lavoro molto pesante, poi gli infermieri sono una categoria esposta a burn-out, cioè vengono bruciati, lo stress, e quando vado a lezione faccio sempre questo esempio: mi sapete spiegare perché appunto le infermiere si lamentano perché devono tirare su gli ammalati – effettivamente è un lavoro pesante, tant’è che ci sono pochi che lo vogliono fare, devono pulire le padelle – e Suor Teresa di Calcutta invece, facendo questo lavoro, in condizioni molto peggiori, era contenta? Qual è la differenza? La differenza è l’io, cioè è la libertà con cui tu fai quello che devi, con cui tu vivi la circostanza, con cui fai quello che devi.
Una volta, mi ricordo, facemmo una discussione sulle sventure della vita – la vita è veramente difficile, e la figura di Abramo, con questo suo peregrinare, con questa sua fatica nel concludere l’esistenza, la sterilità della moglie, eccetera – e don Giussani disse: “Abramo è la prima immagine dell’io”. La prima, prima di Abramo l’io non esisteva, perché Abramo è stato cercato da Dio, cioè l’io comincia quando l’infinito, quando questo desiderio di compimento, che dipende da qualcosa di più grande di sé, finalmente si può cominciare a compiere, si può cominciare a realizzare. Guardate che non è una cosa straordinaria, è il rapporto del bambino con la mamma, che purtroppo per l’adulto non c’è più, perché l’adulto crede di essere indipendente, ma è la stessa cosa: quando tu puoi seguire quello che compie il destino della vita, l’io comincia da lì.
ANDREA MORO:
Grazie Giancarlo, Giancarlo che evidentemente è educatore nel Dna – so che questa espressione è completamente inadeguata, la uso apposta – ha voluto educare anche me oggi e mi ha fatto provare la sensazione dell’imprevisto, perché lui sa bene che l’imprevisto è il sale della vita e nessuno verrebbe qui a sentire qualcuno se sapesse già tutto quello che si dice e quindi cambiandomi la materia, come nelle maturità di un tempo, tu mi hai provocato una reazione che assolutamente non avrei mai previsto; anzi se vi ricordate, quando li ho presentati, avevo detto che queste erano due vie alternative per capire l’io e lui mi ha dimostrato che non è assolutamente vero, mi sbagliavo.
Ripeto due frasi che hanno detto loro senza aggiungere nulla e la convergenza a me ha emozionato. Michele Di Francesco ha detto “non è possibile auto-trovarsi”, io non riesco ad auto-trovarmi e Giancarlo dopo ha detto “se vedo un fatto, compio una azione, io non posso ignorare l’autore”: la convergenza tra queste due prospettive è straordinaria. C’è solo una cosa che mi piace sottolineare, implicita in quello che hai detto tu, questa abitudine ad immaginarci come dei cd-rom di geni. Io a lezione dico sempre ai miei studenti che se avessimo una persona fatta esattamente con lo stesso Dna di Mozart, ma suo padre lo avesse portato a pascolare le pecorelle invece che a suonare organi e clavicembali, non avrebbe composto il Requiem.
Io credo che l’irripetibilità di tutti gli io che siamo noi sia talmente impressionante che sfida la stessa definizione di scienza, dove la ripetibilità sembra essere l’unico criterio di esistenza.
Lasciamo che questa giornata, che per quello che ho sentito, per la vostra presenza e per loro due mi ha emozionato, sia di fatto l’esecuzione di quella raccomandazione che c’è nel VI capitolo di Giovanni, dove Cristo raccomanda ai suoi una cosa che mi sembra uno degli stilemi del Meeting: “Non mormorate”. Grazie a tutti.