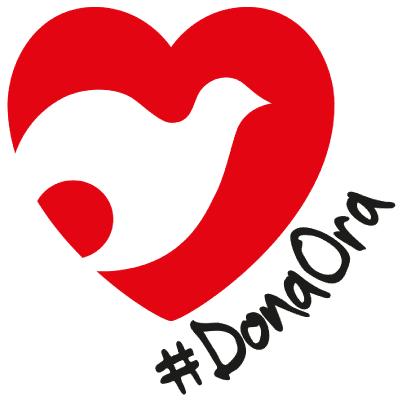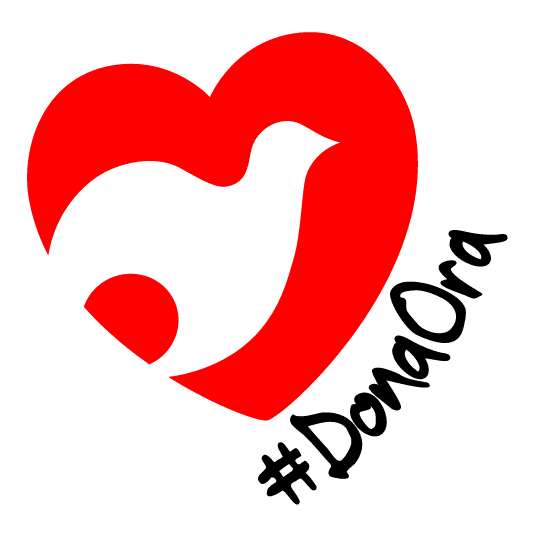Chi siamo
«MIA SORELLA LA VITA». BORIS PASTERNAK
Mia sorella la vita, Boris Pasternak
21/08/2011 - ore 15.00Presentazione della mostra. Partecipano: Adriano Dell'Asta, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca; Ol'ga Aleksandrovna Sedakova, Poetessa, Traduttrice e Narratrice Russa. Introduce Giovanna Parravicini, Fondazione Russia Cristiana.
Presentazione della mostra. Partecipano: Adriano Dell’Asta, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca; Ol’ga Aleksandrovna Sedakova, Poetessa, Traduttrice e Narratrice Russa. Introduce Giovanna Parravicini, Fondazione Russia Cristiana.
GIOVANNA PARRAVICINI:
Buongiorno a tutti, sono molto contenta di vedervi così numerosi, alle tre della domenica pomeriggio, a questo incontro di presentazione della mostra dedicata quest’anno a Boris Pasternak. Volevo subito cogliere l’occasione per sottolineare come Boris Pasternak, grande poeta, scrittore, premio Nobel nel 1958 per il romanzo Il Dottor Zivago, in verità, per la Russia, per milioni di persone, è stato molto di più. Questa mostra vuole essere la testimonianza del significato morale, spirituale, oltre che culturale, che Pasternak ha avuto per la Russia di oggi. Con noi abbiamo Ol’ga Sedakova, una delle voci poetiche più suggestive della Russia di oggi. Ci raccontava che la sua generazione leggeva le lettere che Pasternak scriveva a corrispondenti di tutto il mondo: dato che era praticamente tagliato fuori dai circoli della cultura ufficiale del Paese, soprattutto negli ultimi anni, con le vicende legate al romanzo e al Nobel, metteva la sua creatività in queste lettere. Ebbene, lei diceva, queste lettere che circolavano attraverso il samizdat, erano per noi come lettere apostoliche, ci parlavano di una novità, di un nuovo che stava venendo, che ancora non si vedeva perché il vecchio, quindi il regime, l’ideologia, era come se avesse chiuso tutti gli spazi. Eppure questo nuovo c’era, e noi vedevamo in lui la speranza, il futuro. Pasternak ne era consapevole perché, mentre scrive il romanzo, negli ultimi anni in cui lo sta praticamente completando, a un certo punto dà questo giudizio. Scrive: “Non voglio dire che il romanzo sia un’opera potente, geniale, che sia riuscito, ma è una rivoluzione, una decisione definitiva, è stato il desiderio di andare fino in fondo in quello che avevo da dire e di guardare la vita nello spirito della sua antica certezza, di ritrovare i suoi fondamenti”. Qual è questa antica certezza, questo fondamento? Negli stessi anni, in un momento in cui è malato, Pasternak scrive: “Sto scrivendo tra le lacrime, piango perché ho dolore, piango perché nella stanza accanto stanno suonando Skrjabin, ma piango soprattutto di felicità per la consapevolezza dell’armonia che Dio ha infuso nella vita di ciascuno, creando in qualche modo ogni uomo come suo tempio”.
La sorpresa di questa bellezza, la sorpresa della vita, che è equiparabile all’immortalità, è ciò di cui ci parleranno oggi i nostri relatori. Ma prima di passare la parola a loro, io vorrei leggere alcuni stralci di un messaggio che Eugene Pasternak, il figlio del poeta, ci ha scritto. Lui avrebbe voluto e dovuto essere qui con noi al Meeting, ma poi problemi di salute, e anche problemi di età, perché ha quasi novant’anni, non gliel’hanno permesso.
Vi leggo quello che ci ha scritto.
“Cari amici, perdonatemi se per età e problemi di salute non sono riuscito a venire alla presentazione della vostra mostra, che prende il titolo da uno dei libri più belli di mio padre. Sono felice che questo evento abbia radunato tante persone, alcune conosciute ma in gran parte a me sconosciute, che però sono accomunate dalla decisione di dedicare le proprie energie e il proprio lavoro al cristianesimo, senza lasciarsi arrestare da steccati confessionali o rituali. Mi riempie infinitamente di gioia il fatto che le riflessioni maturate da mio padre vi abbiano ispirato questo raduno, che questo tema abbia unito tanti partecipanti e diventi per voi fonte di un nuovo cammino e di nuovi frutti nella vostra vita.
Il titolo del libro Mia sorella la vita, in cui si scorge l’atmosfera che caratterizza l’opera e la vita di Boris Pasternak, ricorda l’atteggiamento nei confronti del mondo che era di san Francesco d’Assisi, la cui figura era molto intima e cara negli anni giovanili a Pasternak e ai suoi amici di quel tempo. Di san Francesco scrisse nel primo decennio del secolo il suo grande amico Sergej Durylin, che colpiva molto l’immaginazione pittorica del padre di Boris, Leonid Pasternak, perché vedeva in lui una somiglianza con la fisionomia del grande santo. Ciò che amava il giovane Pasternak in san Francesco era proprio la venerazione per la vita, che avrebbe dato il titolo al libro e sarebbe divenuto il contenuto principale della sua lirica.
Nella filosofia di Vladimir Solov’ëv, nel pensiero di Tolstoj e nei fondamenti morali del socialismo ideale, si svelava per questa generazione la caratteristica fondamentale dell’epoca, che Pasternak chiama una «nuova fase del cristianesimo, di straordinaria freschezza». È un rapporto con Cristo come persona viva, presenza quotidiana e unica veramente degna di fedeltà e di adorazione. Alla base di questo cristianesimo, c’era una lettura e un’immedesimazione con il Vangelo, il cui nucleo è l’amore come «tipo supremo di energia viva, che colma il cuore dell’uomo fino a traboccare, e ha bisogno di trovare uno sfogo, di essere elargita e spesa». Inoltre, Pasternak riteneva «straordinariamente nuova» per l’epoca contemporanea l’«idea della libertà personale e l’idea della vita come sacrificio».
Nel Dottor Živago leggiamo che il miracolo della venuta di Cristo ha segnato l’inizio di un mondo nuovo, insieme con il definitivo esaurirsi del paganesimo, e «da quel momento i popoli e gli dei cessarono d’esistere ed ebbe inizio l’uomo, l’uomo-falegname, l’uomo-agricoltore, l’uomo-pastore tra un gregge di pecore al tramonto, l’uomo il cui nome non risuona affatto con orgoglio, l’uomo celebrato con riconoscenza da tutte le ninne nanne materne e da tutte le gallerie di pittura del mondo».
Per tutta la vita Pasternak cercò di superare i limiti che imprigionano la vita, di liberarla dalle pastoie di sistemi sociali e ideologici per restituirle la libertà di movimento e di sviluppo. Trovava la conferma di questo orientamento nella Sacra Scrittura, che contrappone i fatti della storia dei popoli dell’Antico Testamento al miracolo degli avvenimenti evangelici, che scaturiscono dall’intuizione, dalla grazia dello Spirito Santo.
Cristo, liberando il mondo dalla «morta lettera» della legge, instaura la nuova giustizia dell’ispirazione e dell’amore. Secondo Pasternak, è la vita stessa, in quanto incarnazione del disegno divino, a scegliersi liberamente la propria strada tra le diverse varianti. «La salvezza non è nella fedeltà alle forme, ma nella liberazione da esse», scrive nel Dottor Živago.
L’irriducibilità dell’anima alla «prigionia del tempo» e alla fatalità della sorte è un altro dei temi fondamentali dell’arte di Pasternak. La forza principale che ha aiutato Pasternak a superare il gravame del tempo in cui gli toccò vivere è l’arte, la vocazione poetica. Mia sorella la vita è l’espressione della felicità colma di gratitudine dell’esistere. Una volta, nel dopoguerra mio padre disse che avrebbe sempre voluto scrivere come aveva scritto Mia sorella la vita, citando Blok che suddivideva la vita tra periodi di illuminazione e periodi che definiva invece «ovattati». Per mio padre, un’illuminazione era stata appunto Mia sorella la vita, e poi non si era più ripetuta – c’era stato un lunghissimo «periodo ovattato», conclusosi quando si mise a scrivere con grande facilità e ispirazione Il dottor Živago.
«Le circostanze intorno a me erano talmente chiare, così incredibilmente orribili! – scriveva Pasternak a Fedor Stepun -. Bastava solo coglierne il suggerimento e seguirlo docilmente. È stata l’epoca ad apportare l’essenziale all’opera, a determinarne il contenuto – cosa sempre più difficile quando esiste la libertà di scelta».
Ed effettivamente, tale era la forza, l’urgenza del periodo da lui vissuto, da spingere l’autore a nuove scoperte e a una nuova intensità spirituale di lavoro. L’arte autentica, secondo Pasternak, conferisce maggior valore alla vita umana e si oppone quindi alle tendenze distruttive dell’umanità. Lui capiva che ridestando attraverso la parola l’amore per la vita, compiva un’azione divina e in questo vedeva la propria vocazione.
In Mia sorella la vita, il quotidiano irrompe nella storia, attraverso gli avvenimenti della primavera e dell’estate del 1917 in Russia, come Pasternak dirà nella postfazione al Salvacondotto, scritto come una lettera post-mortem a Rainer Maria Rilke. Qui egli definisce il proprio libro come un racconto sui «primi giorni di tutte le rivoluzioni, quando i Desmoulins saltano sui tavoli e infiammano i passanti con un brindisi all’aria. Io sono stato un loro testimone. La realtà come una figlia naturale correva semi svestita fuori da una chiusa e opponeva tutta se stessa, illegittima e senza dote, alla storia ufficiale. Ho visto un’estate sulla terra che non riconosceva se stessa, naturale e preistorica come in una rivelazione. Ho lasciato un libro su di essa e vi ho espresso tutto quello che si può sapere sulla rivoluzione di più inaudito e inafferrabile».
Quel libro esprimeva il sogno di «nuovi cieli e terra nuova» come nell’Apocalisse di san Giovanni, che spazzassero via tutti «i compromessi con la coscienza e l’acquiescenza all’ingiustizia» e restituissero l’uomo alla natura umana, e lo Stato al diritto naturale. Il successivo corso della rivoluzione, in realtà, come si vede dal libro successivo, Temi e variazioni, avrebbe ingannato le attese della società e gettato il Paese in balìa di una dittatura disumana e di lotte fratricide.
Il successivo «periodo di illuminazione» iniziò per Pasternak verso la fine della seconda guerra mondiale, e ne sono l’esito Il dottor Živago e le poesie scritte a nome del suo protagonista. L’idea e l’atmosfera erano chiari all’autore fin dall’inizio, come scrive nell’autunno 1946 a Ol’ga Frejdenberg: «Voglio raffigurarvi un’immagine storica della Russia negli ultimi 45 anni e, nello stesso tempo…, esprimere le mie vedute sull’arte, sul Vangelo, sulla vita dell’uomo nella storia, e su molte altre cose ancora… L’atmosfera di quest’opera è data dal mio cristianesimo, un cristianesimo che nella sua ampiezza di vedute differisce alquanto da quello dei Quaccheri o di Tolstoj, perché si basa anche su altri aspetti del Vangelo, oltre a quelli morali. Tutto ciò è per me così importante e i colori si inscrivono così esattamente nei contorni generali che ho disegnato, che non riuscirò a sopravvivere nemmeno un anno se nel corso di esso non vivrà e si svilupperà questa mia reincarnazione, nella quale, con una concretezza quasi fisica, si sono trapiantate certe mie realtà interiori e certe particelle dei miei nervi».
Le speranze di concludere rapidamente l’opera non si realizzarono: dopo il decreto di Ždanov del 1946, che espelleva dalla letteratura Anna Achmatova e Zoščenko, anche le opere di Pasternak cessarono di venire pubblicate. La scrittura del romanzo si trasformò in lavori forzati che si protrassero per dieci anni, inframmezzati dalla traduzione di sette tragedie di Shakespeare e delle due parti del Faust, che permisero all’autore di guadagnarsi da vivere.
È sorprendente pensare con quanta fede nella forza eterna della fedeltà vivificante a Cristo furono scritte queste pagine negli anni bui dell’incredulità, quando sembrava che «all’alba e al calore manchi ancora un millennio».
Affidando i versi del romanzo al suo protagonista, Pasternak ebbe la possibilità di compiere un nuovo passo in direzione di una maggiore trasparenza stilistica e di una chiarezza e ponderatezza di pensiero. L’autore rinunciava consapevolmente alla specificità della propria maniera creativa, che si era venuta creando nel corso della sua biografia artistica. Questo gli consentì di ampliare la tematica della propria lirica, comprendendovi innanzitutto soggetti evangelici, che non sono in contraddizione, d’altro canto, con le poesie che contengono elementi autobiografici.
Un esempio interessantissimo di fusione armonica delle due tendenze è la poesia Amleto, che esprime il pathos e la sofferenza della preghiera di Cristo nell’orto degli Ulivi, poco prima del Calvario. Pasternak capiva perfettamente il rischio cui si esponeva lavorando al romanzo, un’opera assolutamente controcorrente rispetto all’ideologia dominante del tempo. Era in atto, infatti, una vasta campagna ideologica contro ogni brandello di verità conservatosi in letteratura e in arte, unitamente alle ondate repressive. Pasternak viveva nella consapevolezza della minaccia incombente dell’arresto. «È chiaro, sono sempre pronto a tutto. Perché è capitato a tanti e non dovrebbe capitare a me?», ripeteva in quegli anni.
Un’oscurità notturna mi punta contro
mille binocoli allineati.
Se solo è possibile, abba padre,
allontana questo calice da me.
…
Ma l’ordine degli atti è già fissato,
e irrimediabile è il viaggio, sino in fondo.
Sono solo, tutto affonda nel fariseismo.
Vivere una vita non è attraversare un campo.
Ma era anche consapevole che un cammino spirituale non può che avvenire a prezzo di sacrifici e sofferenze. «Lo spirito fondamentale delle mie esperienze o tentativi (non posseggo nessuna filosofia) – scrive Pasternak a una sua corrispondente americana -, è una concezione dell’arte, una creazione e ispirazione intese come sacrificio di una raccolta abnegazione, in una remota e umile similitudine dell’Ultima Cena e dell’Eucarestia. Infatti, l’espressione figurata della nostra cultura, gli eroi e i personaggi della storia europea sono in qualche modo un’imitazione di Gesù Cristo o gli sono strettamente legati, e il Vangelo è fondamento di ciò che chiamiamo regno della letteratura e realismo».
Pasternak amava molto, come poeta, e fin dall’infanzia conosceva bene la liturgia. Tra le sue carte si sono conservati foglietti consunti nelle pieghe, dove aveva ricopiato passi di testi liturgici che portava con sé. Nei libri liturgici sottolineava con la matita rossa le parole che esprimono il lieto annunzio della Resurrezione: «Ecco sopraggiungere la gioia per tutto il mondo», «Festa delle feste e solennità delle solennità», «Esulta e gioisci, o Sion», «Entrate dunque nella gioia del vostro Signore», e così via. Non sono semplicemente le tracce di una normale lettura, ma la ricerca delle forme espressive della gioia divina nel linguaggio della liturgia.
Il sentimento della gioia è affine al dono della riconoscenza, il dono più bello, di cui Pasternak era provvisto in abbondanza. Ecco la sua classica formula espressiva di questo sentimento nei confronti della natura: «Ti rendo grazie, perché Tu doni più di quanto ti si chieda». L’alternarsi delle stagioni, l’arrivo della primavera per lui era sempre una festa, l’oggetto di un particolare entusiasmo e gratitudine. L’apoteosi di questo sentimento è espresso nella poesia All’ospedale, dove il senso di gratitudine a Dio e al mondo nasce nel malato proprio quando comprende che probabilmente sta per morire.
O Signore, come sono perfette
le opere tue, pensava il malato.
Letti, e uomini, e pareti,
la notte della morte e la città di notte.
…
M’è dolce nella luce smorzata
che piove appena sopra il mio letto
riconoscere me e il mio destino
come un tuo inestimabile dono.
Con quanto amore Pasternak guarda in quest’istante tutto ciò che lo circonda, il panorama alla finestra. Le terribili condizioni dell’ambulatorio e del corridoio di un grande ospedale cittadino sovraffollato vengono descritte con un senso di amorevole addio e gratitudine. Nelle lettere agli amici, egli cerca di rendere queste sue sensazioni:
«Nell’istante che mi sembrava l’ultimo della vita, più che mai volevo parlare con Dio, rendere gloria a ciò che vedevo, coglierlo e fissarlo. “Signore – sussurravo – Ti ringrazio perché il Tuo linguaggio è magnificenza e musica, perché mi hai fatto artista, perché la creatività è la Tua scuola, e per tutta la vita mi ha preparato a questa notte”. Ed esultavo e piangevo di felicità».
Nella preghiera dell’ultima ora, Pasternak esprime il sentimento più profondo della sua lirica, la lode a Dio, la celebrazione della realtà visibile e il senso di partecipazione alla creazione, cioè la discepolanza dal Creatore e la comunione con il creato. La creatività è la scuola del Creatore. Pasternak sentì acutamente per tutta la vita il debito di questa discepolanza. E il suo lavoro infaticabile di artista, tutta la sua feconda esistenza, sono una risposta certa, commossa a questo appello.
Thomas Merton, monaco trappista, poeta e teologo, fece conoscenza con Pasternak per corrispondenza, in seguito alla lettura del Salvacondotto e di alcune poesie. Il dottor Zivago e il breve scambio epistolare arricchirono di aspetti esistenziali l’impressione iniziale: «La prima cosa che mi ha colpito facendo conoscenza con Pasternak come artista e uomo è stato il senso religioso, nel senso più ampio del termine; sia nella sua personalità, sia nella filosofia su cui si basa quanto scrive, balzano all’occhio gli elementi cristiani che vi sono espressi. Sarebbe una forzatura definire Pasternak un combattente per il cristianesimo, il suo profilo religioso è più ampio, esteso, enigmatico ed esistenziale, e l’impronta della sua personalità, come uomo di autentica ispirazione interiore, si esprime più intensamente in quello che è stato, che non in ciò che ha detto».
Contrapponendo il cristianesimo di Dostoevskij nei suoi romanzi, con quello di cui respira Il dottor Živago, Thomas Merton asserisce che Dostoevskij rispecchia i lati oscuri e problematici del cristianesimo in un’epoca in cui la Chiesa è integrata nello Stato. Quando invece la Chiesa è perseguitata e sottoposta a innumerevoli pericoli e gravami, nasce il luminoso cristianesimo apostolico dei primi secoli. È il cristianesimo di Pasternak.
Va anche detto che una componente essenziale della visione cristiana di Pasternak è la grande libertà interiore che contrassegna tutte le sue opere. La libertà come modo di esistere, come metodo creativo e come religione. Nel febbraio 1990, a un convegno organizzato a Mosca per il centenario della sua nascita, il noto scrittore e giornalista polacco Andrzej Drawicz disse che Pasternak era recepito in Polonia come l’apostolo della libertà. Nel Vangelo, è la conoscenza della verità a rendere libero l’uomo: «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi», dice Cristo «ai Giudei che avevano creduto in lui». L’idea di libertà non è mai stata intesa da Pasternak come un’esenzione dal dovere o un’indulgenza, ma è sempre stata legata ai concetti di «piena produttività», bontà, coraggio e «indipendenza da debolezze e calcoli estranei».
Con tutta l’anima sono con voi, Evgenij Pasternak, 24 luglio 2011, Trojckoe”.
Adesso cediamo la parola a Ol’ga Sedakova, che molti di voi già conoscono per aver letto suoi libri e articoli. Volevo solo ricordare una cosa: Ol’ga Sedakova per anni è stata una delle persone che papa Giovanni Paolo II chiamava sistematicamente, nei primi anni dopo la perestrojka, dall’Unione Sovietica, dai Paesi dell’Est europeo, per essere informato e per vivere una fraternità – Ol’ga Sedakova è ortodossa – e un senso ecumenico dell’unità. E quando c’è stata la beatificazione di Giovanni Paolo II, Ol’ga Sedakova ci ha scritto delle lettere che mi hanno commosso profondamente, righe che adesso cerco di ricordare a memoria, in cui lei ci diceva: “Qual è l’impressione che ho avuto della santità di Giovanni Paolo II? È stata l’impressione dello sguardo. Di solito noi abbiamo paura dello sguardo di altri su di noi, perché ci scrutano nel profondo, perché vedono i nostri limiti, i nostri difetti. Ebbene, lo sguardo del santo, lo sguardo di Cristo su di noi, invece, è uno sguardo positivo, perché Lui sa vedere in noi quell’immagine e somiglianza di Dio, quella bellezza, ci sa vedere come veramente siamo, sa fare sì che stiamo davanti alla realtà delle cose come davanti a una presenza che ascolta. Adesso ascoltiamo Ol’ga Sedakova.
OL’GA ALEKSANDROVNA SEDAKOVA:
«E della vita novità»
Perché Tu mi hai donato la compassione, il Tuo primo dono, il dono dello Spirito Santo dal quale sgorgano tutti gli altri.
Il dottor Živago (Dagli abbozzi e piani in brutta)
Cari amici, sono grata della possibilità che mi avete offerto di parlare qui, a questo bellissimo Meeting di Rimini che già conosco, del cristianesimo di Boris Pasternak. Vi sono grata innanzitutto di aver posto questo tema. Per quanto possa sembrare strano, nell’esame del romanzo Il dottor Živago, e in generale dell’arte di Pasternak, questo tema, centrale nel Pasternak della maturità, è il meno trattato[1]. Forse, il motivo è che il concetto solito di cristianesimo, teologia, esperienza di Chiesa per molti è troppo lontano da quello che incontriamo in Pasternak, che parla di tutto questo in un linguaggio volutamente «laico», volutamente «quotidiano», non formalmente «ecclesiastico». Un cristianesimo senza «spiritualismi», «devozionalismi», senza il solito timore di parlare «con le proprie parole» di cose che appartengono a un’altra realtà, senza termini teologici, senza alcuni fra i temi spirituali più tradizionali (peccato, umiltà, obbedienza, mortificazione della carne, lotta con le passioni e così via), che per questo motivo risulta irriconoscibile. Inoltre, potrebbe sembrare che al cristianesimo Pasternak assegni un posto troppo periferico, «sminuito», come ad esempio in questo caso:
«Lara non era religiosa… Ma qualche volta, per rendere tollerabile la vita, le occorreva l’accompagnamento di una specie di musica interiore. Non si può ogni volta scrivere da soli una simile musica. Questa musica era la parola di Dio sulla vita, e su di essa Lara andava a piangere in chiesa» (p. 65)[2].
Una musica che accompagna la vita? Il cristianesimo è tutto qui? Non è forse ciò a cui bisogna dare la vita intera? Ma dopo un primo moto di indignazione nei confronti del personaggio e dell’autore (Lara ascolta le Beatitudini e improvvisamente comprende che erano «per lei»: «Essi (i calpestati) hanno tutto davanti a sé. Così egli riteneva. Era questa l’opinione di Cristo»), proviamo a riflettere: non si dice qui qualcosa di più profondo e, forse, di più autentico sul rapporto tra l’uomo e Dio, tra la vita umana e la parola di Dio, che non nel consueto modo di intendere la parola di Dio come una sorta di prescrizione, del cui mancato adempimento ci verrà chiesto conto, e di cui noi stessi ci chiediamo conto? Questa «musica» cambia la vita in un altro modo.
La drammatica esperienza del cristianesimo nel XX secolo, la nuova percezione del cristianesimo e della Chiesa che inaspettatamente ha avvicinato l’uomo di oggi agli inizi del cristianesimo storico, agli «albori della primavera delle persecuzioni» (per usare le parole di un altro poeta cristiano europeo, Paul Claudel), questo ritorno alle fonti che si osserva in tutto il mondo cristiano, pagato a prezzo della vita di schiere innumerevoli di martiri dei nostri giorni, ci ha reso più comprensibile la parola di Boris Pasternak. La medesima ispirazione attinta all’inaudita novità e semplicità del cristianesimo, alla sua forza di liberazione, all’esperienza della liturgia che «si dilata oltre il tempio», all’invisibile santità della persona e della comunione umana («la comunione tra i mortali è immortale», così commenta il Vangelo un personaggio di Pasternak), noi la avvertiamo nelle parole di molti testimoni del XX secolo: Dietrich Bonhoeffer, madre Marija Skobcova… Con penetranti esortazioni a non trincerarsi dietro «devozionalismi» e a non nascondersi dietro forme precostituite di religiosità si volgeva ai propri ascoltatori il più amato e influente predicatore ortodosso dei nostri giorni, il metropolita Antonij di Surož. Quanti seguono don Giussani possono riconoscere nella stretta connessione fra i significati cristiani in Pasternak e l’esperienza «di verità» che si fa nella propria vita quotidiana un’analogia del «senso religioso» di cui ha parlato Giussani. Nella Lettera agli artisti di Giovanni Paolo II (2000) incontriamo dei concetti sorprendentemente affini a Pasternak sul significato spirituale della bellezza e della creatività culturale dell’uomo. Ma in particolare mi hanno colpito le analogie fra le immagini di Pasternak e ciò che si dice dello Spirito Santo nell’Enciclica Dominum et vivificantem, del 1986. Ritornerò in seguito su queste analogie.
Ma anche nel coro dei testimoni del XX secolo, che parlano di una «nuova fase del cristianesimo, di straordinaria freschezza» (Manoscritto a matita, p. 1477), alla teologia poetica di Pasternak spetta un posto tutto particolare, definito dal fatto che il centro della sua esperienza artistica e religiosa è uno solo. L’annuncio che reca la grande arte (ho avuto modo di scrivere in passato che per Pasternak è stato fin dall’inizio l’annuncio del Paradiso ritrovato[3]), e la Buona Novella per lui in un certo senso coincidono. Non a caso il principale «portatore di idee» nel Dottor Živago, Nikolaj Vedenjapin (potremmo definirlo una figura collettiva dei pensatori della rinascita religiosa russa), di cui subiscono l’influsso tutti i personaggi del romanzo che «fanno teologia», a partire dal nipote Jurij, e formula le idee del «nuovo storicismo» e della «nuova fase del cristianesimo», parte dal fatto che «fin dai tempi antichi quell’aspetto del Vangelo l’hanno sentito ed espresso meglio di tutti gli artisti» (Manoscritto a matita, p. 1477). A questo è legata la particolare esperienza di conversione cristiana di Pasternak, che non presenta drammatiche rotture come avvenne nelle conversioni tardive di altri artisti, quali Michelangelo, Petrarca, Gogol’, Lev Tolstoj. «Mi sono ripreso come da un deliquio», così descrive Pasternak ciò che gli è successo. Degli altri possiamo dire che è come se si fossero destati al pentimento – e in primo luogo, al pentimento per la propria eccessiva venerazione per l’arte, che nella nuova prospettiva appariva loro un’idolatria. Pasternak invece nella «fedeltà a Cristo» vede solo una nuova libertà e un nuovo spazio per la creatività, la semplicità di cui era sempre stato alla ricerca e di cui parla nelle sue riflessioni su Verlaine: «Non è semplice al fine di essere creduto, ma al fine di non ostacolare la voce della vita, che erompe da lui». La vita è il punto in cui confluiscono in Pasternak l’ispirazione artistica e la fede. La «vita nuova» oppure, come dice un personaggio del romanzo, la «vita portata al livello del genio».
Pasternak, quindi, è un artista, e non un teologo o un filosofo sistematico. Ma questo non significa che noi possiamo accostarci con condiscendenza alla sua «teologia poetica». Come se a un artista non si potesse chiedere chissà che, e in particolare una precisione dottrinale, una responsabilità morale. Questi, come si conviene a un artista, «gioca»
(Quanta arditezza occorre
per giocare nei secoli…),
esprime i propri «umori» e «impressioni», spesso subitanei e casuali; è un «eterno fanciullo», dunque esimetelo dalla responsabilità dei tetri «adulti»! Non verificate punto per punto le sue concezioni rispetto alla dottrina ortodossa della Chiesa, non controllate se frequenti le funzioni religiose e così via. E in effetti, nei versi e nella prosa di Pasternak noi ci imbattiamo in affermazioni che sembrerebbero una conferma diretta di queste diffuse opinioni sulla spontaneità irriflessiva dell’artista («quanto più è casuale, tanto più è vero»; «ho detto A, e non dirò B neppure se mi ammazzano»; «gli adulti hanno le loro ragioni»). Ma esse significano un’altra cosa. «Il libero genio dell’uomo» è pegno della realtà del reale; senza di esso il fatto non è ancora un fatto. L’artista per Pasternak non è affatto un pensatore dilettante o di seconda categoria, non concepisce nessuna licenza poetica per capricci artistici; l’arte non è per nulla esonerata dal rapporto con la verità e la coscienza. È esattamente l’opposto: Pasternak ha una visione della verità e della vita secondo cui proprio l’arte come particolare genere di conoscenza – e l’immagine come principale strumento di questa conoscenza-assimilazione («mia sorella la vita») – riescono ad esprimere più da vicino e con maggiore esattezza di tutti i concetti e sistemi di concetti il nocciolo della questione, l’essenza della vita e l’essenza della verità. «Nell’arte l’uomo tace, comincia a parlare l’immagine. Soltanto l’immagine può, quindi, tener dietro ai progressi della natura» (Il salvacondotto). In particolare, la continua disputa di Pasternak (espressa nelle righe citate e in molte altre), contro le pretese della piatta e rigida «coerenza», della causalità, dei «principi» e dell’«attivismo», a favore del «gratuito», del «fuori luogo», dell’«indeterminato», accidentale, «passivo», non nasce da un gusto anarchico da bohémien, da un incitamento al «caos artistico», ma al contrario è un lavoro sui significati, un lavoro per riportare i concetti alla verità. Proprio questo modo duttile ed elastico, lungimirante di comprendere le cose risponde secondo Pasternak all’essenza della vita e della verità. Perché? Forse perché la vita e la verità sono «irrazionali»? No: perché sono dei soggetti. Noi non possiamo discettarne come se fossero oggetti inanimati. Esse hanno una propria libertà e volontà creativa. Non possiamo disporre di esse (neppure nella nostra mente, ad esempio pensare che una cosa avviene per il tal motivo; che a una certa cosa debba conseguirne un’altra ecc.). L’uomo (l’artista, ma per Pasternak sono quasi la stessa cosa: l’artista – dice infatti – risponde della «perpetuazione dell’immagine della specie»; «… proprio in veste di verità lirica l’umanità si evolve attraverso le generazioni») cade tra le braccia della vita, tra le braccia della verità, diventandone un’«opera creata» («Oh, com’è bello non comporre romanzi e non scrivere versi, ma diventare noi stessi un’opera creata, nelle mani di questo sentimento mortalmente dolce…». Dagli abbozzi e piani in brutta, p. 1528), riconoscendosi come un «dono», un’«opera» del Creatore:
Mentre mi spengo in un letto d’ospedale
sento il calore delle tue mani.
Tu mi sorreggi, sono opera tua,
e mi riponi come una gemma nello scrigno.
(All’ospedale)
Dai primi appunti fino alle lettere degli ultimi anni, Pasternak medita sull’essenza dell’arte, e queste sue riflessioni sono tra le pagine più profonde della letteratura mondiale. E non sono pagine di estetica: nell’arte Pasternak vede qualcosa di totalmente insolito rispetto a un approccio propriamente estetico, per quanto sottile e paradossale esso possa essere. Nell’arte egli vede un servizio all’immortalità, un lavoro per superare la morte, uno «sforzo di resurrezione». «L’arte è sempre e senza tregua dominata da due cose. Essa riflette instancabilmente sulla morte e crea così, instancabilmente, la vita. La grande, la vera arte è quella che si chiama [Rivelazione] Apocalisse di san Giovanni e quella che vi aggiunge qualcosa» (pp. 117-118). Questo interrogativo sull’essenza dell’arte si presenta a Jurij Živago durante la celebrazione di un rito funebre. E tutto il romanzo, in sostanza, realizza questo compito: la sua base strutturale, come ho già avuto modo di scrivere, è costituito dal rito funebre ortodosso, la panichida[4]. Pasternak, lavorando al romanzo, sembra quasi adempiere in solitudine quello che sarebbe compito della Chiesa: offre un sacrificio alla memoria della Russia devastata, suffraga tutti coloro che sono stati uccisi, torturati, dimenticati e privati di un funerale religioso.
Anima mia che trèpidi
per quelli che mi attorniano,
sei divenuta il lòculo
dei martoriati vivi…
Nel nostro tempo egoistico
per scrupolo e paura,
come urna funeraria
tu ne ospiti le ceneri.
(Anima)
E proprio come l’ufficio funebre, anche il romanzo in ultima analisi parla della loro immortalità, della loro «vita che non invecchia».
Ma come si può parlare di arte nel senso consueto, se il suo primo modello è l’Apocalisse, cioè la visione di un nuovo cielo e di una nuova terra, un Libro dettato dallo Spirito Santo? Pasternak ha una risposta: egli intende l’arte come un’attività simbolica, e per questo può affermare tale paradosso: «Sebbene Bach fosse un compositore, le sue opere sono realmente vertici di immortalità» (Lettera a Renate Schweitzer). A Pasternak è assolutamente estraneo l’atteggiamento di sospetto nei confronti dello spirito che si manifesta agli artisti nell’ispirazione (come vediamo in padre Pavel Florenskij e in molti asceti, per non parlare della demonizzazione romantica dell’ispirazione). Per lui, Anima, Vita, Dono, Cristianesimo, Realismo (nel modo in cui lo intende Pasternak) appartengono alla medesima realtà. Anima, Vita, Cristianesimo, Realismo convergono nel fatto di essere innanzitutto dono e volontà di dono, sconfinata generosità:
Come fosse uscito uno col ciborio
e, apertone il coperchio,
tutto avesse elargito, fino in fondo.
Della vita come regalo del Creatore e come dono di sé agli altri, Pasternak parla senza fine, nei versi e in prosa. Nel dono di sé, nella creazione di una cosa che si dona inesauribilmente, consiste appunto l’imitazione di Cristo, imitatio Christi, che è alla portata dell’artista.
Si tratta di una creatività e insieme del potere di compiere i miracoli.
Pasternak intende la verità del cristianesimo come una «verità lirica» a lui familiare. La caratteristica principale della verità lirica è la sua naturalezza e inermità, l’assenza in essa di qualunque violenza e forzatura. «…Se la belva che dorme nell’uomo si potesse fermare con una minaccia, la minaccia della prigione o del castigo d’oltretomba, poco importa quale, l’emblema più alto dell’umanità sarebbe un domatore da circo con la frusta, e non un predicatore che ha sacrificato se stesso. Ma la questione sta nel fatto che, nei secoli, non il bastone ma la musica ha innalzato l’uomo al di sopra della bestia e l’ha elevato: la musica, l’irresistibile forza della verità disarmata, il potere d’attrazione del suo esempio» (p. 57). Ed eccoci ritornati alla «musica che accompagna la vita», da cui eravamo partiti.
Il cristianesimo di Pasternak si colloca dunque nella storia, nella «nostra contemporaneità, la cui principale caratteristica è quella di costituire una nuova fase, straordinariamente fresca del cristianesimo» (Manoscritto a matita, p. 1477). Questo nuovo volto della fede è inatteso rispetto alla cultura religiosa tradizionale dell’Ortodossia russa, alla «fede dei padri» con il suo intimo sapore arcaico, ascetico, eremitico. Queste due forme di fede, di Pasternak e della tradizione, sono in contrasto fra loro come la pittura ieratica dell’icona, la «contemplazione nel colore», rispetto agli ariosi schizzi impressionisti dal vero, come l’interno di una chiesa ortodossa o di una cella monastica rispetto a uno spazio aperto, a un paesaggio, nel quale tuttavia si svolge qualcosa che possiamo equiparare a una teofania per i personaggi del romanzo, e per lo stesso poeta. Un panorama guardato come una celebrazione liturgica:
Natura, mondo, scrigno dell’universo,
io resterò con lacrime di gioia,
penetrato da un brivido recondito,
sino alla fine della tua lunga liturgia.
Quando rasserena
Si potrebbe proseguire l’elenco dei contrasti, che riguardano sia molti oggetti di fede che, per così dire, la sua melodica. Ma ciò che lega molto solidamente il pensiero cristiano di Pasternak alla tradizione ortodossa è l’atteggiamento nei confronti dell’immagine, della poesia (poesia liturgica), come più profondo veicolo di significato (i pensieri più importanti sulla novità introdotta nel mondo dal cristianesimo vengono espressi nel romanzo attraverso l’esame della poesia liturgica, dei canoni della Settimana santa).
La novità è una delle parole chiave nel pensiero cristiano di Pasternak. Egli sente come pochi altri, sia prima che dopo di lui, questo motivo evangelico («Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; «Vi do un comandamento nuovo…»). Perché non c’è la morte? Perché le «cose di prima sono passate». Tra le «cose di prima» vi sono razze, classi, popoli, ogni tipo di generalizzazione e sintesi che sostituisca l’unicità della persona e del suo dono. Fra le «cose di prima» vi sono la mediocrità e la «diavoleria del quotidiano». Tutto questo è «passato». Noi siamo liberi da migliaia di cose del passato e non abbiamo nulla da temere. La felicità e la sconfinatezza del nuovo – e la perniciosità, la scontatezza di tutto ciò che non è nuovo (che è quasi tutto quello che ci circonda, sia nella Russia sovietica come in Occidente), in quanto torbido, ottuso, inutile, è il tema fondamentale delle ultime lettere di Pasternak. La persuasione e persuasività di queste parole sulla novità che è apparsa una volta per tutte, sbalordiva il lettore: esse racchiudevano in sé l’energia di una testimonianza diretta. E nel contempo erano un giudizio su tutto ciò che si presentava come «nuovo», su tutte le «novità», «innovazioni», «innovatività» di cui è piena la nostra civiltà. Esse (come nel romanzo) erano un giudizio sulla «novità» promessa dalla rivoluzione e che per un certo tempo aveva ammaliato il protagonista, finché non ne aveva ravvisato la «vecchiezza». In quella novità manca il Nuovo, non c’è nulla di vivificante, libero e miracoloso. Essa è «tramontata» prima ancora di apparire, come la tarda «laida» Roma pagana. In essa non c’è vita, perché non c’è compassione, il primo dono dello Spirito Santo, secondo Pasternak (cfr. l’epigrafe). Egli chiama compassione ciò che Dante chiama amore, e cioè il Principio dell’universo:
La compassione governa l’universo (Pasternak)
L’amor che move il solе e l’altrе stelle (Dante).
Vita, Novità, Dono, Libertà, Futuro sono le parole principali e interscambiabili dell’esperienza cristiana di Pasternak. Ed esse nella sua teologia sono tutte nomi di Cristo. Tutte queste cose, della cui possibilità «in questo mondo» dubitano i nostri contemporanei, non solo sono possibili, dice Pasternak, non solo ci attendono nell’«altra vita»: esse costituiscono la «musica» di questa realtà e costruiscono la vita dell’uomo, la vita dell’universo («dell’universo inaudito prodigio»), la storia («secondo universo», «lavoro per superare la morte»).
La posizione cristiana di Pasternak, in forza della sua profonda ostilità a «devozionalismi» e «spiritualismi» di ogni genere, a simbolismi convenzionali, a nebulose «mistiche» e ritualismi, in forza del suo disinteresse per l’aspetto dottrinale, non di rado viene intesa come una riduzione umanistica di un cristianesimo formalmente «corretto». Da quanto ho potuto qui accennare solo di sfuggita e da molte altre cose che non ho avuto la possibilità di ricordare, consegue, io credo, una conclusione totalmente diversa. Cristo per Pasternak non è un modello di «vita santa», o un esempio di «uomo perfetto» (come vediamo negli umanisti): Cristo è la Vita stessa, la «Vita di tutti», Colui che ha donato al mondo l’Immortalità. Questa è nel vero senso la visione mistica, misteriosa, che ci viene infusa, come sappiamo, dallo Spirito Santo. Pasternak, a quanto so, nomina una sola volta lo Spirito Santo (nelle parole che ho preso come epigrafe e che non sono entrate a far parte del romanzo, come alcune altre affermazioni, «troppo dottrinali»). Ma tutto questo – Vita, Dono, Novità, Futuro, Libertà (come ne parla Pasternak) non è altro che un discorso sulla Spirito, che «soffia dove vuole», e di cui la Chiesa testimonia innanzitutto l’azione vivificante di Datore di vita (khoregos tes zoe). Ho già accennato alle sorprendenti analogie esistenti tra Pasternak e l’enciclica Dominum et Vivificantem. Faccio solo due esempi. Sul dono: «Si può dire che nello Spirito Santo la vita intima del Dio uno e trino si fa tutta dono… e che per lo Spirito Santo Dio “esiste” a modo di dono. È lo Spirito Santo l’espressione personale di un tale donarsi, di questo essere-amore» (I, 2.10). Sulla nuova creazione e il suo legame con la prima creazione come prima salvezza dal non-essere (сfr. «Ecco, voi vi preoccupate se risorgerete, mentre siete già risorta quando siete nata, e non ve ne siete accorta», Il dottor Živago, p. 89): «È un nuovo inizio in rapporto al primo, originario inizio del donarsi salvifico di Dio, che si identifica con lo stesso mistero della creazione» (I,3.12). Un lettore attento di Pasternak riconoscerà in queste affermazioni, espresse in un rigoroso linguaggio dottrinale, ciò che nel linguaggio della verità intima Pasternak vuole comunicare senza posa, senza timore di risultare tedioso. Non possiamo chiamare il suo pensiero cristiano altrimenti che pneumatologia poetica.
Questa testimonianza certa sull’Altro Consolatore l’abbiamo ascoltata anche noi, lettori dei manoscritti proibiti di Pasternak che circolavano nel samizdat, noi che spesso non sapevamo nulla della dottrina della Chiesa, e che ripetevamo come una novità lungamente attesa: «Le cose di prima sono passate». La morte e il male e l’insensatezza sono già stati condannati.
C’è un legame naturale tra quello che volevo dirvi del cristianesimo di Pasternak e il tema di questo Meeting di Rimini: la certezza. Posso dire che quella che ci comunicava Pasternak era una certezza molto particolare. Una certezza infinitamente lontana dal fanatismo. Lo stesso Boris Leonidovič parlava di sé (come del suo personaggio Jurij Živago) come di un uomo irresoluto, indeciso, spesso smarrito. La sua certezza era a un altro livello, così come la sua fedeltà. «Ce ne sono al mondo di cose che meritino fedeltà? Ben poche. Io penso che si debba essere fedeli all’immortalità, quest’altro nome della vita, un po’ più forte. Essere fedeli all’immortalità, fedeli a Cristo!» (p. 15).
GIOVANNA PARRAVICINI:
Adesso ascolteremo quello che ci dirà Adriano dell’Asta, uno dei curatori della mostra, filosofo di formazione, slavista, docente per anni all’università Cattolica. Da un anno ci ha raggiunti a Mosca dove lavora come direttore del Centro italiano di Cultura presso l’ambasciata di Mosca: ma è rimasto amico e affezionato collaboratore, e difatti è qui come curatore della mostra e relatore.
ADRIANO DELL’ASTA:
Buon pomeriggio a tutti, è bello essere ancora una volta al Meeting. Il Meeting è un po’ come la primavera per Pasternak, si ripete ogni anno, e ogni anno è un miracolo. Allora, torniamo ai tempi della pubblicazione del Dottor Zivago. Una corrispondenza dell’Unità dalla Mosca di fine anni Cinquanta, dopo la pubblicazione in Occidente del romanzo, dopo il premio Nobel al suo autore e le polemiche che tutto questo aveva suscitato, spiegava che Pasternak era stato espulso dall’Unione degli Scrittori, cito, “per la gravità dei riflessi politici suscitati dal suo atteggiamento”. Badate, non per qualche cosa che aveva fatto lui, ma per i riflessi suscitati in altri, e ancora, per i riflessi suscitati non da qualcosa che aveva fatto ma dal suo atteggiamento. E’ la formulazione perfetta dell’idea di realismo socialista o di nemico oggettivo, cioè la formulazione perfetta della distruzione della realtà in nome della sua re-interpretazione ideologica, in nome della presunzione dell’uomo di poter sostituire alla realtà e alla sua infinita complessità uno schema. Ecco, Pasternak è l’esatto contrario di questa riduzione nella quale la realtà si perde, e nella quale si perde la nostra stessa esistenza, si perde il suo senso, si perdono i suoi contorni. E’ il contrario, Pasternak, di questa riduzione per la quale la vita individuale non ha più alcun valore e viene travolta, ultimamente con la morte e con la perdita della memoria, con la memoria così importante di cui prima parlava Ol’ga Sedakova. Pasternak è l’esatto contrario di tutte queste contrapposizioni in cui noi ancora viviamo, tra ragione assoluta e verità del singolo, tra società e individuo, tra storia e persona.
A determinare tutto il suo essere e la sua opera, c’è in lui una passione per la verità, per una verità assoluta che non è contrapposta al valore dell’individuo, anzi, lo esige, fondando il valore assoluto della persona e della vita concreta che è sempre multiforme e misteriosa. Pasternak scrive sulla vita, non sull’idea di vita. Come ha scritto un critico italiano sempre in quegli anni Cinquanta, in Zivago c’è una vita vera, un’interezza, un uomo, non già quello delle umanistiche retoriche oggi di moda, quello che si fa un dovere di contrapporre agli eventi irrazionali la propria cultura razionale, non c’è l’uomo della triste e famigerata dignità umana, oggi diremmo dei valori, c’è semmai un uomo con la sua dignità, che è ben altra cosa. Allora, non cerchiamo in Pasternak gli schemi, non riduciamolo entro i nostri schemi: impegno politico, contro disimpegno, progressismo contro decadentismo, storicismo contro intimismo. Questi schemi ci potranno anche dare l’illusione di dominare la realtà ma ci faranno perdere il gusto e la sensibilità per le sue sorprese, cioè ci faranno perdere la realtà stessa che è esattamente la sorpresa. Come diceva uno scrittore contemporaneo di Pasternak, anche lui di ceppo ebraico, Isaak Babel, “Voi sapete tutto, ma a che vi serve se avete sempre gli occhiali sul naso e l’autunno nell’anima?”. Ecco, l’arte di Pasternak, la sua grandezza, è proprio nel superamento di queste contrapposizioni che cercano di incapsulare la vita in una direzione o nell’altra, e si lasciano sfuggire la vita con il suo senso irriducibile: questa è l’arte per Pasternak, la scoperta della realtà nella sua complessità misteriosa e multiforme.
Se Pasternak si contrappone, o meglio, è irriducibile al razionalismo marxista, non è perché sia un irrazionalista ma per lo stesso motivo per cui ricerca e accetta un senso, una ragione della vita contro ogni irrazionalismo. Il punto è che questo senso è misterioso, non è creato dall’uomo, è suggerito a Pasternak dalla semplice percezione ed esperienza della realtà come dono, come qualche cosa che non è fatto da mano d’uomo ma che comunque è per l’uomo, per la sua felicità. In questo senso, l’esperienza di Pasternak coincide con quella del suo dottor Zivago che, quando ormai la tragedia della vita è compiuta, quando ormai è certo della separazione definitiva da Lara – cito – “si convinse che l’arte è sempre al servizio della bellezza e la bellezza è la felicità di dominare la forma e la forma è il presupposto organico dell’esistenza e per esistere ogni cosa vivente deve possedere la forma e quindi tutta l’arte, non esclusa quella tragica, è il racconto della felicità di esistere”. Questa certezza – sia chiaro – viene raggiunta non in un momento di quieto e tranquillo godimento estetico ma nel momento del più acuto dolore da cui può nascere – e di fatto in Pasternak e nel suo eroe nasce – la poesia più alta, a patto che l’uomo accetti questo dono e sia non la vittima o il prometeico signore ma il testimone.
E’ una parola chiara in Pasternak: colui che si fa carico di compiere come protagonista la volontà di un altro, di recitare come propria la parte che gli è stata assegnata da un altro, come si dice in Amleto, la prima delle poesie che concludono il Dottor Zivago.
Allo stesso modo, se in Pasternak viene lasciato tanto spazio alle opinioni più diverse, se c’è questo autentico trionfo del dialogismo, non è perché in questo modo l’autore vorrebbe vendicarsi dell’ideologia e del partito unico, non è perché vorrebbe contrapporre all’ideologia il molteplice cicaleccio indifferente per cui tutte le opinioni si equivalgono, ma perché c’è qualche cosa che, prima delle differenze delle opinioni e prima dell’imposizione di un’opinione obbligatoria per tutti, rende possibile il dialogo, c’è un criterio che rende possibile il dialogo al quale tutti debbono rispondere. Lo spazio per le opinioni altrui, lo spazio del dialogo non nasce in Pasternak per un vago umanitarismo idealistico, ma perché tutti parlano ancora una lingua comune, tutti devono ancora fare i conti con un criterio di giudizio oggettivo, il criterio di giudizio riconosciuto dai secoli che, nell’ultima poesia del Dottor Zivago, si presentano in carovana da Cristo per il giudizio finale.
Così il romanzo, il Dottor Zivago, non ha l’unità dei romanzi ottocenteschi, o comunque fonologici, ha però l’unità di un destino misterioso che guida la storia dei secoli come quella degli individui. Ecco, un’altra delle contrapposizione astratte che l’arte di Pasternak seppe superare è appunto quella tra il cammino della storia e il destino degli individui. Un critico italiano ha contestato la grandezza del romanzo proprio perché, a suo dire – cito – “i romanzi veramente grandi danno la sintesi di un’epoca, invece Zivago si applica in primo luogo a preservare il significato considerato come alcunché di autonomo e di predeterminato della propria esistenza individuale”. Detto per inciso, io faccio fatica a concepire una così feroce alienazione ideologica che porti a spingere a questa contrapposizione tra la sintesi di un’epoca e la difesa dell’esistenza individuale: come è possibile? Che altro mondo intellettuale, quello di una Nadezhda Mandel’stam, secondo la quale la vera eredità che il XX secolo lasciava alla storia era il fatto che quel “secolo lupo” aveva dimostrato come l’uomo, il singolo, la persona possa restare sempre uomo. Lei lo diceva quasi dal patibolo del marito, e non da una tranquilla cattedra universitaria.
A parte questa osservazione, oggi dobbiamo riconoscere che la capacità di dare la sintesi dell’epoca da cui è caratterizzato il Dottor Zivago, risulta sempre più evidente con il progredire degli studi storici. Pensiamo a questo proposito alle tre tesi che appaiono in una delle ultime pagine del romanzo, e che tanti attacchi attirarono a Pasternak accusato per queste tre tesi di essere un semplice antisovietico laddove, in realtà, Pasternak non faceva altro che ristabilire, per via artistica e ben al di là della politica, la verità storica e la verità della vita. Queste tre tesi potremmo condensarle così: primo, la collettivizzazione degli anni Trenta era stata una misura errata, aveva portato a milioni di vittime. Secondo, per nascondere il fallimento era stato necessario sostituire la realtà con una sua rappresentazione falsa. La terza tesi è che la guerra con i suoi orrori reali era stata una tormenta purificatrice, un soffio di aria fresca, un alito di salvezza in mezzo a tante astrazioni asfittiche. Ora, questi tre giudizi non solo sono storicamente esattissimi ma, proprio a dispetto di chi voleva ridurre Pasternak negli stretti limiti della politica, sono esteticamente giustificati, in quanto segnano la vittoria del realismo autentico contro il realismo socialista di cui parlavo all’inizio. Cioè, la vittoria della vita irriducibile contro ogni sua riduzione e soprattutto contro quelle sue riduzioni estreme che sono la morte e l’insensatezza. Non ci deve sfuggire che questi giudizi storici, che smascherano e denunciano le astrattezze e gli schemi dell’ideologia e la sua pretesa di conoscere e portare a compimento le leggi della storia, si trovano alla fine e a coronamento del romanzo, laddove diventa evidente quanto la vita dei suoi protagonisti sia stata guidata da un destino che, sotto le apparenze del caso e delle coincidenze apparentemente più fortuite, rivela invece una sapienza che non è meno potente e reale per il fatto di essere misteriosa e nella quale però, a dispetto di ogni pretesa dell’universale di assorbire e annullare il particolare, persino le cose più piccole e personali si trovano inserite nella grande storia dell’universo e si scoprono addirittura essenziali per lo sviluppo di questa storia. E’ in questo senso, ad esempio, che Lara, ripensando al proprio amore per Zivago, piccolo, misero, in quel momento, forse moralmente discutibile, lo concepiva come qualcosa che rientrava nell’armonia dell’universo e le apparteneva.
All’inizio della sua attività poetica, Pasternak aveva rispecchiato il caos, il disordine: con il romanzo, passa alla fase dell’interpretazione senza però rinunciare in nulla alla pienezza della realtà e del suo caos. Il problema è trovare un senso nelle cose senza ridurle entro uno schema, senza arrivare a trasformare la ricerca e la scoperta del senso delle cose in una razionalizzazione. Per fare questo, lo strumento dell’interpretazione, il principio ordinatore che permette a Pasternak di non perdere nulla della realtà, è la fede nella natura provvidenziale del destino, che non casualmente intreccia le vicende di tanti protagonisti e lo fa in maniera così ostentata, così pesante, in maniera così inaccettabile per chi vorrebbe che la storia degli uomini fosse guidata da una legge, ma da una legge che non contempla il mistero della libertà. Invece, il romanzo è l’eterno poema dell’uomo nel quale ciascun istante comunica con tutto il tempo, nel quale – cito Pasternak – “si ha a che fare con la vera libertà, non quella a parole, non quella delle rivendicazioni, ma una libertà caduta dal cielo come dono”. Contro ogni aspettativa, una libertà ottenuta per caso, stupenda percezione della libertà come dono che non è meno corrispondente alle attese dell’uomo per il fatto di essere sorprendente, anzi, è perfettamente corrispondente per un uomo che è definito dal Mistero, e ancora, è una perfetta comprensione della libertà come dramma, come relazione, dove il dramma per l’uomo – cito ancora Pasternak – “non è quello ideologico o politico, di approvare o respingere una realtà diversa da lui, il dramma è quello cristiano di comprendere come individuo tutto ciò che accadde e accade e di portarne degnamente il peso come testimone e non come vittima”.
Qui acquista tutta la sua evidenza il nucleo centrale sul quale si fonda tutto il romanzo, quello che permette a Pasternak di recuperare vita e senso della vita, realtà e senso della realtà, fuori e al di là di ogni estrazione. “Il cristianesimo come mistero dell’individuo”: sono sempre parole di Pasternak. Ciò che bisogna dare ai fatti perché essi acquistino un senso per l’uomo è ancora una volta il paradosso di un particolare che diventa senso dell’universo. Ma con il cristianesimo, quello che di nuovo è entrato nella storia è proprio il fatto che un particolare unico abbia assunto un valore universale e salvato la storia. E’ questo tema dell’unico, irripetibile e sorprendente, che sta a fondamento nel romanzo, del ruolo del caso e delle coincidenze fortuite, come guida dello sviluppo degli eventi. Un unico, irripetibile e sorprendente, o comunque non chiuso in una serie universale e necessitante, che guida i secoli in carovana.
Cito Pasternak nel Dottor Zivago: “Che profondo significato in questo cambiamento! In qual modo per il cielo (perché è con gli occhi del cielo che bisogna valutare tutto ciò, perché tutto ciò si compie al cospetto del cielo, nella divina cornice dell’unicità), in qual modo dunque una singola circostanza umana, insignificante dal punto di vista dell’antichità, diventa invece per il cielo equivalente all’emigrazione di un popolo intero?”
Qui parla degli ebrei che attraversano il mar Rosso. Qualcosa nel mondo era mutato, scomparsa Roma, cessava il potere del numero, l’obbligo imposto a ciascuno con le armi di vivere come tutti gli altri, come la massa. I capi e i popoli spariscono nel passato, al loro posto sorge il rispetto della personalità, l’affermazione della libertà, una singola vita umana diventata la storia di un Dio che ha riempito del suo contenuto tutto lo spazio dell’universo, come si dice in un cantico dell’Annunciazione. Adamo voleva diventare Dio è sbagliò, non lo divenne, ma ora Dio diventa uomo per fare di Adamo un dio, Dio si fa uomo per fare di Adamo dio.
Come si faccia poi a leggere Pasternak senza il cristianesimo, me lo devono ancora spiegare. In questa rivoluzione consisteva l’essenza del messaggio cristiano, con un Cristo non ridotto a morale ma riconosciuto come senso delle cose concrete di ogni giorno, come un uomo la cui vita, la cui libertà risultano più reali, più certe e più durevoli proprio per il fatto di essergli donate. Questa rivoluzione non poteva essere accettata dall’altra rivoluzione, che in realtà era solo una scimmiottatura della rivoluzione. Ho notato che è proprio per questo che il marxismo e la sua rivoluzione sono inconcepibili per il romanzo: non c’è nessuna motivazione politica ma solo la coerenza artistica, il tema del romanzo è la vita nella sua concretezza particolare dove un unico diventa senso dell’universo, e questo la nostra mentalità moderna non lo può capire. Troppo bassa e troppo limitata è questa verità per il marxismo o per chi, comunque, pretende di conoscere le leggi della storia e non riesce a intuire e a tollerare la realtà degli individui. Mentre, seguendo Pasternak, basterebbe chinarsi per terra, raccogliere questa verità più alta e più ampia di tutti gli universi, esattamente come Pasternak intende l’arte che è quella cosa più alta di tutte le Alpi di celebrata altezza, che giace nell’erba sotto i piedi, così che basta solo chinarsi, vederla e raccoglierla da terra. Grazie.
GIOVANNA PARRAVICINI:
Senza la pretesa, naturalmente, di racchiudere in poche parole tutta la ricchezza di quanto è stato detto, mi sembra proprio che adesso sia chiaro per tutti, che sia divenuto ancora più chiaro per tutti, che cos’è la presenza di una singola persona umana, di un uomo vivo, perché Zivago in russo vuol dire uomo vivente, quale sia il significato, la forza dirompente dell’uomo vivente davanti al muro di un’ideologia, di una società che si svela come inconsistente, un castello di carta. La stessa cosa che, come adesso diceva Dell’Asta, è stata questa ragazza che, nel silenzio della casa di Nazareth, in segreto dà la vita a un bambino e dà al mondo la vita, il miracolo della vita, la vita di tutte le cose, colui che è la vita. Ebbene, questa stessa circostanza è la circostanza di ogni persona, la circostanza di Maria nella casa di Nazareth, la circostanza di un uomo come Pasternak le cui poesie, le cui lettere venivano lette nei lager come preghiere, ed è la stessa cosa per noi oggi: le forze che muovono il cuore dell’uomo sono le stesse forze che possono cambiare, che cambiano la storia. Grazie.
[1]Fanno eccezione le opere della slavista francese Jacqueline de Proyart, amica di Pasternak, e della nostra biblista e storica della Chiesa Anna Šmaina-Velikanova.
[2]Tutte le citazioni del romanzo Il dottor Živago sono prese dall’edizione: B. Pasternak, Opere narrative, Milano 1994.