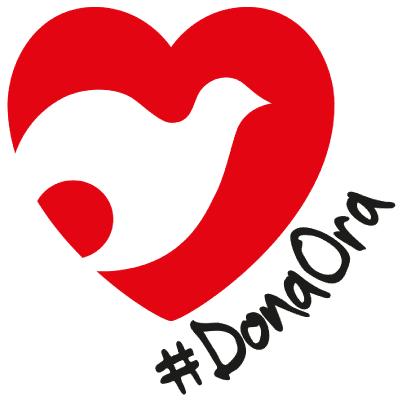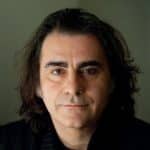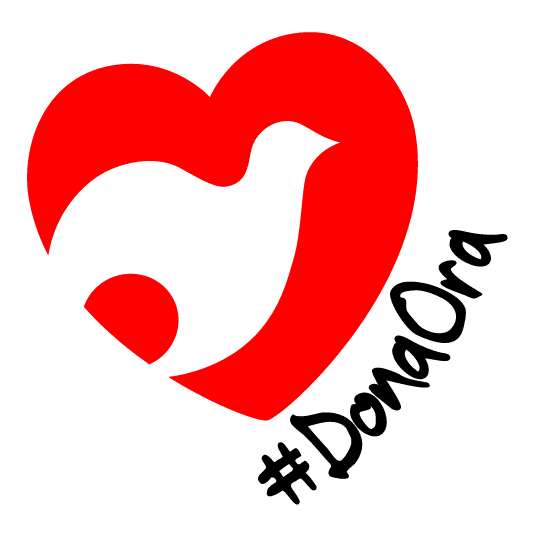Chi siamo
L’AMICIZIA CON IL TEATRO. GIOVANNI TESTORI NEI 100 ANNI DALLA NASCITA
Valter Malosti, Regista e interprete di Maddalene; Andrée Ruth Shammah, Cooperativa Teatro Franco Parenti; Andrea Soffiantini, Attore. Modera Giuseppe Frangi, Giornalista, Casa Testori Associazione Culturale.
«Il teatro è oggi l’unico luogo al di fuori della messa, in cui l’uomo può difendere ancora l’incarnazione della parola di Cristo e sé stesso come luogo di questa incarnazione». Era una convinzione profonda di Testori, condivisa per altro nel suo rapporto con don Giussani. Testori è stato uno dei maggiori drammaturghi italiani del 1900. Ha attraversato diverse stagioni, entrando in rapporto con tanti protagonisti del teatro italiano, a cominciare da Luchino Visconti. Nel 1973 ha vissuto l’appassionante avventura di fondare un nuovo teatro a Milano, con un grande attore, Franco Parenti e una giovane regista, André Ruth Shammah. Proprio lei è protagonista di questo incontro, dove racconterà 20 anni di amicizia e lavoro con Testori. Nel 1978 lo scrittore aveva avviato anche un’esperienza di teatro corale, coinvolgendo i giovani attori del Teatro dell’Arca di Forlì. Tra loro Andrea Soffiantini, per il quale Testori aveva anche scritto “Factum est”, un testo che ancora Soffiantini ha nel suo repertorio. Valter Malosti, terzo protagonista dell’incontro, non ha conosciuto Testori. Ma è stato uno dei registi che più assiduamente e creativamente hanno frequentato e portato in scena i suoi testi, tra i quali “Maddalene” rappresentato in occasione di questa edizione del Meeting al Teatro Galli.
Con il sostegno di isybank.
L’AMICIZA CON IL TEATRO. GIOVANNI TESTORI NEI 100 ANNI DALLA NASCITA
L’AMICIZIA CON IL TEATRO. GIOVANNI TESTORI NEI 100 ANNI DALLA NASCITA
Martedì 22 agosto 2023 Ore 17
Sala Neri Generali-Cattolica
Partecipano:
Malosti, regista e interprete di “Maddalene”;
Andrée Ruth shammah, cooperativa teatro franco parenti;
Andrea Soffiantini, attore.
Modera:
GIUSEPPE FRANGI, giornalista, Casa Testori associazione culturale.
“Sempre, qualunque sia l’argomento trattato, io sento che la parola che scrivo ha bisogno di essere detta, pronunciata. È come se messa così sul libro non avesse ancora detto tutto quel che ha da dire. Solo il teatro la libera completamente. Guai se la parola non è già coinvolta nella vita e non ricoinvolge la vita stessa. Ci sono parole destinate fatalmente a rivelare nell’esser dette qualcosa in più rispetto alla scrittura. Tutti i grandi testi, anche quelli già perfetti in sé ad un certo punto rivelano questa istanza nativa. Per questo posso immaginare un mondo senza romanzi e senza poesie, ma non un mondo senza teatro perché in fondo in fondo il teatro che cos’è? È il bisogno di pronunciare una richiesta di perdono attraverso una confessione, la confessione di fatti avvenuti, perché la confessione è un fatto, non si può teorizzare, o accade o non accade. Il teatro è questo, il teatro vero. E oggi chi cerca di precipitare in quello che oggi io chiamo il ventre del teatro s’avvicina sempre più alla non dicibilità secondo i canoni del teatro borghese, quindi domanda una dicibilità che è di natura diversa da quella del comune teatro”.
Frangi. Grazie, buongiorno a tutti. Quello che avete ascoltato leggere da Andrea Soffiantini è un passaggio del testo intervista che Luca Doninelli ha realizzato con Testori poco prima che morisse e poi uscì il libro da cui oggi Andrea ha tratto un bellissimo spettacolo che si chiama appunto: “Conversazione con Testori” e questo è un brano che ho voluto si leggesse all’inizio perché spiega benissimo quanto sia fondamentale, centrale il teatro per Testori. Tutto è teatro, come sa benissimo il nostro amico Valter Malosti che ha portato in scena testi che non erano teatrali, come sapeva benissimo il grande Franco Branciaroli, che non si può non ricordare. Quando Testori pubblicò “In exitu” come romanzo da Garzanti, corse da lui dicendogli che quel testo dovevano portarlo in scena ed è stato uno dei grandi eventi della storia del teatro di quegli anni.
Tutto è teatro quindi, è teatro “Maddalene” che ieri Valter Malosti ha letto al teatro Galli. Sono poesie che Testori aveva scritto come didascalie alle grandi rappresentazioni della Maddalena nella storia dell’arte, che però acquisiscono tutta un’altra dimensione e fisionomia, nascono per diventare presenza sulla scena, le parole di Testori hanno questa natura, per cui parlare del teatro di Testori è parlare di qualcosa che è al centro di tutta la sua avventura umana e culturale.
Innanzi tutto ringrazio tutti i nostri ospiti: Andrée Ruth SHAMMAH, che ha voluto essere qui nonostante fosse lontana e avesse problemi alla schiena. L’amicizia di Andrée per Testori è qualcosa di veramente inesauribile. Io, che sono un nipote di Testori, quando penso a tutto quello che Andrée ha fatto, al modo con cui ha sostenuto con grandissima convinzione tutto il teatro di Testori veramente mi commuovo. Andrée ha partecipato alla fondazione insieme a Testori, insieme a Parenti, insieme a Isella, insieme a Fercioni, insieme a Renato Palazzi di quello che oggi è il più bel teatro di Milano, l’allora salone Pier Lombardo, oggi teatro Franco Parenti.
Per chi non è di Milano dico che è uno dei posti più significativi della città. Andrée ha anche recuperato con un grande sforzo civico una piscina contigua al teatro e abbandonata da anni, una piscina bellissima degli anni Trenta che oggi è diventata patrimonio per tutti. È un teatro che è un luogo di vita.
Valter MALOSTI, che ieri appunto ha portato in scena le “Maddalene”, ha un curriculum testoriano che è poco meno di quello di Andrée. Ho calcolato che ha sei regie di Testori, la differenza tra Andrée e Valter è che quest’ultimo non ha mai avuto un rapporto personale per ragioni generazionali con Testori.
Poi abbiamo il nostro grande Andrea SOFFIANTINI, che è nato con Testori ed anche lui è espressione di una straordinaria fedeltà a quell’origine, a quella prima matrice. Andrea oggi lavora anche con Andrée e quest’anno sarà in scena con “Il misantropo” che Andrée porterà al teatro Parenti.
Dato che ho parlato di amicizia inesauribile partirei non tanto raccontando come è nato tutto questo, dico solo, per chi non lo sapesse, che il teatro Parenti, allora salone Pier Lombardo, nasce, è bello dirlo, da un attore comunista, da uno scrittore cattolico, anche se un cattolico non molto obbediente e da una giovanissima regista ebrea che aveva 25 anni.
Shammah. Questo è giusto dirlo, perché la forza di quel teatro è stata ciò che ci ha unito, cioè il valore dell’uomo e della vita comunque, dando peso al nostro passaggio su questa terra, è questo non è poco. Avete parlato di come tutto diventa teatro nella parola di Testori, perché la metti in bocca e si pronuncia, io invece ho fatto proprio gli spettacoli teatrali scritti apposta per noi, apposta per Franco Parenti e devo dire che gli sarò grata sempre. Sono contenta che Giuseppe lo abbia riconosciuto, ci sono cose che uno non dimentica.
Io a quell’epoca ero veramente giovane, avevo venti anni o poco più, avevo lavorato alla stesura dell’”Ambleto” e quando Franco Parenti, per il quale è stato scritto, dovette andare a Torino a prendere un lavoro perché mancavano i soldi, dato che eravamo una cooperativa, un gruppo molto povero a cui, come ha scritto Testori, solo la follia ha dato la forza di crederci, ha chiesto chi avrebbe fatto la regia, Testori rispose che l’avrebbe fatta Andrée. Io ho detto di sì e così è andata. Così è Testori e così è stata la nostra storia, per cui quello che io ho cominciato a fare è il teatro con il teatro di Testori.
Quello che voglio anticipare, poi ne parlerò dopo perché ci sarebbero tante cose da dire, e che può essere molto interessante da comunicare a voi è che cosa mi ha dato. Oggi alle 15 al Meeting c’era un incontro pazzesco sul potere dell’algoritmo, una discussione con due grandissimi: Paolo Benanti, un validissimo esperto che lavora con tutti i dati del Vaticano e Nello Crisantini e mentre si parlava della possibilità di non scegliere quello che l’algoritmo vuole, ad un certo punto è stato detto che dovremmo riprendere il significato delle parole e invece di chiamarci utenti, che è la parola che serve alla macchina, possiamo chiamarci persone. In quel momento ho pensato a Testori, perché nell’ultimo testo che ha fatto per noi teorizza proprio perché pronunciare una parola invece di un’altra cambia il mondo, perché oggi il grande tema del terrore, dell’ansia di quello che sta avvenendo nasce dal fatto che non usiamo le parole.
Lo spettacolo “I promessi sposi alla prova” l’ho fatto quattro volte, ma non sempre con lo stesso attore. La prima volta quando è nato con Testori, per Franco Parenti, Lucilla Morlacchi e Giovanni Crippa che faceva l’allievo. La seconda volta, dieci anni dopo, e allora fu una rivelazione perché si dichiarava la necessità del maestro, la necessità di parlare, la necessità per cui il teatro è la parola che si pronuncia, necessità che in quel momento furono importantissime. Abbiamo avuto un grande successo. Dopo dieci anni a me è sembrato necessario di nuovo e l’ho rifatto con Gianrico Tedeschi che faceva il maestro. Poi, prima del Covid, mi sono detta che non era possibile che si dimenticasse questa lezione e ogni volta che lo rifacevo, ogni volta parlava con un pubblico che cambiava e ogni volta era sempre più importante dire quelle cose.
Ad un certo punto c’erano da ricordare i cento anni di Testori e mi sono chiesta che cosa potevo fare di più e qui, dato che siamo come in famiglia, vorrei fare una confidenza, anche se, come ha detto Giuseppe, io sono ebrea, ma questo non cambia niente perché sono accettata e amata da molti ciellini. Quando ho pensato che serviva rifarlo per i cento anni di Testori- a parte il fatto che ho messo in scena “Maria Brasca”, il primo testo che Testori ha rappresentato al Piccolo per Franca Valeri ed io l’ho riportato in scena con una nostra attrice, per cui ne ho fatti due e poi tre e quattro- era il nostro cinquantesimo che coincideva con il centenario di Testori, per cui si sono sovrapposte le cose e questo mi è sembrato il gesto più incredibile. Stavo dicendo in confidenza che quando Testori stava già molto male e sono stata chiamata in ospedale-sono il penultimo incontro che lui ha fatto- all’orecchio mi ha invitato a non avere più paura, perché era arrivato il momento che facessi io la maestra, perché il tema de “I Promessi sposi alla prova” è questo maestro che afferma la necessità di sapere quanto può essere utile un maestro.
Allora mi sono detta che se l’allievo della prima edizione dove c’era Testori con noi e scrivevamo insieme, è diventato il maestro questo mi è sembrato il modo più rispettoso per passare la consegna, per dire che si rilancia, che si continua. Ebbene, ho portato quell’edizione de “I Promessi sposi alla prova”, cioè Manzoni, Testori e la lombardità,a Napoli, dove ho fatto un discorso anche furbo dicendo che dovevo molto ad Eduardo, così mi sono fatta voler bene subito, invitando i napoletani a farmi sapere se era vero, come io pensavo, che questo testo parla a tutti.
Ho messo dunque un po’ di passione, lo spettacolo dura tre ore e mezzo e la gente a Napoli con il milanese è rimasta stregata, perché nell’idea di affermare la parola contro tutto il resto c’è la teatralità e questo è davvero rivoluzionario. Noi abbiamo anche approfittato con il maestro per dire che quelli che sono necessitati a fare l’avanguardia devono ben conoscere la lingua. Ebbene, a distanza di quarant’anni la parola di Testori era di una potenza ancora più forte. Dunque festeggiare i suoi cento anni non è festeggiare qualcosa del passato che è stato grande, ma qualcosa che continua ad essere con noi, che è importante ora.
Frangi. Sottolineiamo che “I promessi sposi alla prova” andranno al Piccolo teatro in ottobre per due settimane. Spiegaci perché vai in trasferta, dato che il Pier Lombardo nasce in fuga dal Piccolo teatro, che è un teatro pubblico, mentre il salone Pier Lombardo quando nasce ha una compagnia chiamata compagnia degli Scarrozzanti, quindi un gruppo mobile. Siccome le parole hanno un peso, era proprio per contrapporsi ad un’idea di un teatro forse un po’ conformistico, un po’ seduto, quindi l’intento era di fare un teatro che andasse incontro a ciò che accadeva, perché erano gli inizi degli anni Settanta, quindi era una stagione in cui Milano era una città attraversata da profondissime inquietudini, dunque si va fuori delle mura spagnole, in periferia, anche se oggi non sembrerebbe più tale, ma allora lo era. Si va in periferia e si fa un teatro povero, nomade, scarrozzante, quindi questo era un segno.
Shammah. Non saprei dire perché. Certamente c’è questa idea di passare le consegne all’allievo di allora che diventa maestro, a dei ragazzi giovanissimi alla prima esperienza di palcoscenico, che vogliono parlare con la necessità di dire quello che si deve dire, perché questo è il nodo. Tu per stare sul palcoscenico, per recitare non per te , ma per gli altri devi avere la certezza, la voglia di comunicare le parole che stai dicendo. Questi giovani fanno un’esperienza fortissima con questo maestro raccontando il capolavoro dei capolavori che è “I promessi sposi” di Manzoni, dove Testori mette alla prova, sfida Manzoni e si mette lui alla prova con Manzoni e questo implica tantissime cose che ci porterebbero lontano. Perché va al Piccolo? Era giusto che il Piccolo festeggiasse i cento anni di Testori e lo facesse con lo spettacolo che io reputo storico, che è una somma di tante idee di Testori, che è una somma di quello che ho fatto. Non voglio usare dei concetti che a Testori non sarebbero piaciuti, quindi non sono d’accordo col dire che ci consacriamo andando al Piccolo, perché siamo più importanti noi del Piccolo teatro, scusate. Il teatro pubblico è finanziato dallo stato, dalle regioni, non ha nessun rischio economico. Il mio teatro invece rischia ogni anno, ogni mese di non garantire gli stipendi e questo a Testori piaceva molto, perché c’è un gioco di rischio, perché anche nei testi che scriveva si parlava di povertà, ma di povertà come scelta e come motivo di grande orgoglio. Credo che sia giusto che un teatro della città abbia sentito il bisogno di scegliere quello spettacolo per il suo cartellone, allora noi glielo diamo.
Frangi. Voglio affrontare una questione. Andrée ha esordito come regista a 25 anni, tu, Andrea, hai esordito come attore con Testori più o meno alla stessa età in “Interrogatorio a Maria”, che aveva avuto come regista il grande nostro amico e amico di Andrea, Emanuele Banterle che allora aveva 22 anni. Il tema del credere nei giovani è una questione fondamentale in Testori.
Prima di parlare mi piace sottolineare una cosa che dal punto di vista simbolico mi ha molto colpito in quest’anno centenario testoriano, perché Antonio Latella, un altro protagonista del teatro italiano, ha voluto lanciare un progetto in cui farai tre Amleti di Testori, cioè l’”Amleto” sceneggiatura cinematografica che poi non diventò mai film, “L’Ambleto” e il “Post Hamlet” che Andrea aveva portato anche qui al Meeting. Sono tre testi in cui Testori riflette su questo personaggio chiave per la sua storia culturale.
Antonio Latella ha scelto una formula non conformista, molto fedele allo spirito di Testori e ha lanciato un bando perché cercava otto giovani attori che partecipassero a questo progetto. La produzione è sostenuta da Pesaro 2024 e da AMAT, cioè il teatro delle Marche e dal Piccolo teatro di Milano. Hanno risposto 610 ragazzi under 35. il bando chiedeva che non fossero usciti da più di cinque anni da una scuola di teatro e ciascuno doveva dare una motivazione rispetto al tema, cioè agli Amleti di Testori. Con i suoi collaboratori, con Gilberto Santini direttore del teatro Le macchie, hanno fatto uno screening sulla base delle motivazioni e ne hanno scelti 50 che sono stati chiamati in una settimana a fare un provino a Pesaro, dove ciascuno doveva portare un monologo di Testori a scelta, doveva immaginare un omaggio a Testori e recitare qualcosa del suo repertorio.
A me è capitato un pomeriggio di assistere a questi provini ed una cosa mi ha veramente segnato facendomi capire perché c’era stata quella risposta, perché 610 attori giovani che vogliono sfidarsi su un testo di Testori non è un fatto scontato. Ho capito che questi attori erano usciti dalla scuola di teatro, avevano attraversato il nulla del Covid e la parola di Testori dava voce a questa loro ferita e lo si coglieva fisicamente assistendo a questi provini.
Alla fine ne sono stati scelti otto che parteciperanno a questo progetto che comincerà in autunno esordendo al Piccolo teatro poi a Pesaro. È una sorta di grande workshop in cui gli otto attori saranno impegnati per un anno. Il Corriere della sera due settimane fa annunciando l’iniziativa ha fatto un titolo stupendo: “I giovani: Parlaci ancora Testori” e questa è la cosa più bella che mi ha colpito.
E allora chiedo ad Andrea che cosa significa cominciare così giovane con una parola così impegnativa, hai fatto “Interrogatorio a Maria” come coro, però dopo hai avuto il compito di portare in scena nel 1981 “Factum est”, un testo straordinario di grande complessità.
Soffiantini. Credo che questo attaccamento, questa facilità che Testori aveva nell’avvicinare i giovani ed anche il piacere di poterlo fare, fosse legato al fatto che ai giovani è più facile confessare il proprio bisogno e quindi avvicinarsi anche a quella definizione di teatro che lui dà, per cui il teatro vero è proprio il bisogno di pronunciare una richiesta di perdono attraverso la confessione di fatti avvenuti.
Il giovane se ha un fatto che gli è avvenuto è più disponibile a raccontarlo, a confessarlo e quindi gli è naturale una richiesta di perdono che è anche una richiesta di aiuto. Io ricordo, riguardo al “Factum est”, un episodio legato alla sua nascita: mentre con Testori scendevo le scale mobili dal self service che c’era in cima alla Rinascente a Milano, gli dissi che mi sarebbe piaciuto con questo mestiere raccontare la vita, ma non mi usciva niente e lui dopo una settimana o poco più mi portò l’inizio del “Factum est”, che era un testo teatrale, raccogliendo così il mio desiderio di fare teatro. Aveva come protagonista un essere vivente che stava per iniziare nel grembo materno. Raccoglieva anche il fatto che io dicevo di voler raccontare la vita, infatti questo essere iniziava a comunicare con un balbettio. Testori fu magistrale, la confessione che gli feci fu da lui subito raccolta e trasformata in testo teatrale.
Anche per “Interrogatorio a Maria” fu la stessa cosa. Lui cercava una compagnia di giovani che non avessero, lui diceva, il vizio dell’accademia e allora incontrò il teatro dell’Arca, di cui io ero un membro, venne a Forlì dove il teatro aveva sede e come provino ci fece salire uno dopo l’altro sul palcoscenico a dire l’Ave Maria. Sembra assurdo, eppure salimmo uno dopo l’altro sul palcoscenico e mentre la recitavamo ci disse che il suo testo andava recitato così, come una preghiera. Rispondeva ancora una volta ad una domanda che noi, giovane compagnia nata nell’ambito di Gioventù Studentesca che poi sarebbe diventata Comunione e liberazione, avevamo come necessità: dei giovani che interrogano Maria sulla nascita di Cristo, quindi una parola che si fa subito carne.
Shammah. Non so quante persone in questa sala conoscano Testori, però vorrei dire che io ho fatto un po’ il clown perché nella parte di Testori che abbiamo fatto noi, Franco Parenti, che è un grande attore comico, ha tirato fuori sia le battute che Testori ha scritto per Parenti, sia quelle che Parenti inventava anche dove non c’erano, con Testori che a volte ne era angosciato.
I testi che abbiamo fatto noi sono anche comici, anzi quando ne “I Promessi sposi alla prova” Franco Parenti interpretava don Abbondio, faceva di tutto per far ridere, perché l’idea era quella del teatro popolare. Testori è lo stesso uomo che ha bestemmiato la ricerca di Dio, che quando l’ho conosciuto era un cattolico anomalo molto alla ricerca, per cui l’urlo era la ricerca dello scandalo. Noi abbiamo avuto quella parte di Testori, poi la sua irrequietudine, la sua ferita si placa con la morte della mamma, nel senso che trova una dolcezza dentro di sé e da lì incontra anche la sua pace.
Esiste poi il Testori di questa lingua folle che anche chi non vada a cercare l’anima di Testori né la teatralità che abbiamo creato insieme come Scarrozzanti, che può essere il caso di Malosti, prende una lingua, un’invenzione e fa degli spettacoli bellissimi che sono di tutt’altra natura, e questo accade non solo nel teatro, per cui il teatro di Testori è profondamente suo.
Lo abbiamo sperimentato nei nostri anni con tutta la trilogia degli Scarrozzanti: “L’Ambleto”, il “Macbetto”, l’”Edipus”, poi anche con “L’Arialda” che abbiamo fatto, che ho rifatto, che aveva fatto anche Visconti, anzi c’è il primo Testori fatto da Visconti. Ci sono dei Testori neorealisti, ci sono tutte le sue anime: il critico, il poeta, il giornalista, allora per capire perché siamo qui a parlare di lui occorre dire che ognuno ne ha una parte.
Io penso di averne una importante anche a livello personale, l’amicizia ha sicuramente superato il fatto che lavoravamo insieme, però noi stiamo parlando di un uomo che è un pianeta non ancora perlustrato e che a volte si pensa sia di difficile comunicazione, magari faticoso. Io penso che sia comunque un’esplosione tale di grinta, di rabbia, di poesia, di parola che è un fatto dentro la stitichezza, la mediocrità di quello che abbiamo intorno. È apparso questo fuoco d’artificio e oggi parlare di lui è parlare della generosità di darsi, di sbagliare, di tentare, di cambiare.
Dunque Andrea parla di un Testori, quello che balbetta, io parlo del Testori che faceva morir dal ridere, anche durante le cose più terribili dell’”Edipus” cantava “La Violeta la va la va” e Testori è tutto questo con la stessa autenticità perché, ritorno alla parola chiave, la necessità di quello che faceva ogni volta era assoluta, anche quella si contraddirsi. Abbiamo quindi tante sfaccettature, anche quelle che non sono qui rappresentate. Se siete qui in tanti e avete sentito parlare di Testori avete fatto bene a venire.
Malosti. Prima Andrée parlava della lingua di Testori. Io faccio sempre un esempio legandomi a Dante. Per i ragazzi guardandolo solo sulla carta sembra difficile, quando invece lo si dice ad alta voce improvvisamente qualcosa prende il volo. Testori è molto simile, sulla carta sembra impossibile da recitare, poi quando lo porti attraverso il tuo corpo, d’altra parte anche la voce fa parte del corpo, e va fuori di te, qualcosa succede. Certo devi usare molto anche il cervello, cosa a cui siamo un po’ disabituati come categoria di attori, ti obbliga a fare un certo tipo di lavoro sia fisico che mentale.
L’altro esempio che faccio spesso nei riguardi di Testori è Shakespeare: sono due poeti molto concreti, tutto quello che Testori dice non ha niente di astratto, è poesia perché esprime anche l’organicità, anche cose fastidiose per alcuni, in maniera poetica, ma è tutto concreto: se studi puoi rintracciare nel corso del testo che tutto ha un senso, tutto è portabile, quindi quando tu hai qualcosa di concreto, di materiale, di poetico hai in mano una bomba, come nel caso di Shakespeare.
Io ho diretto la scuola del Teatro Stabile di Torino per tre trienni, uno pienissimo da cui sono usciti un sacco di artisti importanti e gli altri due di cui ho fatto solo due anni e un po’, ma Testori era uno degli autori centrali su cui lavoravamo con quel corso centrale in cui abbiamo fatto Pasolini all’inizio e Testori alla fine. Abbiamo portato in scena” L’Arialda” come saggio finale, ma avevamo lavorato su “I segreti di Milano”ed è stato molto formativo, perché abbiamo attraversato anche il corpo dei suoi scritti d’arte che Andrée citava prima. Io ho iniziato a lavorare su quel corpo letterario di Testori un po’ perché già appunto Andrèe ed altri artisti avevano fatto benissimo, diciamo quindi che il territorio era occupato.
In realtà avrei voluto fare il pittore nella vita e l’ho fatto anche un po’, ogni tanto si trova su eBay qualche mio quadro dell’inizio, poi ho smesso perché non mi consideravo un bravo pittore.
La critica d’arte di Testori, e non dico nulla di straordinariamente nuovo, segue le orme di Roberto Longhi, di cui anche Pasolini è stato allievo, ed è una critica d’arte emozionale, dove il corpo e l’anima entrano in gioco, non è soltanto una questione scientifica. Chi ha potuto ascoltare le “Maddalene” capisce quali investimenti Testori abbia fatto, lui dice, usando una delle sue perifrasi solite, che ha scritto il testo facendo lingua in bocca con Maddalena ed è vero nel senso che si sta insieme all’umanità fino in fondo e questo anche nella critica d’arte.
Il mio primo spettacolo di Testori è stato un saggio di critica d’arte che lui ha scritto per Olivetti nel 1958: “Giovanni Martino Spanzotti e gli affreschi di Ivrea”. Dentro lo stabilimento Olivetti c’è una chiesa francescana, davanti c’è la mensa di Gardella, poco lontano ci sono gli edifici di Gabetti e Isola. Questa chiesa ha un tramezzo affrescato da Martino Spanzotti che Testori riconosce come uno dei capolavori di fine Quattrocento ed il testo mi riguardava molto perché c’è un giovane pittore che parla prima con suo padre, poi diventa a sua volta maestro di Gaudenzio Ferrari. Era scritto per essere detto e appunto mi riguardava moltissimo. A proposito di maestri, penso che Testori abbia sempre percorso questa strada, questa staffetta che si passa dall’uno all’altro, da un maestro all’altro che poi diventano auspicabilmente uno diverso dall’altro. Un’altra cosa che mi pare di capire è che Testori non cercava copie, anzi cercava l’originalità che nel teatro noi tendiamo a dimenticare.
Quando da ragazzo ho cominciato a fare le regie mi dicevano che i miei attori recitavano uno diverso dall’altro, ma io rispondevo che a me piaceva. Ognuno deve non dico essere se stesso, che sarebbe un discorso troppo lungo, ma deve portare un’originalità, deve portare la sua vita e la vita che c’è attraverso le parole che dice. In Testori questo è possibile in tutti i testi. “L’Arialda”, che sembrava un testo desueto, fatto invece con i miei ragazzi a scuola è diventato un testo fortissimo perché c’era tutta la forza della gioventù. In Testori c’è un’energia incredibile, di grande qualità. Oltre che sull’”Arialda” e su “La Maria Brasca” abbiamo lavorato sui testi de “I segreti di Milano”, che sono bellissimi, un capolavoro della letteratura italiana e a fianco di queste opere c’è la critica d’arte. Una delle prime cose che facevo a scuola era far leggere il testo su Grünewald per vedere se i ragazzi riuscivano a superare lo scoglio che appunto è fatto di corpo anche fastidioso, perché Testori parla dei protagonisti, del Cristo e degli altri personaggi in maniera organica, non c’è la pietà, o meglio c’è ma supera l’immagine di pietà a cui noi siamo abituati. Devi investirci col corpo e con la mente.
Shammah. Sembra scontato quando si parla di Testori e dell’importanza di un maestro, ma siamo in un’epoca in cui dire una cosa del genere è una follia, quando mai la gente riconosce il bisogno del maestro? Le cose che dice Testori sono sempre contro il pensare comune, non ha mai seguito l’onda. Nella critica d’arte a parte l’emotività ci sono delle intuizioni pazzesche, perché lui ha capito che Martino Spanzotti era un grande prima che lo riconoscesse chiunque altro. Anche nel teatro ogni volta sono provocazioni, sono solitudini. Il fatto che oggi siate in tanti non è un dettaglio, è una conquista incredibile perché lui è sempre stato scomodo tra i cattolici, così come Franco Parenti era un comunista scomodo, perché l’establishment del PCI non voleva niente di ciò che faceva, io sono sempre stata un’ebrea scomoda, una donna scomoda, non ero femminista quando c’era il femminismo, per esempio. Siamo sempre stati scomodi con l’idea che il pensiero non deve essere influenzato dalle mode, dal conformismo. Il rischio intellettuale di quello che pensi: questo è Testori. Allora che oggi si parli di lui, lo si riconosca è una cosa straordinaria, senza semplificarlo, senza banalizzarlo, senza ridurlo ad un’immaginetta facile, ma continuando a parlare della sua complessità. È difficile Testori, però quando si parla di maestri, vi risulta che i giovani oggi credano alla loro importanza? Quando mai parlo del mio maestro e dico grazie perché ho imparato da lui? Non si ringraziano i genitori, è tutto dovuto.
Tutto Testori, anche” L’Arialda”, anche la “Brasca” che ho rifatto, parla una lingua che anche all’epoca non era così facile. C’era la ribellione, cioè volere quello che si vuole al di là di quello che pensano gli altri, questo è il senso, che poi sia la ricerca dell’indipendenza sessuale, che tu sia una donna di una certa età che vuole un ragazzo, queste sono sempre metafore contro il perbenismo intellettuale, non è mai conformismo ed è accettare, per voi penso sia anche chiaro dal punto di vista religioso, accettare la croce, la difficoltà di stare al mondo e la fatica e il senso di dolore che Testori provava. Non cercava l’approvazione, si metteva sulle spalle la fatica di essere quello che era. Questo è molto forte, perché avrebbe potuto, quando voleva, cercare consenso, aveva tutti gli strumenti per essere un seduttore con quegli occhi blu, con quel modo di parlare, però quando ti seduceva troppo ed era troppo facile farlo, si interrompeva. Io posso parlare di lui perché da quando l’ho conosciuto da ragazzina nel 1969 fino a quando è morto nel 1993, anche in periodi in cui non recitavamo i suoi testi, l’ho sempre visto, frequentato, mi ha insegnato tantissime cose e lo dico perché è abbastanza eccezionale che noi oggi ne stiamo parlando. Non dico che fosse votato, ma aveva anche l’attrazione verso l’abisso, più le cose erano difficili più lui vi si sprofondava, o sbaglio?
Frangi. Non solo. Una cosa che va detta è che a Testori piaceva molto lavorare e far lavorare, ha messo al lavoro Franco Parenti, i ragazzi, in fondo ha messo al lavoro anche te nell’affrontare la lingua di Testori. Era un personaggio che si sporgeva sempre sull’abisso, poi aveva una sua concretezza molto lombarda per cui alla fine plasmava la lingua giusta, inoltre la cosa che a me ha sempre colpito e che un po’ è emersa da quello che ha detto Andrea Soffianti è il suo amore per l’attore, per il corpo dell’attore, per la voce di Franco Parenti per esempio. Credo che sia un amore, e bisognerebbe che lo dicesse Valter che non l’ha mai conosciuto, che sente chi porta in scena Testori, perché in fondo portarlo in scena e leggerlo potrebbe sembrare cosa da pazzi, invece è un esercizio che regala una sorta di felicità, di pienezza.
Shammah. Allora confido una cosa. “Factum est” è chiaro che aveva dei significati..
Frangi. Racconta l’episodio, che è bello. Hai fatto recitare “Factum est” a Franco Parenti.
Shammah. Questo è un episodio straordinario, ma stavo dicendo un’altra cosa: “Factum est” è un feto che parla e che chiede il diritto all’esistenza. Era politicamente, nel momento in cui è stato scritto, un argomento molto discusso. Franco Parenti, per dire come stimava Testori, affermava di capire che si trattava di un tema molto discusso, il nostro teatro in quel periodo era stato bollato come un teatro di sinistra, ma quella lingua lui voleva dirla, voleva recitarla e sapeva che se avesse continuato a recitare quel testo poi ne sarebbe anche stato convinto. Questo per sottolineare che lui voleva fare “Factum est” e per spiegare la potenza di questa lingua. Ha fatto una cosa strepitosa.
Frangi. Valter è regista, ma anche attore. Qual è la sua esperienza?
Malosti. È come stare in equilibrio su una fune altissima, sei sempre lì che caschi in queste subordinate che non sai quando finiscono. Anche nelle poesie è la stessa cosa, è bello, è un’emozione, è come buttarsi con una corda.
Frangi. Valter, parli di quando devi affrontare la sintassi in Italiano, invece quando Testori si inventa la lingua?
MALOSTI. Quando si inventa la lingua bisogna andare a cercare la concretezza. Ho un amore sconfinato per Shakespeare ed è molto simile, devi andare a cercare che cosa ti vuol dire, non devi andare a cercare la filosofia, è un teatro in cui non devono passare le didascalie, è per tutti, è un teatro popolare che anche nei testi più estremi comunica, passa e quindi per un attore è una goduria infinita poterlo recitare. Lo si capisce attraverso l’esempio che facevo prima dei miei allievi, la cui formazione purtroppo è sempre più carente.
Testori ti richiede tutto un lavoro che sarebbe necessario rifare nel nostro futuro educativo, tenendo presente tutto quello che c’è intorno, per esempio la parte dei beni culturali è negletta, ormai nessun attore sa più riconoscerli. Una volta portavo i ragazzi anche nei musei e cercavo di far leggere loro dei quadri, ma nessuno di questi sa più leggere un quadro, soprattutto un quadro religioso, è come per me guardare le pietre non essendo un archeologo. Tu le guardi, ma non sai riconoscere quello che stai guardando. Quando abbiamo fatto “Cleopatras” con Anna Della Rosa abbiamo dovuto studiare tutto quello che c’era intorno. Testori ti porta a scoprire dei mondi e questo è fondamentale. Oltre al piacere fisico di recitarlo ti porta anche a riscoprire un patrimonio che è anche molto italiano.
Shammah. Per l’”Amleto” siamo andati a Varallo, al Sacro Monte e il muro del nostro teatro è stato fatto come un muro del Sacro Monte e per anni e anni è rimasto blu con le stelline del Sacro Monte.
Malosti. È un teatro non politico apparentemente, invece è altamente civile e politico perché ti insegna a guardare la realtà ed anche il tuo patrimonio, Testori parlava di radici espressive e penso che questo sia un termine bellissimo e noi dovremmo aiutare i nostri ragazzi a ritrovare le radici espressive che ci appartengono.
Soffiantini. Quando ci veniva a trovare a Forlì lui sempre voleva andare in pinacoteca, conosceva il direttore e la domenica mattina si faceva aprire per salire su a vedere i quadri di Cagnacci. Nella sala grande ci sono due grandi dipinti e lui si metteva a contemplarli, li conosceva a menadito ed era l’ennesima volta che andava a vederli. Noi eravamo un po’ perplessi, però ad un certo punto pensavamo che se aveva tutta questa dedizione a guardare dei quadri che conosceva da tanto tempo, allora anche noi potevamo cominciare a guardarli e guardando lui che guardava cominciavamo a vedere dei particolari. Lui ci spiegava tutto, però l’attacco era quello.
Shammah. Non solo devi guardare, ma vedere. Non guardi, veda – mi diceva.
Malosti. Mi è dispiaciuto che Testori non sia venuto a vedere lo “Spanzotti”, perché io ho trovato un coro popolare e quando i quaranta coristi hanno attraversato la chiesa francescana, lungo questo doppio spazio, uno per i frati ed uno per i fedeli e sono passati vicino agli affreschi, mi sono detto che erano loro, avevano quelle facce e quindi la concretezza, la realtà. È qualcosa non facilmente descrivibile, ma che esiste.
Shammah. Tre piccoli dettagli, due sono piccoli episodi molto divertenti. Nell’”Ambleto” noi avevamo il letto della regina che era fatto da delle conigliere e quando siamo andati a Roma al teatro Eliseo invitati da Romolo Valli, abbiamo portato i conigli, i pulcini, il fieno dove dormiva lei, insomma c’era di tutto, poi abbiamo recitato l’”Ambleto” con l’odore di merda, perché volevamo far capire che rappresentava la materia, abbiamo voluto dipingere il muro del teatro, appunto una provocazione, come vi dicevo, poi abbiamo fatto il “Macbetto” e poi l’”Edipus”, che era contro il compromesso storico. In quel periodo hanno trovato il cadavere di Moro, per cui era d’attualità, di piena rispondenza con la realtà.
C’era in sala Pertini e Franco Parenti, che faceva lo scarrozzante, ad un certo punto pronuncia la parola “spettaculanti”, poi esce di scena e sembra che non voglia più recitare perché ha troppo dolore. Ritorna e dice:” Spettaculanti vi domando perdono”. “E noi non ti perdoniamo!” Tutto il pubblico urlava e strappava gli abbonamenti. Allora ho chiamato Valli e gli ho chiesto perché ci avesse invitato. Era stato uno scandalo, non ci lasciavano andare avanti, Pertini è intervenuto per difendere Franco. Valli ha risposto che l’aveva fatto proprio per questo, per svecchiare il pubblico. Allora ho pensato che usando Testori in un attimo ho cambiato il pubblico all’Eliseo.
Racconto un altro degli episodi, prima parlo di quelli leggeri poi faccio il finale, il mio finale, perché è un’immagine che non posso dimenticare. È giusto condividere questo momento molto importante e divertente perché anch’io ho recitato un giorno a Brescia. Addirittura c’era Emanuele Severino in sala che poi è diventato un amico. Luisa Rossi era una gigantesca attrice che ha fatto la regina dell’”Ambleto”, quella del “Macbetto”, però aveva bevuto e non poteva entrare in scena, barcollava. Io ero a Brescia quel giorno, avevo seguito la compagnia. Siccome Luisa Rossi non aveva molta memoria io avevo studiato con lei per farle imparare la parte, quindi eccezionalmente la sapevo anche io, così d’accordo con Franco entro in scena, dovevo fare la regista che legge, solo che in “Macbetto” la lady comincia leggendo la lettera e io, da regista deficiente, siccome sono degli Scarrozzanti, ho pensato che lei entrava in scena e leggeva la lettera, ma le mancavano gli occhiali: una trovata registica.
Prendo il testo e vado a cercare la luce per leggere fingendo grande difficoltà. Sento il gelo in sala e allora alla fine della lettura butto via il libro e dico la famosa battuta: “Ti mostrerò come il poteraz tira la figa come e più del caz”. A questo punto gli spettatori applaudono, perché non leggevo più, erano salvi. Poi ho ripreso il libro e ho letto tutto il testo fino alla fine e siamo arrivati in fondo.
L’episodio che non posso non raccontare riguarda l’ultima volta che Testori è venuto a vedere lo spettacolo durante “La Maria Brasca”, che non aveva ancora visto, era in ospedale ed è arrivato con Riccardo Bonacina. Ci sono delle coincidenze magiche, che non sono coincidenze. Quella domenica pomeriggio non sapevamo quando sarebbe venuto Testori, fra il pubblico c’era un gruppo di Novate Milanese, dove Testori è nato, dove ha vissuto la sua famiglia e dove c’è casa Testori. Alla fine, lui era molto magro, ci sono le foto di quel momento, viene sul palco e pensando di dedicare a Franco Parenti un inno alla città di Milano che c’è ne “I Promessi sposi alla prova” quando padre Cristoforo parla appunto di Milano, prende il suo libro, pensa a Franco Parenti che nel frattempo era morto e gli dedica questo inno non rendendosi conto che mentre leggeva tutti sapevano che stava male e si vedeva anche moltissimo. Apre il libro e legge:” Città culla, città bara dove riposeremo un giorno la nostra stanca testa”. In quel momento è successa una cosa che rende il teatro incredibile, c’è stato un grande silenzio, lui stesso non riusciva ad andare avanti perché eravamo tutti con lui. Che cos’è una comunità, che cos’è il teatro? Lui è arrivato in fondo, c’era silenzio, non si riusciva neanche ad applaudire e quel silenzio, io lo dico spesso, anche se c’è stato un boato alla fine, era appropriato, al contrario dell’applauso che disturba qualcosa che è successo. Allora questo episodio lo racconto perché fa capire che cos’è stare insieme. Lui non si aspettava il fatto di stare leggendo qualcosa che lo riguardava, voleva fare un omaggio a Franco Parenti, ma in verità è stato un saluto che ha fatto lui sia alla sua città, Novate, sia al nostro teatro, perché poi è tornato all’ospedale e non è mai più uscito. È stata questa la sua ultima uscita. Questo credo sia il messaggio più importante per non prendere sottogamba il valore del mestiere che abbiamo, per prenderlo sul serio.
Frangi. Grazie a tutti per questo incontro. Come presidente dell’associazione Testori tengo anche a ringraziare il Meeting che ha voluto ricordare in maniera così intensa, così vera questo centenario di Testori con questi tre incontri e con lo spettacolo di Valter.