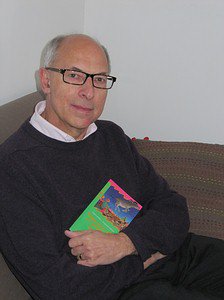Chi siamo
LA POESIA METTE A FUOCO LA VITA. READING DI POESIE
La poesia mette a fuoco la vita. Reading di poesie
Partecipano: Ángel Guinda, Poeta; Gianfranco Lauretano, Insegnante e Poeta; Jean-Pierre Lemaire, Poeta. Introduce Davide Rondoni, Poeta e Scrittore.
LA POESIA METTE A FUOCO LA VITA. READING DI POESIE
Ore: 11.15 Sala Neri GE
DAVIDE RONDONI:
Buongiorno e bentrovati. Spero che la poesia alle 11.15 di mattina sia un buon modo per iniziare la giornata. Siamo qui con tre poeti, tre amici. Come titolo ci siamo dati: “La poesia mette a fuoco la vita”, un’espressione che mi capita di usare spesso. Perché se è vero ciò che il Meeting sta dicendo in modo forte e chiaro – tanto è vero che, se prendete oggi il Corriere della Sera, una firma importante della cultura italiana, Claudio Magris, si confronta con il tema che il Meeting ha posto -, se questo tema sta incontrando gli interessi di tanti, anche diversi e dalle posizioni più varie, la poesia porta con sé, in maniera inevitabile, questo aspetto, che la natura dell’uomo è rapporto con l’infinito. Non ci sarebbe poesia se la natura dell’uomo non fosse rapporto con l’infinito. Non sarebbe arte, proprio perché l’arte, e la poesia in particolare, è il gesto con cui l’uomo cerca di comprendere che cosa sia questo rapporto con l’infinito, cerca di vederlo, di toccarlo, di seguirne il movimento, perché è un rapporto, una cosa viva, sennò non sarebbe un rapporto. Un rapporto non è un bastone di legno che ti congiunge da un posto all’altro, quello non è un rapporto! Un rapporto è un legame, una cosa viva, cioè una cosa che devi comprendere tutti i giorni. E la poesia fa questo: cerca di comprendere tutti i giorni cos’è questo rapporto della natura nostra con l’infinito. E lo fa per la sua stessa esistenza. Pensate che in questo Meeting si parla di tante cose: l’economia, la politica, la società; e poi c’è anche la poesia. E uno dice: “Cosa c’entra la poesia?”, che è come dire: “Cosa c’entra la poesia col mondo?”. Anche prima, una gentile Giada che mi ha fatto un’intervista mentre entravo mi ha fatto una domanda che mi fanno sempre tutti: “Ma la poesia, al giorno d’oggi, cos’è?”. Perché uno se lo chiede: ma la poesia, se tutto il resto è chiaro e normale che ci sia, perché c’è? E’ una domanda comprensibile, anche se fa sempre sentire un po’ un coglione chi scrive poesia. Tutto il resto si capisce, l’economia, la politica, i soldi: ma la poesia? Per la loro stessa esistenza, la poesia, l’arte sono un segno che la natura dell’uomo è rapporto con l’infinito. Perché tutte le altre cose che si occupano del finito non bastano, ci vuole anche qualcos’altro.
Quindi, per la sua stessa esistenza, per il fatto stesso che c’è, per il fatto che nel lavoro della poesia quello che si fa è mettere a fuoco la vita fino a vederne sempre, qualunque sia la posizione da cui parte questa messa a fuoco – una posizione scettica, una posizione esplicitamente religiosa, una posizione disperata – che cosa sia questo rapporto che ci costituisce. Com’è fatto, che cos’è, come vive. L’ho sempre trovato in tutti i poeti. Infatti, mettono sempre in questione il rapporto tra qualcosa che è finito e qualcosa che finito non è. E non si tratta solo della esistenza come messa a fuoco, lo fa la poesia ma anche la natura stessa del suo lavoro. Perché chiunque di voi scriva, o legga, sa bene che il lavoro con le parole è per natura stessa un problema di rapporto tra ciò che è finito e ciò che è infinito. Voglio dire che un poeta fa proprio questa esperienza: prova a mettersi in rapporto con un significato, e il significato è una cosa infinita, il significato è una cosa a cui i segni tendono. Quindi, è infinito, il significato. Ma lo fa attraverso un lavoro con delle cose finite che sono le parole. E la poesia nasce sempre in questa tensione, in questa scintilla, in questo dramma, tra una cosa finita che è una parola: perché le parole sono dei corpi, hanno una storia, hanno un significato loro limitato, hanno una vita, hanno un cambiamento. Le parole sono come dei corpi, non sono infinite. Le parole sono finite. Pensate che sono talmente finite che bisogna tradurle da una lingua all’altra, come faremo oggi. Sono talmente limitate, le parole, che non passano da una lingua all’altra. La traduzione è il segno del limite, è il segno della nostra natura. Ma il lavoro del poeta è esattamente il lavoro tra questo limite, le parole, e l’infinito del significato delle cose. Per questo, come natura, come lavoro e anche come tecnica, come arte, la poesia porta dentro questo problema di un rapporto tra il finito e l’infinito. Questo naturalmente non rende di per sé i poeti più avanti degli altri nel problema che il tema del Meeting pone, cioè non rende moralmente i poeti più avanti. Ma è come se li rendesse più sensibili, più feriti, più attaccati, più ammaccati, più vivaci su queste cose.
Era solo per introdurre i nostri amici, che ringrazio molto di essere qui. Loro parleranno e leggeranno. È un momento anche di ascolto, quello di oggi, non di parole perché la parola della poesia non è un discorso, non la si ascolta: quindi, è un momento di ascolto un po’ diverso dagli altri che faremo oggi. E anche dagli altri momenti in cui c’è la letteratura e la poesia in scena o in parola, qui al Meeting. Li presento brevemente nell’ordine in cui parleranno. Il primo è un italiano, sembra un po’ una barzelletta, c’è un italiano, un francese, uno spagnolo… Il primo è un italiano, che è anche un mio caro amico, Gianfranco Lauretano. Ha pubblicato molti libri di poesia, gli ultimi due sono: Occorreva che nascessi per Marietti e Racconto la Riviera per Raffaelli. È un critico militante nel senso alto della parola, cioè uno che si dà da fare perché la poesia venga conosciuta, studiata, diffusa. Guida e dirige la rivista ClanDestino che abbiamo fondato insieme, anzi, lui è l’inventore del nome, mi ricordo che eravamo nel giardino della casa di un nostro amico di Forlì, vent’anni fa. Non sapevamo come chiamare questa rivista che dovevamo fare e ad un certo punto, non mi ricordo se annebbiato dall’alcool o dal sole, Lauretano, come parlando da solo, disse: “Chiamiamola ClanDestino!”. Al che, eravamo tre o quattro tutti amici abituati ai suoi vaneggiamenti, gli diciamo: “Cosa stai dicendo?”. Invece, aveva trovato il nome giusto, che infatti c’è ancora. L’ha inventato lui e lo ringrazio per quello e anche per tante altre cose della nostra vita. Ha pubblicato un bel libro che vi consiglio di leggere, La traccia di Cesare Pavese, per Rizzoli. Dirige la collana di poesie per Raffaelli e sta lavorando a un prossimo libro, sempre per Rizzoli, nella collana che dirigo, su Clemente Rebora. Dopo di lui parlerà Jean-Pierre Lemaire, alla mia destra, francese. Insegna lettere classiche a Parigi, nei licei e nelle scuole superiori, nelle Alte Scuole universitarie. Ha passato l’infanzia nel nord della Francia, ora sta invece a Parigi da tempo, con la sua famiglia. È uno dei più importanti poeti francesi. Ha pubblicato molti libri, ha vinto i premi più importanti tra i quali il grand prix de poésie de l’Académie française. Ha pubblicato molti libri tra gli editori più importanti in Francia e con Gallimard, che è il suo editore, ha fatto recentemente un libro che si chiama Figure humaine e Marcher dans la neige, che invece è una riflessione sulla poesia. Lo ringrazio molto di essere qui. È un amico, da tempo amo la sua poesia che ho tradotto in un libro uscito in Italia per Edizioni Meridiana. Ángel Guinda è nato a Saragozza ma vive a Madrid, anzi, nel cuore di Madrid, nel quartiere, nel barrio più multiculturale e multi-incasinato di Madrid. Ha vinto i più importanti premi di poesia in Spagna. È autore di un manifesto di poesia che ha un titolo molto simpatico, si chiama: “Poesia util”. Ha scritto un bel saggio che si chiama: “El mundo del poeta, el poeta en el mundo”. Insomma, ha pubblicato molte poesie che sono state tradotte da poco anche in Italia da Gloria Bazzocchi, che spero sia in sala e che dopo ci venga a salutare, una brava traduttrice e studiosa di letteratura ispanica. Iniziamo con Gianfranco Lauretano.
GIANFRANCO LAURETANO:
Ringrazio Davide Rondoni, della presentazione e dei vaneggiamenti, che ovviamente smentisco. Volevo anche tranquillizzare gli amici stranieri perché nelle barzellette italiane chi fa la brutta figura è il tedesco: e non l’abbiamo invitato apposta. Prima di leggere qualche poesia, come da programma, volevo dire due parole che coincidono abbastanza, come sempre mi succede, con quello che ha detto Davide introducendoci. E lo faccio citando due poeti, ancora due poeti che vogliono essere un’indicazione di lettura e anche di scoperta, uno straniero e un italiano. Il poeta straniero che vi cito è un poeta russo, così finiamo l’Europa, Osip Mandel’štam che, a proposito del tema di oggi, diceva delle cose molto interessanti. Osip Mandel’štam è un poeta che ha pubblicato la prima raccolta nel 1913, quindi prima della Rivoluzione russa. E l’altro poeta che vi citerò è invece italiano, è stato ricordato da Davide, quello su cui sto lavorando, Clemente Rebora. Un poeta molto più importante di quello che si sappia in giro: ad esempio, in Montale ci sono centinaia di ricorrenze lessicali e linguistiche che vengono da Clemente Rebora. Stranamente – me ne sono accorto dopo -, entrambi questi poeti, Mandel’štam e Rebora, esordiscono nel 1913. La prima raccolta di Mandel’štam si intitola La Pietra, quella di Clemente Rebora, Frammenti Lirici. Siamo in epoca simbolista, detto molto velocemente, forse semplificando troppo: come avete visto dal programma, io sono insegnante, quindi abituato a parlare a gente che si affaccia come novità anche alla letteratura. Il simbolismo ha due scopi: quello di far coincidere arte e vita e, direi, più la vita all’arte che il contrario. In questo rovesciamento sta la sua – cito un altro poeta, Pasternak – acquosità, la sua palude, forse. L’altro grande equivoco del simbolismo è il fatto che la poesia sia un po’ come una religione e che quindi serva a far conoscere il mistero di Dio ma un po’ come se fosse appunto una religione e quindi il poeta un sacerdote. Le radici di questa posizione, la poesia e l’arte come religione, sono nel razionalismo, nell’illuminismo, in quel movimento che ha staccato il senso religioso dalla società, l’ha secolarizzata. Venendo a mancare questo, chi ha sostituito nell’ Ottocento, e ancora in tutto il Novecento, i sacerdoti? Spesso e volentieri, la tentazione, soprattutto degli artisti, è stata di avere i poeti come sacerdoti di una nuova religione.
Contro questo, Mandel’štam scrive un manifesto – era un’epoca in cui i manifesti si sprecavano, ricordiamo in Italia il manifesto futurista, che più o meno è proprio di quegli anni – in cui dice due o tre cose molto interessanti che vorrei citarvi. Innanzitutto, “la parola poetica è l’unione di molti elementi che ne costituiscono la particolare densità e il significato cosciente”, che lui chiama addirittura “logos”. “Soprattutto la parola poetica non ha valore in sé”. Ricordatevi questa frase perché è molto interessante, molto importante per quello che stiamo cercando di fare stamattina. Ma permette di accendere – c’è una frase bellissima che cito come virgolettato di Mandel’štam – “una gioiosa interazione con i propri simili, come le singole pietre in una cattedrale gotica”. Questo ci dice anche che cos’è la poesia per Mandel’štam, una cosa che assomiglia al costruire le cattedrali, che ha anche qualcosa di molto artigianale – contro una certa idea di poesia un po’ spiritata e spiritualista, in cui l’ispirazione ha avuto la maggiore -, il recupero del lavoro artigianale del poeta, quindi della riflessione instancabile, continua, profonda su quello che è la materia, le pietre, del poeta: le parole. Perché la poesia non ha valore in sé, non è una religione, non è un ente. Durante il ’900, anche in Italia si è rischiata l’entizzazione – scusate la parolona – della poesia. Mandel’štam direbbe: “La poesia con la p maiuscola non esiste”, è semplicemente l’unione di tutte le poesie che sono state scritte, e se si smettesse di scriverne, finirebbe la poesia. Perché non esiste l’ente poesia, esistono uomini che scrivono, che sono i poeti. E Luzi diceva che non è detto che scrivano sempre, non è detto che siano sempre poeti, perché non esiste neanche il poeta. Il poeta è quello che in quel momento, in quell’epoca della sua vita, scrive, ma in altre epoche non è poeta. E’ insegnante, idraulico, qualsiasi cosa possa fare un uomo per guadagnarsi la vita, anche perché con le poesie non ci si guadagna la vita.
Questo è molto importante perché è un equivoco ricorrente. Poi, in Italia questa cosa c’è stata, anche l’ermetismo non è esente da colpe, spesso anche nella sensibilità comune degli studenti, di chi vede nella poesia quella cosa difficile, un po’ ispirata, un po’ per addetti ai lavori. Ecco, questo è tutto ciò contro cui Mandel’štam, e umilmente io, accodandomi, ha combattuto, perché non è così. La poesia è un lavoro che ha molto a che fare con l’artigianato, l’artigianato delle parole, ed è una facoltà, un modo di guardare – a proposito del tema di stamattina – il reale con più intensità, scoprendolo. Innanzi tutto, dice ancora Mandel’štam in un’altra frase che dovremmo ricordarci: “Amate l’esistenza della cosa più della cosa in sé e il vostro essere più di voi stessi”. Ecco il più grande precetto di quello che era il movimento poetico a cui aderiva Mandel’štam, l’acmeismo: amare il fatto che le cose, la realtà, l’io esistano, più delle cose in sé. Il fatto che le cose ci siano, quello che qualcun altro ci indica come il “contraccolpo della realtà”, il fatto che le cose ci sono. Perché, dice Mandel’štam, da questo discende l’importanza fondamentale del rapporto tra poesia e mondo reale, il quale a sua volta è composto di fenomeni tutti ugualmente importanti, gioiosi o dolorosi, perché, per il fatto stesso di esistere, si oppongono al non essere, al vuoto, per il fatto stesso di esistere affermano l’essere. Questo è ciò che fa il poeta, stare di fronte a questo, scoprire questo contraccolpo del reale, secondo Mandel’štam. Il fatto che le cose ci siano, questa è la cosa più importante: amare l’esistenza della cosa più della cosa in sé, il vostro essere più di voi stessi.
Il secondo passaggio lo prendo da Rebora. La storia di Rebora assomiglia un po’ alla storia di Dostoevskij. Chi va a vedere la mostra qua troverà raccontato molto bene (l’ho visitata ieri ed è un bellissima mostra, che consiglio). Ad un certo punto, ci hanno detto che la storia di Dostoevskij ripete un po’ la storia della Russia, che è una storia di grande spiritualità nell’Ottocento, poi di immediato e traumatico allontanamento da questa storia, la Rivoluzione e gli anni della dittatura, e poi un lento riavvicinamento contemporaneo, dei nostri giorni, alla tradizione spirituale che c’è stata in Russia. Così come è successo in Dostoevskij, un brusco allontanamento, l’adesione anche ai movimenti rivoluzionari di fine ’800, la prigione, e poi un riappropriarsi e un raccontare questo, attraverso la sua opera. E’ ciò che succede anche a Rebora, che parte da una cultura post-risorgimentale, laica, laicista, di famiglia, poi ha il grande dramma della guerra e soprattutto le grandi domande e la grande attesa (noi conosciamo bene Dall’immagine tesa di Clemente Rebora, che è la poesia dell’attesa per antonomasia), infine l’avvicinamento alla fede fino all’entrata nei rosminiani, alla vocazione sacerdotale. In un verso, lui dice: “a verità condusse poesia”. Cioè, il primo passaggio per arrivare alla verità è stata la poesia. Anche la poesia scritta prima della vocazione, prima della conversione. E infatti, nella primissima poesia della prima raccolta, quei Frammenti Lirici, lui dice, nel Frammento 1: “Vorrei palesasse il mio cuore nel suo ritmo l’umano destino. Qui nasce, qui muore il mio canto”. La poesia non serve a se stessa, la poesia non serve a diventare la poesia con la p maiuscola, l’ente, non è quello il punto. Il punto è l’umano destino, ciò che noi siamo e ciò a cui siamo destinati, la nostra grandezza. E questo la poesia deve dire. “Qui nasce, qui muore il mo canto” dice Rebora. Tant’è vero che in una delle ultime poesie, quando è arrivato a quella verità e a quel destino che ha cercato, lui dice in un verso: “santità soltanto compie il canto”. Il canto è la poesia. Solo la santità compie la poesia.
Ecco, queste sono due esperienze, due poeti, due grandissimi (il mio modesto parere è che Mandel’štam è il più grande poeta del ’900 di tutto il mondo, Rebora è un grande poeta italiano, più grande di quello che ancora sappiamo ma pian piano sta venendo fuori). E tutti e due ci hanno detto questo, ci hanno detto che la poesia non è in sé valida ma per ciò che dice del destino, del mistero, di ciò che è poi la legge della vita, ciò che accade in continuazione nell’esperienza di tutti, che sembra accadere secondo una volontà che non è la nostra, l’“imprevisto”, per citare Montale. È quello che la poesia insegue, quel nucleo di mistero che c’è nella vita e che è il fondamento vero della realtà, anche se mai completamente raggiungibile. Ieri, nel suo bellissimo messaggio autografo, Benedetto XVI si domandava: ma insomma, questo infinito che non riesco mai a raggiungere, non è una cosa sbagliata, in un certo senso? No. Perché in continuazione ci spinge, per citare una cosa che noi crediamo di Montale e invece è di Rebora, a vedere che “ogni cosa porta scritto: più in là”. Rebora lo dice nel 1913, Montale solo negli Ossi di Seppia nel 1925, però quella citazione è di Rebora. Non vi volevo smontare Montale, è bravo! Però poteva riconoscere il suo debito. Montale non dirà mai che aveva letto i Frammenti lirici.
Leggo due tre poesie perché l’ho fatta troppo lunga e non voglio togliere spazio agli amici stranieri. Il Racconto della Riviera, che Davide ha avuto la gentilezza di citare, è un racconto in versi, un genere molto difficile, raccontare in poesia, il poema, che è parte così importante della nostra tradizione ( la Divina Commedia, l’Orlando Furioso, La Gerusalemme Liberata, ma anche Il canto notturno di Leopardi, le grandi opere della nostra tradizione sono poemi. Poi, all’improvviso, nel ’900 ci siamo messi tutti a scrivere liriche, solo liriche, siamo seppelliti dalle liriche). Ho provato a riscrivere un poema, solo che l’epica ha bisogno di un fatto importante, epico, da raccontare: e questo era il vero problema. Cosa abbiamo in Italia di epico da raccontare? Non volevo fare l’epica sulla mafia o sul terrorismo o sulle solite cose. Allora, ho raccontato un’epica (io sono romagnolo) più vicina. Ho raccontato la storia di un branco di ragazzi e tutto ciò che combinano durante una notte sulla Riviera, racconto della Riviera. La discoteca, la droga, le botte con le altre bande, queste cose qui. Uno di questi ragazzi, però, Marco, ha conosciuto una ragazza che poi se n’è andata perché è morta: questa ragazza, la sua morosa, finché la conosceva, gli faceva le domande. Non accettava che le cose avvenissero perché devono avvenire, neanche l’amore. Perché anche l’amore, come la poesia, non ha valore in sé. Amore con la a maiuscola non esiste, non è neanche quello lo scopo della vita, nessuna delle cose che esistono. Ricordate Eliot, Assassinio nella cattedrale: il quarto tentatore dice che neanche il diventare santi è il Mistero, è l’infinito, neanche quello. È la tentazione più strana che sia stata scritta nella letteratura mondiale, però non c’è nulla con cui l’infinito, se è infinito, coincide definitivamente. Siamo sempre rilanciati in questo. Quindi, Chiara, la morosa di Marco, quella il cui ricordo lo tira fuori, in questo racconto che ho scritto, gli faceva le domande e aveva questa posizione. Vi leggo Chiara, che ho scritto e di cui poi mi sono innamorato quando ho riletto quello che ho scritto. Vi lego qualche pezzettino, è difficile leggere un poema tutto intero.
“Chiara ha occupato la ragione di Marco per giorni e giorni, uno strano amore sgorgato vicino alla chiesa, una porta chiusa che Marco non apriva. Chiara, Chiara, incomprensibile, cristiana, lontana, vicina come Dio. Le sue domande, le questioni inaudite di nebbia, cosa sono Chiara le domande? E perché non posso toccare senza bruciarmi il cuore, il corpo tuo pungente, più lucente dell’ombra, luce mai vista e faticosa? Una sera parlarono ore. Gli occhiali di Chiara riverberavano, un lampione mandava un riflesso che la riassumeva, una tenerezza come un abbraccio attorno. Cose mai sentite prima o dopo appoggiate allo scooter, come loro. Da quella sera il branco assomigliò ad una prigione e avevano solo parlato. Nel lampione una premura, nel riflesso che scendeva come un sole sul viso di ragazza comparsa a mostrare un miracolo. Chiara non era perfetta neppure per se stessa, era bella ma non si notava per strada. Bella a guardarla bene quando rideva di nascosto, come se sapesse cose antiche o ridacchiava delle amiche agitate per la partenza di Marco, i suoi atteggiamenti, dei musi se veniva messa in dubbio la durezza. E amava come fosse sempre innamorata. Amava libera come chi sa che l’amore viene da oltre un mare misterioso. Infatti per lei neppure l’amore era Dio. La vita dura e recente, la madre al lavoro, il padre lontano dall’altra ma insieme qualche maestro le suggeriva che Dio non si ferma mai e desidera e mette insieme il tempo dall’inizio di una storia di morte e risurrezione a imitazione di noi, cadenti e sorgenti”.
Poi confesso di aver scritto qualche lirica, ho tempo di leggerne un paio? Chiedo scusa per averle scritte. Da quel libro che ha citato Davide, Occorreva che nascessi: questa è per mia figlia. “Vedi occorreva che nascessi perché prima/c’era nel mondo un buco di parole/a chiederti dolorosamente/da essere senza fiato né voce/ da non sapere che eri tu/ che giochi e ridi di nascosto./ Tu così, tu figlia, eri tu che non c’eri./ In quel vuoto che non ricordo tanto era assurdo,/ che non mi figuro più come se fossi qui da sempre./Tu che ci sei sempre stata”. E l’ultima, sempre su questo tema, sul fatto che ogni cosa è infinita, richiama all’infinito. Anche una figlia e anche una moglie. “Il tuo corpo come un fiore raro, una chiesa pronta per la liturgia, campo di un gioco infaticabile, a ben vedere è dove accade tutto, dove risiedo davvero e dove mi trovo dopo lunghe veglie fredde e tanto lavorare. Il tuo corpo manda luce propria e tu non sei già più una donna ma fuoco e nube, occasione di vedere alla fin fine chi, insistente, vuole che lo veda”. Grazie.
DAVIDE RONDONI:
Ha fatto bene Gianfranco a ricordare, sulla scia di Mandel’štam e di Rebora, il fatto che non c’è niente, niente, toccando il quale tu possa dire: “Il mio cuore è pieno”. La Bibbia l’aveva detto, scrivendo che “l’uomo è un abisso che chiama l’abisso”. E quando si scrivono poesie o si arriva a fare questa esperienza, che è un’esperienza di bilico, perché il fatto che non ci sia niente, niente che sembra compiere il tuo cuore, si trasforma immediatamente in una tentazione del nulla. E chi non ha questa tentazione, non può scrivere poesie, non può vivere sensatamente. Chi non sente questa sensazione, non solo non può scrivere poesie ma non può vivere adeguatamente, umanamente. Un uomo che dicesse di non avere provato questa sensazione, sarebbe falso come un manichino. Per questo, quando dicono: “Che bello, scrivi poesie…”. Bello un corno! Il bello è leggerle, scriverle è un po’ un inferno. Perché scrivere vuol dire accettare continuamente questo livello del gioco, quindi anche questa tentazione. E il fatto che non ci sia niente che sembra soddisfare il cuore dell’uomo, quel niente che è proprio quello spazio tra la parola e il suo significato, perché nessuna parola è soddisfatta, fa sì che chi lavora con le parole lavora con l’insoddisfazione, con la materia strana che è l’insoddisfazione. Il fatto che ci sia questa esperienza è paradossalmente il più grande segno che qualcosa deve esserci. Ma è proprio un crinale sottilissimo – e i poeti che ha citato prima, Mandel’štam e Rebora sono maestri in questo -, in cui uno decide (è una decisione, non è un automatismo) da che parte volgere lo sguardo perché l’insoddisfazione può essere il più grande motore verso la ricerca della soddisfazione, oppure può essere l’imbuto in cui ti lasci andare. E così, anche la parola della poesia: pensate, il fatto che nessuna parola compia il proprio significato nella poesia, per cui non esiste la poesia ma esistono le poesie, e i tentativi che tutti fanno, o è l’inizio di una grande frustrazione o è la benzina di un grande lavoro. E questa è una decisione, non è una posizione automatica, questa o l’altra, e per fortuna ci sono grandi poeti che ci hanno fatto vedere questo. E Jean-Pierre Lemaire, secondo me, è uno di questi.
JEAN-PIERRE LEMAIRE:
Grazie, Davide, per questa presentazione. Da tre anni cerco di imparare l’italiano ma evidentemente non ho fatto progressi tali da potervi parlare direttamente. Gianfranco ci ha parlato di Mandel’štam, quanto a me vorrei cominciare con un altro grande poeta russo, amico di questi, Boris Pasternak, autore de Il dottor Zivago. Nel 1917 Pasternak viveva gli albori della rivoluzione russa, ma anche una grande storia d’amore. Vediamo cosa ci dice: “Non riconosciamo più la realtà, ci sembra apparire sotto una nuova forma e questa forma, che le è inerente, è distinta, diversa dal resto. Tutto al di fuori di questa qualità, ha già un nome: donne, treni, alberi… Solo lei non ha un nome e noi cerchiamo di darle un nome”. E così comincia la poesia. Credo che se la natura dell’uomo è rapporto con l’infinito, l’infinito si manifesta in sé e nella realtà attraverso questa novità. Ecco perché all’inizio della poesia c’è l’ascolto di quello che cerca di nascere, di ciò che è nuovo, che ancora non ha un nome e che per questo motivo è fragile, difficile da sentire e ancora più difficile da dire. Questo ascolto è l’ascolto di un balbettìo che sentiamo nel cinguettìo degli uccelli all’alba, nel passaggio di un treno, nelle parole confuse di un immigrato che si presenta allo sportello della posta. Ecco quindi che la parola poetica non è primaria, è come il proseguimento di un’altra parola che, però, deve ancora nascere nei rumori, nei segni del mondo. Dunque, questa poesia non pretende più di correggere il reale, come si è stati tentati di fare, per esempio, all’epoca del surrealismo. Essa sposa, nel reale, il movimento della vita promessa. Ecco perché la poesia non è realista nel senso comune del termine, non imita la realtà, nel senso in cui la realtà è quello che già esiste. Sposa nella realtà il movimento segreto della vita promessa, della vita a venire, immersa nella tristezza, nel sonno, nell’indifferenza, la nostra indifferenza di tutti i giorni. Allora, come può far sentire la novità? Andando velocemente, andando piano. E questo forse è un po’ anche il suo handicap, perché oggi viviamo tutti in velocità, parliamo velocemente. E andando avanti troppo in fretta, trascuriamo quello che ancora deve nascere, tutto quello che è timido, tutto ciò che rimane al limitare del giorno. La poesia ci farà sentire il gemito del creato che sta partorendo, di cui parla san Paolo in una sua epistola. E quindi, grazie a cosa si manifesta questa novità? Si manifesta grazie ad una sorpresa, ad uno stupore, talvolta grazie a un dramma, che riescono a trafiggere il corsetto delle nostre abitudini. La poesia allargherà questa fessura, impedirà a questa finestra di richiudersi troppo in fretta: attraverso questo ascolto e questa parola, bisognerà riprendere il cammino della nostra crescita e anche della nostra nascita, entrambe interrotte. La poesia, quindi, ci dà gli occhi e le orecchie per aspettare ma anche per riconoscere questa nascita, una nascita che avrà luogo e avverrà soltanto se ci crediamo. A questo punto, vorrei leggervi qualche mia poesia, cercando di far capire e sentire questa nascita. Vedrete, un po’ dappertutto si parla di natura, di persone un po’ emarginate, di noi stessi, anche. La prima riguarda l’alba.
Traduzione della poesia letta in francese
“L’alba cosi stanca, che sorride invece di parlare, ancora una volta ha partorito il mondo, senza un grido, come imbarazzata di occupare tanto spazio, nell’indifferenza generale, quasi generale, eccetto gli uccelli e gli adolescenti che la guardano lungamente,
il mento tra le mani e tra i vasi di gerani e pioppi commossi, sognando di vedere
la loro nascita e già la loro prima paternità”.
La seconda poesia non è di stagione, perché siamo in estate. Si intitola Sera di marzo.
Traduzione della poesia letta in francese
“Impercettibilmente l’orizzonte sospira come un dormiente coricato sulla schiena, che si sveglierà da un momento all’altro. Gli alberi sanno una lingua imparata in tre giorni, ogni anno alla stessa ora, lo stesso silenzio bagnato affiora. Terra, questa volta la dirai la parola profonda che gonfia i colli: la tieni sulle tue labbra imminente, timida, ma oggi ancora, all’ultimo momento, mantieni il tuo silenzio davanti a noi, e il tuo mormorio nell’orizzonte si sente solo di profilo”.
Le prossime due poesie sono dedicate agli immigrati.
Traduzione della poesia letta in francese
“Quelli che non sono iscritti da nessuna parte guardano da lontano la città illuminata, i palazzi notturni come grandi stelle nere, coperti da una scrittura sconosciuta, di un alfabeto di fuoco calligrafato, rigoroso, indecifrabile. Piangono nel leggere tanto senza potere tradurre, mentre qui dentro, in noi, non c’è niente di scritto e tutte le pagine dietro la notte ridiventano bianche”.
La seconda poesia evoca l’immagine di uno di questi immigrati alla posta ed è intitolata Vaglia clandestino.
Traduzione della poesia letta in francese
“Davanti allo sportello si fermò intimidito, come alla penultima casella di un grande gioco della settimana. Aldilà, con le bilance, le ali, si passava il mare; lui non partiva. Fuori le macchine tutte gialle non prendevano le persone, soltanto le lettere, i vaglia, talvolta clandestinamente, l’ombra della loro mano destra”.
La prossima poesia racconta il mondo dell’ospedale ed è intitolata Il mondo in bianco. Traduzione della poesia letta in francese
“Dietro a un parco c’è un mondo con degli uomini, delle donne, dei pasti, dei sentimenti, ma la luce là è sempre la stessa e allora i malati passano la giornata nell’attesa dei colori del crepuscolo. La vita e la morte diventano trasparenti a forza di essere misurate, e quelli che possono attraversare i muri, tra i mondi, moltiplicati, sono tutti vestiti di bianco, razza divina, immortale, nel lampo dei sorrisi. Il pomeriggio nelle ore di visita, arriva anche la grande umanità. I rumori della strada rimangono nei loro capelli e si sforzano di accordare i loro gesti con lo spazio esatto della camera. Quando hanno finito di far uscire dalla borsa i fiori del giardino, le ultime lettere, nel silenzio maldestro, si operano le trasfusioni dell’anima”.
La prossima poesia ci parla della nascita delle cose, nascita che può anche diventare una risurrezione, che accompagnerà la nostra.
Traduzione della poesia letta in francese
“Le cose possono alzarsi quando si credono sole, o che risuscitiamo. Vicino alle scale la testa del cervo porta di nuovo fra le sue corna la saggezza del silenzio, come una coppa solenne che traboccava con la notte sui nostri libri, i nostri lenzuoli, i nostri visi. Indovini che i bicchieri stanno nel grande armadio impercettibilmente più dritti, come se riprendessero l’attesa. Contro l’imposta una rosa cresce, hai ritrovato la distanza, così lassù, dall’alto del sicomoro, Zaccheo vedeva la strada”.
E per concludere, tre piccole poesie. Una è sugli alberi.
Traduzione della poesia letta in francese
“Gli alberi rimangono sempre i nostri genitori e noi camminiamo accanto a loro nell’ombra e nella luce, mentre guardano un po’ più lontano, verso l’avvenire vicino, mormorando sul mondo al di sopra delle nostre teste parole ancora impercettibili”.
La prossima poesia evoca una nascita che avviene in noi, o piuttosto una rinascita, quella del bambino che non è cresciuto in noi e che può aprire gli occhi in occasione della preghiera.
Traduzione della poesia letta in francese
“Come l’ombra che si alza più piccola in mezzo alla fiamma, i bambini che non sono cresciuti pregano in piedi dentro noi e parliamo per loro con una voce un po’ più alta, facciamo gesti un po’ più larghi, che non converrebbero se fossimo soli, cosi che ci imitano lentamente, dall’interno e aprono un dito, poi due, dal piccolo pugno stretto”.
Cercherò di leggere l’ultima poesia in italiano: scusatemi se farò tanti errori di accento. Questa poesia ci parla di tutti coloro grazie ai quali possiamo rinascere: spesso sono gli altri che ci aprono una porta, una finestra, essendo loro stessi questa porta o questa finestra.
“I muri trovi un giorno degli uomini porta, uomini finestra, per i quali vedi il mondo, il paesaggio, e gli altri uomini così avvolti all’infinito. Mettendoti dietro di loro va a finire che seguirai senza saperlo un cammino in fondo al quale pure tu, forse, ti aprirai”.
DAVIDE RONDONI:
Molte grazie a Jean-Pierre. Quando ho tradotto queste poesie, mi sono accorto che era un grande poeta, e questa mattina ne ho avuto la conferma. Prima dicevo che è una decisione quello che fa muovere nella direzione della tentazione del nulla o della ricerca di qualcosa che esista, direbbe Caproni, che possa soddisfare il cuore. E uno può pensare: sulla base di cosa si prende una decisione del genere? E’ uno spunto casuale? O non è piuttosto, come ha detto prima in una sua bellissima espressione ripresa in un verso Jean-Pierre, che il problema è riprendere il cammino della nostra nascita? Perché la decisione circa la ricerca di qualcosa che soddisfi l’abisso del mio cuore, pur di fronte alla tentazione del nulla, è una decisione che si prende per fedeltà alle cose, per il fatto che le cose ci sono, che tu ci sei, che la realtà c’è. Si tratta quindi di riprendere il cammino della nascita, è questo che si oppone al nulla. È la ragionevolezza di riprendere il cammino della nascita che si oppone alla tentazione del nulla. La decisione è questa: riprendere sempre il cammino della nostra nascita. I poeti, se servono a qualcosa, servono a questo. La parola ad Ángel Guinda.
ÁNGEL GUINDA:
Bene, io oggi sono un uomo felice a Rimini. Domani non lo sarò. Come spagnolo, chiedo venia perché l’Italia è stata messa da parte dalla Spagna ai recenti campionati europei. Sono ben felice di essere al tavolo con i miei colleghi e con tutti voi. Vorrei ringraziare innanzitutto Manuele Masini, che ha tradotto in italiano Chiaro interiore, e Gloria Bazzocchi. Poi ringrazio, Claudio l’interprete che leggerà le poesie in italiano. Cinque poesie.
El mar.
Mi cabeza es un mar rodeado de montañas
donde ruge el silencio y las nubes reposan
como gaviotas muertas. Mi cabeza es un mar
entre andamios de niebla, o la gran polvareda
de las demoliciones. Mi cabeza es un mar.
Un mar cuyas ventanas tiemblan como relámpagos
y en sus olas retumba el eco de los soles.
Mi cabeza es un mar de enrona y laberintos
donde agitan sus crines los caballos del aire.
Mi cabeza es un mar, y en sus puertos en llamas
atracan los volcanes, los recuerdos zozobran.
Mi cabeza es el mar de las detonaciones,
los tambores de humo del adiós y sus ruinas.
Mi cabeza es un mar o el libro de registro
de los derrumbamientos, los escombros del cielo,
los tesoros perdidos. Mi cabeza es un mar.
Mi cabeza es un mar sobre el que las estrellas
fugaces desparraman tormentas de placer.
Mi cabeza es un mar de emboscadas y túneles,
avalanchas de luz y sed resquebrajada.
Conmoción de lo inmóvil, mi cabeza es un mar.
Mi cabeza es un mar en cuyo fondo claman
los suicidas del agua, los barcos y aviones
acribillados por el horizonte.
Mi cabeza es un mar, y en sus playas los niños
juegan a ver caer caramelos de fuego
de las guerras de un mundo donde no está mi mundo.
Mi cabeza es el mar donde yo he naufragado.
Traduzione
Il mare.
La mia testa è un mare circondato da montagne dove il silenzio ruggisce e le nuvole riposano come gabbiani morti. La mia testa è un mare fra ponteggi di nebbia o il gran polverone delle demolizioni. La mia testa è un mare, un mare con finestre che tremano come lampi e nelle sue onde rimbomba l’eco del sole. La mia testa è un mare di maceria e labirinti dove i cavalli dell’aria agitano le criniere. La mia testa è un mare e nei suoi porti in fiamme attraccano i vulcani, naufragano i ricordi. La mia testa è il mare delle esplosioni, i tamburi di fumo dell’addio e le sue rovine. La mia testa è un mare o il libro del registro delle demolizioni, le macerie del cielo, i tesori perduti. La mia testa è un mare. La mia testa è un mare di imboscate e tunnel, valanghe di luce e sete sgretolate, commozioni dell’immobile, la mia testa è un mare. La mia testa è un mare nel cui fondo reclamano i suicidi dell’acqua, le navi, gli aerei crivellati all’orizzonte. La mia testa è un mare e nelle sue spiagge i bimbi giocano a veder cadere caramelle di fuoco delle guerre di un mondo, dove il mondo non c’è. La mia testa è il mare dove io sono naufragato.
No
Soy un claro interior, el porvenir
de una puerta que siempre está atrancada.
La trampa de vivir y ver morir.
Contra la destrucción de la conciencia
bramo, reviento, clavo en Dios los codos.
Soy un zarpazo roto de paciencia.
Una luz que, arañando los escombros,
borra la niebla y sigue hacia adelante.
Un hombre con la sombra hasta los hombros.
Como hambre y bebo sed con todos
los condenados a escarbar la nada.
Esto no es un poema, es un desplante.
Profundamente grito un no rotundo.
Yo no quiero vivir en este mundo.
Traduzione
No.
Sono un chiaro interiore, avvenire di una porta che è sempre sprangata, tranello di vivere e veder morire. Contro la distruzione della coscienza scasso e bramo, con Dio m’impunto. Sono un’unghiata rotta di pazienza. Una luce che graffia le macerie, spazza via la nebbia e segue avanti. Un uomo adombrato fino ai fianchi. Mangio fame e bevo sete con tutti i condannati a raspar niente. Questa non è poesia, è un affronto. Grido profondamente un no rotondo. Perché non voglio stare in questo mondo.
La diferencia.
Todo armoniza por la diferencia:
el desierto de hielo, el árbol en la roca,
la suave furia del mar y las estrellas.
Nacemos transparentes como el aire,
nos volvemos opacos como el mármol.
Uno puede soportar tanto dolor
como placer es capaz de recibir.
Piedra, hierba, fuego, agua,
luz, tiniebla, tempestad de arena:
todo armoniza por la diferencia.
La ciudad, mientras duermes,
draga el silencio que todo lo hace nuevo.
Nadie tiene otra patria que su soledad,
nadie llega a nadie si no es para marcharse.
Tiene el amor en sus abrazos
el atroz método del amordazamiento.
Cuanto nos llena del otro nos vacía.
Nube, raíz, el canto de los pájaros:
todo armoniza por la diferencia.
Traduzione
La differenza.
Tutto si armonizza per differenza: il deserto di ghiaccio, l’albero nella roccia, la delicata furia del mare e le stelle. Nasciamo trasparenti come l’aria e diventiamo opachi come il marmo. Possiamo sopportare tanto dolore come piacere siamo capaci di ricevere. Pietra, erba, fuoco, acqua, luce, tenebra, tempesta di sabbia: tutto si armonizza per differenza. La città, mentre dormi, draga il silenzio che rende tutto nuovo. Nessun’altra patria se non la solitudine, nessuno è con nessuno se non per andarsene. L’amore porta in braccio l’atroce metodo di mettere il bavaglio. Ciò che ci colma dell’altro ci svuota. Nube, radice, il canto degli uccelli: tutto si armonizza per differenza.
Adesso, una poesia di un solo verso che ci ricorda Ungaretti: Sentimento di perdita.
Si lo he perdido todo, ya soy un ganador.
Traduzione
Se ho perduto tutto sono ormai un vincitore.
Per concludere, la poesia che dà il titolo al libro, Chiaro interiore. C’è un aneddoto che si riferisce ai primi due versi che parlano della morte che ho conosciuto sin dall’inizio, è un ricordo di mia madre che è morta dandomi alla luce.
Te reconozco, trance de esta hora.
Te he conocido desde que nací.
Tienes los ojos de la lejanía,
la almendra amarga de la soledad.
El cielo es grande porque nos contempla.
Me fatiga subir a la montaña
para aplacar mi sed de infinito
y atar las llamas del amanecer.
Me hace temblar la tralla del relámpago
apedreado por la realidad.
Sólo tú haces que yo siga vivo.
Eres la puerta que esperó mi llave:
cuando la abra, ¿qué me encontraré?
El tiempo es una sombra que todo se lo traga.
Y el espacio, la inmensa transparencia
que no me deja ver la intensidad
de este instante después de haber vivido.
Después de haber vivido, ¿cómo vivir ya más
si he dado incluso lo que no tenía?
Del aire vive el aire; y la luz, de la luz que lleva dentro;
agua es el agua en nube, río, mar.
Y aunque la vida siempre para la muerte vive,
y nada más que muerte hay en la muerte,
en la noche más noche brillan más las estrellas.
¿Qué miro que no veo sino al fondo
del miedo y del misterio?
Todo está claro ya en mi interior.
Traduzione
Ti riconosco, passaggio di questa ora. Ti ho conosciuto dalla mia nascita. Hai gli occhi della lontananza, la mandorla amara della solitudine. Il cielo è grande perché ci contempla. Mi affatica salire la montagna per placare la mia sete di infinito e legare le fiamme dell’alba. Mi fa tremare il sonaglio del lampo lapidato dalla realtà. Solo tu fai che ancora sia vivo. Sei la porta che ha atteso la mia chiave: quando aprirò, cosa mi starà aspettando? Il tempo è un’ombra che tutto inghiotte e lo spazio, l’immensa trasparenza che non mi lascia vedere l’intensità di questo istante, dopo aver vissuto. Dopo aver vissuto come vivere ancora, se ho già dato anche ciò che non avevo? Dell’aria vive l’aria; e la luce, della luce che reca dentro; acqua è l’acqua in nube, fiume, mare. E anche se la vita vive sempre per la morte, e non c’è altro che morte nella morte, nella notte più profonda brillano ancora le stelle. Cosa guardo se non vedo se non nella paura e nel profondo del mistero? Tutto è ormai chiaro nel mio interiore.
DAVIDE RONDONI:
Ha detto poco fa, in un bellissimo verso: “Tutto si armonizza per differenza”. Perché l’armonia della vita non è un mare piatto. L’armonia dell’esistenza non è la mancanza di dramma. Il dramma è esattamente quello che accade nell’incontro tra le differenze. Ho scritto ieri, in una rubrichetta che faccio, che noi nel cuore abbiamo uno scontro, non uno scontrino. Cioè, abbiamo un cuore che è fatto di dramma, di differenza, di questioni, di domande aperte. Non a caso, anni fa, don Giussani, intervenendo qua al Meeting, disse: “Vi auguro una cosa, di non stare mai tranquilli”. Perché l’armonia non è la tranquillità. I poeti che abbiamo ascoltato ce l’hanno ridetto, ce l’hanno fatto sentire. Io vi invito quindi anche nei prossimi giorni a sfruttare gli appuntamenti di poesia, di letteratura che ci sono al Meeting, e ce ne sono tanti, li vedete nel programma. Concludo con la mia poesia Oceano cucina.
I
Verrebbe da dire: me la sono cavata,
fermo stanotte al tavolo della cucina
mentre qui intorno nelle migliaia di appartamenti
come in strani cunicoli sospesi per l’aria dormono tutti
e l’argento della pioggia finisce nel buio.
Verrebbe da dire:
me la cavo con l’affitto e sorrido ai miei debiti, ma
cos’è ancora questo vino luminoso
e viola sangue che mi esce tra i denti,
le notizie come stelle terribili in mente
non si dissolvono i fantasmi d’amore seduti,
la luce sale, li sbianca, sono il viso
di donne, le mani di stracci, carta pesta
e amici che si voltano nell’acqua degli anni.
Il mio amore non sta ancora fermo,
mi alzo ed esco in terrazzo, il cuore è un puma
sulle alture, ho gli occhi di mio figlio,
stanotte é la prima notte del mondo.
II
Verrebbe da dire: me la posso
cavare. Ma una volta mi fermai
sul molo di Stone Island
in un mattino splendido, ghiacciato
nel mezzo della corsa
della mia esistenza e sentii
tutta l’oscurità del mare,
l’enigma, il suo respirare
che arriva in questa cucina, in una città
italiana, nel silenzio spogliato,
ed è il vibrare del frigorifero
a trovare la stessa nota dell’oceano,
la luce del video
acceso a nessuno
rende a queste stanze un chiarore di fondale.
Verrebbe da dire: me la sono
cavata, ma non è mai detto e non è
nemmeno giusto da dire
se l’infinito un giorno
e molti giorni in una vita
ti viene a visitare.