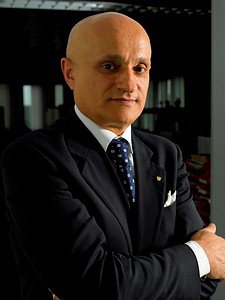Chi siamo
LA CRESCITA DEL CAPITALE UMANO: INTENZIONE O REALTÀ?
La crescita del capitale umano: intenzione o realtà?
In collaborazione con Unioncamere. Partecipano: Francesco Bombelli, Presidente Consorzio HCM, Milano; Manuela Kron, Direttore Corporate Affairs, Gruppo Nestlé in Italia; Umberto Vattani, Presidente ICE; Federico Vitali, Presidente FAAM. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Compagnia delle Opere.
BERNHARD SCHOLZ:
Benvenuto a Francesco Bombelli, Presidente del Consorzio HCM: lui stesso spiegherà poi quale sia la realtà che rappresenta. L’ambasciatore Umberto Vattani, Presidente dell’ICE, Istituto Italiano per il Commercio Estero, e Federico Vitali, Presidente della FAAM: anche per lui spiegheremo dopo cosa si intende con questa realtà. Mi permetto di fare solo una brevissima introduzione sul tema del capitale umano. All’inizio degli anni ’80, l’espressione capitale umano è stata classificata dall’Istituto per la Lingua Tedesca come la peggiore parola dell’anno. Lo dico perché su questa espressione c’è un grande fraintendimento: con capitale umano, per essere chiari, non si intendono le persone. Capitale umano è invece quell’insieme di conoscenze e competenze che una persona acquisisce durante la sua formazione, durante il suo lavoro. Perché è stata introdotta l’espressione capitale umano per parlare di competenze e di conoscenze? Se vi ricordate, fino alla fine degli anni ’70, gli unici due fattori essenziali di misurazione economica erano capitale e lavoro. E furono considerati, soprattutto il lavoro, come fattori immutabili, fissi. Invece si è constatato che la produttività di un’azienda, la sua capacità innovativa, dipendono, molto più di quanto si pensasse, dalle persone che ci lavorano, da un fattore fino ad allora in parte riconosciuto, in parte non riconosciuto, ma sempre più evidente nella sua forza propulsiva per il sistema produttivo.
L’espressione capitale umano è stata introdotta quando ci si è accorti che si trattava di un fattore misurabile. Sono nate allora le prime indagini che hanno iniziato a misurare: per esempio il sistema scolastico di una Nazione incide sulla produttività del Paese, la formazione che si fa all’interno di un’azienda incide sulla sua capacità produttiva. Quindi, l’espressione capitale umano è stata introdotta per dire: non esiste solo il capitale finanziario e la forza-lavoro tout court. Esiste un fattore che è completamente personale ma, al contempo, anche misurabile, non di per sé ma nelle sue conseguenze. Questa è stata la ragione per cui si parla di capitale umano, non perché la persona sia in qualche modo paragonabile al capitale finanziario, ma per la misurabilità degli effetti di un impegno della persona in termini di conoscenza e di competenza.
Questo incontro non vuole essere una riflessione teorica sul capitale umano: noi vogliamo presentare esperienze significative di come, all’interno di realtà molto diverse, sia possibile sostenere la crescita di una persona in termini professionali e umani, dopo che è finito il sistema scolastico e universitario e quando è già entrata nel sistema aziendale. Perché anche qua bisogna fare una breve riflessione: normalmente, si pensa che una volta che si ha il diploma, una volta che ci si è laureati, sia finito il percorso formativo. Invece no. Per tante persone, è proprio dentro la vita lavorativa che comincia un percorso di formazione interessante: oltre ai corsi specifici di formazione, ci formiamo proprio sul posto di lavoro, nel rapporto con i colleghi. Sono questi i percorsi formativi sul lavoro. Un secondo aspetto che emergerà anche oggi con chiarezza, è che occorrono certe condizioni, un certo clima, una certa disponibilità dell’azienda nei confronti delle persone, per favorire che la persona possa esprimersi al meglio, mettere in gioco i suoi doni, i suoi talenti. Una considerazione molto semplice: se un clima aziendale è mediocre o di basso livello, è molto difficile pensare che le persone diano il meglio. Sono fattori che incidono, direttamente o indirettamente, su ciò che chiamiamo capitale umano, ma che sono le competenze, le conoscenze e anche le esperienze che una persona acquisisce. Allora, io passerei per primo la parola a Francesco Bombelli, che nasce come professionista infermieristico all’ospedale San Raffaele: ciò che è successo dopo, ve lo racconterà lui. Grazie.
FRANCESCO BOMBELLI:
Grazie. Per me, per noi, questo è il quinto Meeting dove abbiamo la possibilità di portare qualcosa di nostro e di portarci a casa tanto di quello che qua si respira. Per entrare subito nel tema di oggi, questi cinque Meeting sono parte di ciò che è stata la nostra esperienza di crescita, di approfondimento, di condivisione del nostro capitale umano: nel 1994 eravamo in due, oggi abbiamo superato i 2.100. E vi assicuro che è tanto bello poter dire 2.100, ma è meraviglioso poter dire: eravamo in due, e quello che c’era allora con me, c’è ancora oggi. E’ una prima fotografia che voglio darvi. Posso dirvi con la massima consapevolezza che, per unire queste due parole, chiamiamole così, per adesso, capitale da una parte, umano dall’altra, non ho alcun dubbio che serva il cuore: l’ho provato proprio fisicamente, serve quello. Poi, qui tutto è molto più semplice, più facile, perché al Meeting il respiro del cuore lo si sente, e quindi ci consente di avvicinare queste due parole con meno fatica.
Il cuore quindi è sempre l’attore protagonista nel mettere insieme il nostro Paese e la nostra realtà economica: quella reale, va sempre più verso una prospettiva dove le imprese in crescita sono nell’area dei servizi. Nell’economia sociale di mercato, il lavoro arriva e arriverà sempre più da qui e questo richiede un approfondimento, perché nella nostra realtà chi intraprende nell’area dei servizi è visto ancora un po’ troppo da lontano rispetto alla realtà manifatturiera, che a volte diventa un pensiero abituale. In concreto, il futuro del nostro Paese, cioè il cuore del nostro futuro, è il capitale umano, la sua qualificazione, la sua capacità di aggiornamento, la sua crescita, appunto: scuola, ricerca, università, educazione permanente ai valori fondativi della nostra società, alternanza scuola-lavoro, innovazione tecnologica. Per innovazione tecnologica, intendo tutto quello che riguarda la globalizzazione delle comunicazioni. Attenzione, perché se la presenza educativa non sta sulla bilancia almeno quanto la libera fruizione, i disastri si vedono. Per tenere insieme tutto questo, credo ci vogliano due dighe invalicabili a chiunque e a qualsiasi cosa: spirito di libertà e rispetto della dignità umana. Dico questo perché certamente il campione, che significa poi la realtà, è tanto lungo quanto largo, e, usciti di qua, ogni giorno dobbiamo lottare per tenere questa rotta. Bertrand Russell diceva una cosa, un po’ stretta ma molto reale: il mondo va inevitabilmente verso il meglio o verso il peggio. Noi siamo tutti certamente impegnati verso l’evoluzione dell’uomo, non verso l’involuzione.
Perché ho detto questa cosa? Per tornare all’azienda, alle imprese che sono comunità di capitale umano, quindi gli eserciti più adatti e per natura idonei a combattere con il cuore questa conquista quotidiana di rispetto. Una cosa importante che ho imparato in questi anni è che noi imprenditori dobbiamo tenere conto che è da tempo superato il modello di azienda dove esistono gruppi di lavoratori incolti, ignari della propria cultura aziendale. A partire da chi si occupa degli ambienti, l’atteggiamento relazionale di condivisione non può certo essere dispari. Diverso, ma non dispari. Non esiste il capitale umano in natura. Il capitale proprio dell’uomo è il tempo, e allora, quando l’uomo spende il suo tempo e si identifica in un progetto, inizia l’esperienza del capitale. Per dare un senso alle cose che ho detto, vi racconto cosa è successo a me come imprenditore. Nel 2005 è accaduto che sono diventato Presidente di una cooperativa sociale tra le più storiche di Lombardia, tra le più storiche di Milano, una cooperativa che è nata nella seconda metà degli anni ’80 ed è stata tra le prime ad organizzare un’offerta educativa, man mano che l’ente locale cominciava ad affidare la domanda educativa a un terzo soggetto, a una cooperativa.
Devo dirvi che mi sono trovato in un disastro di ottima qualità: un’azienda che in pochi erano riusciti a stortare, rispetto al fatto che invece ce n’erano tantissimi che tiravano, che tenevano e ne erano veramente innamorati. Parliamo di un popolo di circa 600, 700 persone tra educatori, psicologi e coordinatori vari. Da una parte, mi sono trovato un conto economico che non teneva, uno sbilancio continuo, un deficit finanziario, i contratti presenti molto in perdita: la consapevolezza che cresceva in me era che non potevo cambiare nulla, nel breve. Potevo resistere e cominciare a conquistare il popolo, unica variabile per vincere e andare oltre gli incagli che vedevo all’orizzonte, e trasformarli. Qui mi permetto di fare una provocazione, trasformarli in capitale umano, perché allora il non-capitale dissestato era in sede centrale, ma fuori c’era questo meraviglioso esercito di umani, impegnati con passione a educare nel sostegno alla disabilità, nei media, nel doposcuola, nei centri disabili, nei centri ricreativi estivi, nell’azione educativa di strada, insomma in tutti gli angoli delle famiglie e tra tutti i tipi di marciapiede del disagio sociale.
Cambiare la qualità del fatturato, uscire senza strappi dai diversi contratti e lavorare per vincerne altri, portare in sede centrale, nel governo dell’azienda, alcuni di quelli che stavano fuori per condividere e affidare: tanto era il bisogno di costruire un organigramma aziendale – che vuol dire formazione, senso economico, efficientamento dei servizi, politica degli acquisti -, ma tanto era anche indispensabile costruire un organigramma familiare. Sì, familiare, sembra una parola semplice ma non lo è. Non sapevo da dove partire, poi mi sono fatto coraggio e sono partito da colui che quest’opera aveva iniziato. Oggi siamo una coppia direi abbastanza indistruttibile. Organigramma familiare, sì, indispensabile perché, per iniziare un percorso di identificazione e unificazione, di solidarietà verso questa cooperativa che mai era stata gestita così, per avviare quel processo verso il capitale umano, c’era bisogno di conquistare fiducia, attraverso relazioni di familiarità, perché la struttura era molto larga: 600 soci in 4 Regioni, affidati a 25, 30 coordinatori e supervisori vari. Trasversali tra il passato e il presente, verso il futuro.
Dico questo anche con una certa commozione, perché lì fu il passaggio più complicato ma fondamentale per il reset e il rilancio dell’esperienza. Perché poi è da quelle 25, 30 persone che io ho ricevuto il contributo di fiducia che mi ha dato le energie per dire “si va avanti”. Tenete conto che, avendo iniziato io quel percorso, avevo un certo numero di persone a cui fare cambiare strada, il popolo fuori che mi vedeva un po’ come: “Oddio, cosa sta succedendo?”. Ma per fortuna, capitale umano fuori, capitale umano dentro, i colleghi, capitale umano, e chi fruiva del nostro servizio, capitale umano, perché questa è un po’ l’unicità delle realtà che lavorano in questo ambito. Tu hai l’umano che fa e l’umano che riceve. Molte lacrime, che poi sono diventate una colla incredibile, però ogni volta che giravo nei servizi mi rendevo conto che era la mia strada, mi affascinava il fatto di aver scoperto un’azienda, chiamiamola azienda, che per mestiere dava un servizio essenziale: l’educazione.
Ma questo, lo devo dire in tutta onestà, coincideva col fatto che non potevo tornare indietro, tornare indietro voleva dire chiudere. Chiudere che cosa?, mi domandavo tutti i giorni. Sono quelle cose che quando chiudono non ne arrivano altre, di questo ho piena certezza. Ci sono esperienze imprenditoriali che sono uniche, non replicabili, ciò che fa unico l’uomo è proprio questo. E lì mi rendevo conto, giorno dopo giorno, che era così. Allora ho deciso – parliamo di un percorso che poi è durato due anni – di partire verso un lungo viaggio fatto di decine e decine di incontri, di colloqui di gruppo con persone, per cercare di vedere chi ci stava e chi non ci stava. È stato un lavoro durissimo, ricordo un momento che poi è stata la svolta negativa ma positiva, in un Consiglio di Amministrazione in cui ho detto ai miei Consiglieri che, oltre a tutto quello che stavamo già facendo, bisognava ricapitalizzare la cooperativa. Cosa che avviene raramente, nella storia delle cooperative. Ricapitalizzare vuol dire andare in Assemblea e chiedere ai soci di metterci dei soldi. Oltre a tutto quello che si sta facendo, l’azienda va ricapitalizzata perché il bilancio assume un’immagine diversa, c’è un rientro finanziario.
Io mi sentii dire da uno dei consiglieri anziani che, piuttosto che venire in Assemblea davanti a questi volti, lui avrebbe trovato un altro Presidente. Va bene, io sono andato avanti, in Assemblea ci sono andato, sono venute 350 persone e hanno votato la ricapitalizzazione. Da lì, abbiamo cominciato a rivincere, abbiamo perso, abbiamo rivinto, siamo passati da Monza, siamo arrivati a Novara, siamo arrivati a Salsomaggiore. E chiudo, dicendovi una cosa che è di un mese fa, e che sta nella ragione per cui credo non ci si possa tirare indietro, per la libertà del pensiero. Abbiamo fatto la chiusura dei centri estivi del Comune di Cologno Monzese, 600 bambini: io ero un po’ emozionato. Quando li ho salutati, ho chiesto loro se potevano farmi un regalo, guardarmi in faccia per tre, quattro, cinque secondi. Questi mi hanno guardato in faccia per cinque secondi, 600 bambini, 1200 occhi. Vi assicuro che è una grande ragione per non smettere di fare questo mestiere. Voglio dire al Presidente che bisogna continuare ad apprezzare, osservare, sostenere le realtà imprenditoriale in ambito sociale, sanitario ed educativo. Dico questo perché sono l’eccellenza del nostro Paese, ribaltano nella società il rapporto economia/lavoro, sono quelle attività produttive che tengono insieme due cose che non hanno tutte le aziende: servizi essenziali e certezze essenziali. Il mio cuore batte sempre in questa direzione e io lo seguo. Grazie.
BERNHARD SCHOLZ:
Grazie, Francesco Bombelli, e passiamo a Federico Vitali, che è Amministratore Delegato della FAAM, una società che produce batterie, si chiamano accumulatori, nel gergo più tecnico, comunque, batterie e autoveicoli elettrici. Tra l’altro, è la prima azienda in Europa che è stata certificata con la Certificazione Ambientale Emas: vuole dire che è un impegno che tiene conto di tutti i fattori. Faccio solo una premessa breve. Quando ho incontrato Federico Vitali, anni fa, la prima cosa che mi ha colpito è la grande valorizzazione dei giovani dentro la sua azienda. Ho già lanciato la provocazione.
FEDERICO VITALI:
Grazie, Presidente. Noi siamo un’azienda molto più terra terra rispetto a quella che mi ha preceduto. Noi produciamo, facciamo dei prodotti. E poi lavoriamo il piombo e altro, siamo arrivati a lavorare il litio, facciamo veicoli elettrici, ma facciamo anche i nostri uomini, il nostro capitale umano. Condivido pienamente quanto ha detto il Presidente. Il capitale umano è l’insieme di competenze, conoscenze, esperienze dell’uomo che lavora con me, che lavora insieme a me, che lavora nel nostro team. E’ una cosa personale, ma questo suo arricchimento fa crescere la nostra impresa. Senza l’arricchimento personale di questa persona, la nostra impresa non sarebbe tale. E allora siamo nati, così vi faccio capire un po’ la storia, in un paesino a 11 km di distanza, in linea d’aria, dalla Cassa per il Mezzogiorno. Chi è italiano, sa che la Cassa del Mezzogiorno significava avere l’80% di fondo perduto, quando era poco, perché poi si arrivava ad avere pure il 110%. Noi nasciamo 11 km fuori dalla Cassa del Mezzogiorno, e negli anni abbiamo avuto tante tentazioni, tanti ci hanno chiamato: ma spostatevi di pochi chilometri, siamo qui. Vi debbo dire molto francamente che ho avuto pure un’esperienza amministrativa importante, ho gestito, in quanto Amministratore locale, una fase della Cassa del Mezzogiorno.
Sono stato prima Assessore Provinciale, poi Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, ma non ho mai pensato di portare la mia impresa, l’impresa che ho fondato, altrove. Dico ai miei figli che sono qui in sala, che l’impresa è la nostra, in quanto abbiamo il dovere di curarla, ma è della società, l’impresa è della comunità, l’impresa è soprattutto dei lavoratori. Allora ci siamo dati una missione, siamo nati per contribuire alla crescita di un paese che stava morendo, aveva dato molto alla storia del Paese Italia, però stava morendo per effetto della Cassa del Mezzogiorno: 11 km a Sud, il polo calzaturiero, la Cassa del Mezzogiorno, 15 km a Nord. Questo paese in mezzo stava morendo. Facciamo qualcosa per vedere se possiamo lavorare qui, ci siamo detti: e oggi c’è un piccolo Gruppo, una multinazionale tascabile, con due stabilimenti a Monterubbiano, uno a Manfredonia in Puglia, uno piccolo in Uruguay ed uno importante in Cina. Per il gruppo FAAM, lavorano oltre trecento persone in Italia, oltre cinquecento in giro per il mondo. Questa missione che ci eravamo dati, l’abbiamo formalizzata all’inizio degli anni ’90, e l’abbiamo scritta: se andate nel nostro website la trovate, non ve la leggo, non vorrei farvi perdere tempo.
Ma quando ci siamo impegnati a scrivere quella missione, ci siamo posti tre domande. La prima era: si può crescere senza sentire il desiderio? Credo che queste domande siano molto legate al tema di oggi, “La crescita del capitale umano: intenzione o realtà?”. Un’impresa, se ha l’intenzione di far crescere il capitale umano e non la tramuta in realtà, non è un impresa: può essere un’attività economica ma dura poco. Quindi, la prima domanda era: si può crescere senza sentire il desiderio? La seconda è: il diritto è un diritto o un dovere? La terza è: cosa serve provare, verso il lavoro, per ottenere risultati eccellenti? A queste tre domande abbiamo cercato di dare delle risposte. Per crescere, bisogna prima desiderarlo, non ho visto mai nessuno che sia riuscito a crescere se non desiderava crescere. Non si può insegnare niente a nessuno, se non vuole imparare. Allora, come lo tramutiamo questo nel lavoro? Fin dalla fase di valutazione e di selezione delle persone che vogliono entrare nel nostro team, cerchiamo di capire i loro sogni per poi verificare se siamo in grado di far sì che possano realizzarli, perché la loro felicità, il loro completamento, sarà sicuramente il nostro successo. Quindi, nella fase di selezione delle persone vogliamo capire il loro sogno, per essere certi di contribuire alla sua realizzazione. Questo, poi, i tecnici lo chiamano “valorizzare le differenze”.
La seconda domanda sul lavoro: “diritto o dovere”? L’articolo 4 della Costituzione, nel primo paragrafo, dice testualmente: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Ma la seconda parte, che nessuno recita mai, dice: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Questa seconda parte, per noi, per me e per tutti i responsabili con me, è diventato un modo di pensare, quando siamo con i nostri lavoratori, i nostri uomini, il nostro capitale umano: “che cosa dobbiamo fare perché questo diventi un vero capitale umano?”. La terza domanda è: “Che cosa serve provare verso il lavoro, per ottenere risultati eccellenti?”. Anche qui, la frase non è mia ma è bellissima, “a me piace riscoprire l’amore per il lavoro”. L’ha detto un giorno un Arcivescovo, gli ho chiesto se c’era il copyright, mi ha detto di no e allora la uso da qualche anno. Perché senza amore per il lavoro non si va da nessuna parte.
Oggi ho avuto il piacere, assieme alla dott.ssa Kron, di essere a pranzo con il responsabile di una cooperativa sociale, il quale ci raccontava che stanno lavorando per recuperare i detenuti: “I lavori che fanno questi detenuti è apprezzato dalle aziende che ci danno lavoro perché, rispetto al lavoro che loro riuscivano ad ottenere dalla Romania, è assente una imprecisione: loro dicono che i nostri lavoratori detenuti fanno questo lavoro con amore”. E’ vero! Io la ascoltavo e mi dicevo che era una grande verità. A queste domande, quindi, ci siamo date risposte, e questo ha fatto maturare la convinzione che la questione sia culturale. E allora, se la questione è culturale, cosa possiamo fare? Come possiamo agire? Quando abbiamo steso la missione nei dieci punti che ci siamo impegnati a tenere ben presenti per esplicitare la nostra missione, quattro li abbiamo riservati al capitale umano. Per esempio, valorizzare e gratificare ogni persona che vuole mettersi in gioco e dare giorno dopo giorno il meglio di sé, nel conseguimento della missione aziendale.
Erano i primi anni ’90, quando abbiamo scritto queste cose, le hanno scritte i nostri uomini: io adesso me ne vanto un po’ ma lo hanno fatto loro, io ho dato solo il mio piccolo contributo. L’altro punto era creare con il lavoro giornaliero un’organizzazione di uomini che rimanga solida nel tempo, a favore della crescita e del benessere delle generazioni future. Sapete, uno dei nostri problema è che il 97% delle imprese alla terza generazione fallisce. Allora, se è vero che un’impresa è un bene della società, bisogna creare le condizioni perché questa non fallisca ma continui: i miei figli sono qui, in sala, lo sanno che potranno avere le azioni dell’impresa se, moralmente le meriteranno. Ma se vorranno occuparsi della gestione, dovranno dimostrare che lo vogliono fare, che hanno le capacità. Non è perché sono i figli del fondatore che possono gestire l’impresa. L’impresa la gestirà chi avrà gli skill, le capacità, il sogno per farlo.
L’altro punto era tutelare il benessere delle persone coinvolte nel processo produttivo, convinti che la forza della nostra azienda stia in colui che per essa lavora. L’ultimo punto era partecipare al processo di crescita del tessuto sociale economico-culturale in cui l’azienda opera, convinti che lo spirito di collaborazione sia il fondamento di ogni sviluppo futuro. Queste cose le abbiamo scritte nei primi anni ’90, le abbiamo attuate in questo tempo, ogni anno ci incontriamo. Il presidente Scholz dice che è una impresa giovane! Ci piace valorizzare i giovani, scegliamo persone giovani, poi nell’andare avanti, in questi pochi minuti che mi sono rimasti, vi racconterò qualcosa su questo: ma il punto è partecipare al processo di crescita del tessuto sociale economico-culturale in cui l’azienda opera, convinti che lo spirito di collaborazione sia fondamento per ogni sviluppo futuro. Crediamo che l’aver scelto Monterubbiano, nonostante sia entrato nella Cassa del Mezzogiorno, quindi l’avere lavorato in un’area che nel ’74, quando siamo partiti, era ostile, sia stato giusto. Questo piccolo gruppo fa lavorare 350 persone in Italia, più di cinquecento in giro per il mondo ma da lì, si parte. Il 45% dei lavoratori sono di quel paese, il resto vive a 15 km di raggio dal paese.
Evidentemente, stiamo ancora rispettando questo punto. Ma la soddisfazione sta nel fatto che lo stiamo rispettando a Manfredonia, dove siamo andati a metà degli anni ’90, perché trovare un lavoratore nelle Marche, soprattutto nella nostra zona, era difficilissimo. Si era al 3% di disoccupazione, praticamente erano tutti occupati, e noi avevamo bisogno di assumere 70, 80 persone. Dove trovare manodopera qualificata che possa essere messa a frutto? Abbiamo pensato a Manfredonia. Siamo andati lì, abbiamo chiuso una joint venture che avevamo in Ungheria, abbiamo delocalizzato all’inverso per aprire uno stabilimento a Manfredonia. Ci dicevano: siete dei pazzi, come si fa ad andare ad investire al Sud? Avevamo fatto un progetto, c’era un Patto Vaira, così si chiamava per Manfredonia, forse qualcuno lo conosce: si voleva contribuire alla rimessa al lavoro delle 4000 persone che erano state espulse dalla chiusura dello stabilimento Enichem. Abbiamo detto, rinunciamo ai 50 milioni che ci date per ogni dipendente ex Enichem, perché noi vogliamo assumere solo giovani. Come rinunciate a 50 milioni per dipendente? Il progetto consisteva in 2 miliardi e mezzo di lire, erano 50 dipendenti, all’epoca. Sapete, non vengo dalla famiglia Onassis, ma noi guardiamo al futuro, pensiamo alla nostra missione per i prossimi 450 anni, e allora i 50 milioni durano poco: ci siamo detti, forse li perderemmo in poco tempo, preferiamo i giovani.
Allora, a quei genitori che venivano lì a chiederci di assumerli perché portavano 50 milioni di dote, dicevamo: lei ha una dote più importante, suo figlio dovrà lavorare, facciamo lavorare lui. Dopo 12 anni, posso dirvi, con grande soddisfazione, che erano 11, le imprese nate in quell’area. 9 hanno chiuso, noi da 50 dipendenti siamo arrivati a 125, l’altra impresa lavora a fianco. Probabilmente, anche il creare con il lavoro quotidiano un’organizzazione di uomini che rimanga solida nel tempo, a favore della crescita e del benessere delle generazioni future, funziona. E sapete qual è la mia vera gioia? Molti dicono: al Sud, nessuno sa fare niente! Non è vero! Al Sud sono più bravi che in altre parti, se il sogno che hanno è di realizzare qualcosa di condiviso. Questi giovani che sono stati formati, li abbiamo portati a Monterubbiamo e a nostre spese, rinunciando ai fondi statali e regionali, abbiamo cercato di fare loro capire che investivamo su di loro. Lo hanno capito, sono stati così bravi che hanno trasferito questa loro esperienza in Cina, e noi adesso abbiamo uno stabilimento in Cina, dove i giovani cinesi sono stati formati dai pugliesi. Chi ci conosce, chi visita lo stabilimento, fornitori e clienti, ci dice: ma come avete fatto! E vi assicuro, lo hanno fatto i nostri uomini, questo è il capitale umano. Tutelare il benessere delle persone coinvolte nel processo produttivo, convinti che la forza della nostra azienda sia in chi lavora e collabora. Come si fa a tutelare l’interesse delle persone se non le si motiva e non le si coinvolge? Motivazione e coinvolgimento, convinti che non stiamo inventando nulla ma che la politica del personale sia la politica più importante perché l’impresa possa essere presente nei prossimi 450 anni.
Presidente, concludo con l’ultimo punto: valorizzare e gratificare ogni persona che si vuole mettere in gioco e dare, giorno dopo giorno, il meglio di sé, nel conseguimento della missione aziendale. Come ho detto, FAAM opera dal ’74: la nostra soddisfazione è che, l’anno scorso, due dei nostri dipendenti siano stati insigniti con la Stella al Merito dal Presidente della Repubblica. Sei sono stati insigniti dal Premio Maestri del Lavoro. Questa è un’altra bella soddisfazione! Io mi emoziono un po’ quando parlo del mio team, dei miei uomini. In 36 anni di attività, non abbiamo mai avuto un secondo di sciopero: e vi assicuro che sono tutti fortemente sindacalizzati, perché sono io il primo a stimolare i miei uomini perché si iscrivano al sindacato. Quando siamo andati a Manfredonia, è stata una battaglia dura, perché i giovani che avevamo assunto sono stati chiamati dalle organizzazioni sindacali locali che dicevano loro: questi sono venuti qui a sfruttarci! Ai nostri tre, che erano stati eletti rappresentanti RSU, il nostro direttore generale, con me al fianco, ha detto: “Questo è l’insegnamento che vi hanno dato i vostri referenti che avete conosciuto ora, vero? Voi, che esperienza avete del lavoro? Prossima allo zero! Bene! Allora noi vi diciamo la nostra esperienza. Avete visto come siete stati a Monterubbiano. Le richieste che vi hanno fatto i vostri colleghi del sindacato sono queste, noi vi diciamo che sono sbagliate per questa ragione e quest’altra. Ora, se volete, ci ragioniamo sopra, siamo disposti a dialogare. Se non volete, faremo un assemblea, però ci saremo anche noi, parliamo con tutti i lavoratori e vedremo se i lavoratori saranno d’accordo sulle linee di pensiero dei vostri referenti sindacali o su quello che stiamo dicendo noi. Non vi stiamo dicendo di non fare il vostro dovere, ma il vostro dovere è verificare il nostro atteggiamento all’interno dell’impresa, affinché si cresca assieme”. Bene, oggi, con nostra grande soddisfazione, sono tutti e tre rappresentanti provinciali, hanno scavalcato i loro maestri, e con nostra grande soddisfazione nello stabilimento non c’è mai stato un secondo di sciopero. Abbiamo un prodotto eccellente, di qualità, riconosciuto come tale dai nostri clienti.
BERNHARD SCHOLZ:
Grazie, Federico. Passiamo a una realtà multinazionale, il gruppo Nestlè, perché anche San Pellegrino fa parte del gruppo Nestlè. Quando ci siamo visti a preparare brevemente questo incontro, Manuela Kron ci ha fatto notare una differenza specifica fra lei e il resto dei partecipanti a questo incontro: lei è manager, ma è anche maneggiata. Sentiamo la sua esperienza.
MANUELA KRON:
Grazie. Infatti, la differenza non è quella che voi potevate pensare, lei è una donna e loro sono uomini. No, io sono un manager e come tale gestisco. Come manager, gestisci qualcosa che ti viene dato dall’azienda, due cose, fondamentalmente: i soldi che l’azienda ti dà per ottenere un certo obiettivo ma, cosa altrettanto e più importante, gestisci persone. Gestisci persone che lavorano e che devono portare il tipo di risultato che l’azienda desidera. Quindi, quando si parla di capitale umano, in maniera un pochino più cinica, si può dire che un’azienda dal suo capitale umano si aspetta un ritorno che aiuti le persone che lavorano. Come manager, io ho fatto tutta una trafila per cui sono stata, dapprima solo maneggiata, poi ho incominciato a maneggiare, e quindi a gestire. Questa è una relazione è importante per capire una serie di passaggi. Nestlè è, come sapete, il più grosso gruppo di produzione alimentare nel mondo, per gli uomini e per – come diciamo noi – “i nostri amici a quattro o due zampe”, o anche solo con le ali. Gestiamo nel mondo più di centottantamila persone, più di cinquemila in Italia. Come potete immaginare, diversissime.
Quindi, quando si parla di gestione, io non parlo solo del capitale in soldi, che è quello paradossalmente più semplice, ma della gestione delle persone. Abbiamo esigenze diversissime nel mondo. Pensate che noi abbiamo stabilimenti in più di centottanta Paesi, quindi, passiamo dall’Italia all’Arabia Saudita, dal Brasile agli Stati Uniti, con realtà completamente diverse. Se pensiamo all’Italia, abbiamo stabilimenti in centri che hanno bassa pressione di disoccupazione, ma anche in aree – se pensiamo all’acqua minerale – in cui siamo l’unica realtà che offre un lavoro, un lavoro normato, se mi si passa il termine. Quindi, la responsabilità che abbiamo è grande. Il gruppo Nestlè, in questo senso – io vengo da altre realtà, sono in Nestlè da circa tre anni e mezzo -, è una realtà abbastanza singolare, proprio per questa sua enorme diffusione culturale in tutti i Paesi, ti dà delle basi per cui ti dice: “Questo è il minimo che devi fare, perché io ti affido un capitale e tu lo devi gestire in un certo modo”. Poi però dice anche: “Siccome l’Italia non è il Brasile, non è l’Arabia Saudita, vedete voi che cosa potete portarmi in più”. E questo ti crea, come gestione, altri tipi di problematiche, è una grossa responsabilizzazione. Se pensate ai manager come persone che si limitano ad eseguire quello che gli viene detto, non è così. Come minimo, devi eseguire quello che ti viene detto, ma devi portare un contributo per poterlo fare meglio, e motivare le persone che lavorano con te.
Il capitale umano parte sicuramente dai giovani, come è stato detto negli esempi molto belli fatti prima. E una realtà grande come Nestlè ti può permettere di fare esperienze molto diverse, molto interessanti e in varie aree. Devo dire che constato come i giovani italiani non abbiano ancora la propensione a lasciare il loro, e nostro, Paese per andare a fare esperienze altrove. In questo mondo che si sta accorciando, l’opportunità che noi possiamo dare, che siamo obbligati a dare, per le richieste che ci arrivano, per come è organizzata la nostra azienda, è una forte formazione in un’ottica di innovazione. L’innovazione, per chi fa alimentare, è più che necessaria, è la base per continuare a esistere. Nestlè ha un centro di innovazione e sviluppo che produce sempre novità, però, ancora più importante, da un po’di tempo c’è una fortissima spinta ad essere super innovativi anche per quello che riguarda la gestione del capitale, per l’appunto, umano: dare le possibilità di crescita e miglioramento ai giovani, però pensare a tutti.
Qui si innesta quello che potevamo fare noi, come manager italiani, perché io sono qui ovviamente a rappresentare dei manager in Italia. E qui emerge l’altro elemento su cui scherzavo prima, l’elemento femminile. L’innovazione che stiamo portando a livello di gestione del capitale umano, di recente in Nestlè nasce da un’esperienza di gruppo femminile: un gruppo che è nato in Nestlè qualche anno fa e che doveva cercare di dire a un manager, figura prevalentemente maschile, come far crescere e valorizzare il capitale umano femminile. Sentivo stamattina delle statistiche sul numero di donne imprenditrici, Amministratori Delegati, le percentuali di donne al potere in Italia rispetto agli uomini: 6%. Siamo i quart’ultimi, dopo d noi c’era Malta, Cipro e un’altra che non ricordo, ma insomma i termini erano questi. Qualche anno fa, alla Nestlè si sono guardati in faccia, hanno visto tutti maschi e hanno detto: forse dovremmo cercare di migliorare qualcosa. E si è formato questo gruppo di lavoro che è venuto fuori con quella che siamo orgogliosi di chiamare la vera novità che stiamo cercando di portare avanti, ovvero un cambiamento di approccio culturale dalla cultura della presenza in ufficio alla cultura della performance.
Che cosa significa? Spero di non scandalizzare nessuno, dicendo che c’è una cultura molto maschile: se il capo sta in ufficio fino alle otto di sera, tutti alle otto di sera in ufficio. Magari non siamo superproduttivi, però rimaniamo. Le donne hanno sì il lavoro, ma hanno tante altre belle cose da gestire. Quindi abbiamo cominciato a dire: come possiamo fare per migliorare le nostre risorse? Ovviamente, non pensando solo alle donne ma in generale. Abbiamo cominciato a pensare a come valorizzare il nostro capitale umano e, visto che, come si legge spesso, è il tempo che manca, ci siamo chiesti come fare loro guadagnare in tempo e in serenità. E abbiamo lanciato, proprio su questo tema – tenete presente che ci vogliono anni, perché inizino cambiamenti in azienda, perché ovviamente non è così semplice allineare una grande organizzazione – due progetti molto importanti. Il primo progetto, che abbiamo chiamato “Progetto novanta giorni”, nasce da questo pensiero: i genitori e le scuole che chiudono. Abbiamo un certo periodo dell’anno, circa novanta giorni, in cui la scuola è chiusa ma i genitori vanno a lavorare. Esistono i nonni, ma non sempre. Esistono le baby-sitter, ma le devi pagare tanto. Cosa facciamo? Abbiamo iniziato quest’anno una sperimentazione nella sede di Milano, che saremo lieti di esportare in tutti i nostri stabilimenti, diciotto sul territorio nazionale: “porta il ragazzino a scuola, in ufficio”. Noi lo gestiamo, viene dato a terzi, ovvero c’è un’organizzazione che gestisce i bambini, che fa fare loro dei percorsi. Il genitore, ma anche gli zii, portano il bambino in azienda, poi se lo vanno a riprendere. Orario: dalle otto alle otto. L’azienda mette gli spazi e la competenza, la famiglia mette un minimo di contributo economico: in questo modo, all’azienda tecnicamente non costa niente, non ha esborsi diretti di denaro, e per le famiglie significa risolvere un enorme problema. Non pensate solo alle vacanze estive: le tre giorni, le elezioni a Pasqua, tanti momenti.
Questo ha talmente sollevato i nostri genitori che abbiamo cominciato ad avere richieste di partecipazione a questo nostro campo – Junior Camp – dal quartiere. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: perché no? Pensiamoci sopra, vediamo come farlo, perché poi c’è tutta una serie di problematiche, assicurative e quant’altro. E questo è stato il primo passo che ha suscitato grande interesse anche nel mondo politico: qualcuno è venuto a chiederci, a vedere come si fa. Perché è veramente una situazione in cui vincono tutti: vince la famiglia, vince l’azienda, non ha un costo, quindi vinciamo noi manager che abbiamo un incubo che sono tre parole: taglio del budget. Questa è una cosa che non si può tagliare, perché non c’è un budget dedicato: si fa e basta, si gestisce, curando il management in questa cosa.
L’altra cosa che abbiamo appena iniziato è una situazione molto interessante: abbiamo appena concluso con i sindacati un contratto per il telelavoro. Dipende ovviamente dal lavoro che fai, ma chi l’ha detto che devi venire in ufficio, se magari abiti a quaranta chilometri dal posto di lavoro? Magari fai un lavoro che puoi eseguire benissimo da casa, e te lo gestisci tu. Io ti dico quello che voglio, quello che mi aspetto che tu porti dopo una settimana, un mese, sei mesi: e tu lo gestisci come vuoi. Abbiamo appena iniziato, abbiamo fatto della sperimentazione: la cosa innovativa – perché il telelavoro non è una novità in sé – che vogliamo portare è che le persone tengono la scrivania in ufficio. Ma avranno la possibilità di lavorare, per un giorno alla settimana, tre giorni alla settimana, verticale, orizzontale, quello verrà definito con i propri manager, con i propri capi. Sono due attività che abbiamo iniziato a svolgere, c’è voluto tempo, per poterle organizzare. Ma io sono molto fiera del fatto che l’azienda non abbia pensato solo al suo capitale umano più alto, in via di sviluppo, ma che abbia pensato al suo capitale umano, per averne un maggiore ritorno in termini di tempo e di affezione, in maniera molto più ampia e allargata su tutti, perché queste evidentemente sono iniziative che riguarderanno assolutamente tutti.
BERNHARD SCHOLZ:
Sono un maschio, ma la cultura della presenza è veramente una cosa imbarazzante. Bene, passiamo all’Ambasciatore Vattani, che è stato due volte Segretario Generale del Ministero degli Esteri e Presidente della Venice International University, l’Università Internazionale di Venezia. È posizionata su una bellissima isola.
UMBERTO VATTANI:
San Servolo.
BERNHARD SCHOLZ:
San Servolo. E dal 2005, è Presidente dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Poi ha avuto tanti altri incarichi. Dico questo perché proprio per il suo lavoro, per la sua carriera, conosce molto bene il mondo internazionale e quali siano le leve con le quali l’Italia si può posizionare a livello internazionale. La domanda è: quali sono le possibilità che esistono in Italia, le opportunità per valorizzare quelle abilità, quelle capacità tipiche di questo Paese, che fanno la differenza?
UMBERTO VATTANI:
Grazie mille, Bernhard. Dopo l’intervento introduttivo di Scholz, e i tre casi, le interessanti relazioni che abbiamo ascoltato, guardiamo un po’ al quadro generale. Sono tre importanti realtà, quelle che abbiamo qui al tavolo, ma quante sono le imprese in Italia, cioè, quante sono quelle organizzazioni che in qualche modo, unificando e ponendo insieme i fattori della produzione, creano posti di lavoro, creano ricchezza? Beh, sono oltre 4 milioni, ma su questi 4 milioni, soltanto 189.812 – noi teniamo molto a quel dodicesimo – sono quelli che esportano, cioè che producono qualche cosa che va all’estero. E se guardiamo più da vicino queste 189.812 imprese, questi imprenditori, ci accorgiamo che quasi la metà, il 46%, è responsabile solo per il 6,4% delle esportazioni totali. Il che vuol dire che c’è una miriade di imprese piccole, piccolissime, alcune delle quali esportano in un unico mercato all’estero. E allora, qual è il problema? Il problema è cercare di aiutarle, queste piccolissime, a trovarsi anche qualche altro mercato, e aiutare quelle che già esportano di più, e quindi sono più importanti per il profilo della bilancia commerciale, a rafforzare la loro azione all’estero.
E in questo, l’ICE, insieme al Ministero degli Esteri – mi fa molto piacere che sia qui tra noi anche l’Ambasciatore Giovanni Marini, che è stato ambasciatore in Macedonia, ambasciatore a Montecarlo, oltre che in tanti altri Paesi – ha una grande rete all’estero. L’ICE da sola ha 116 uffici in 86 Paesi: non arriviamo a tutti quelli dove è presente la Nestlè, ma abbiamo pur sempre 116 uffici in 86 Paesi che cercano di aiutare questa miriade di imprenditori a rafforzarsi, trovando nuovi sbocchi. In che modo? Dando informazioni, studi di mercato, organizzando missioni – Vitali è venuto tante volte con noi, in queste missioni all’estero -, cercando soprattutto di assisterle nella ricerca di partners e di canali di distribuzione. Per citare un esempio che mi è capitato un’ora fa, Tommaso Pirozzi, che costruisce magnifiche biciclette elettriche, mi diceva: dove possiamo trovare uno sbocco per queste biciclette? La cosa che mi ha colpito è che, a quanto mi è stato detto, i suoi 150 dipendenti sono tutti portatori di handicap. E’ riuscito a mettere insieme una realtà produttiva con persone che non sono nelle migliori capacità fisiche, ma che ciò nonostante fanno delle magnifiche biciclette, e le vogliono esportare all’estero.
Il problema non è solo questo. Il problema è come fare in modo che queste straordinarie aziende riescano a sviluppare una maggiore capacità di andare all’estero. E non è sempre facile, perché in queste aziende l’imprenditore – faccio l’esempio di Vitali, quando ha cominciato la sua attività – è quello che mette assieme la produzione, deve assumere il personale, tiene i rapporti con le banche, con i clienti, con i fornitori. Qual è il tempo che gli rimane per andare all’estero a studiare un altro mercato, a vedere se esistono possibilità di sbocchi? Non più molto. E allora l’ICE – ed è l’unico Ente di Promozione delle esportazioni che conosco, non lo fanno i francesi, non lo fanno i tedeschi, non lo fanno gli spagnoli, i portoghesi o gli altri – svolge un’azione importante di formazione. Formazione di chi? Di persone, che noi chiamiamo normalmente export-manager, che iniziano a conoscere bene i mercati internazionali e le tecniche per commerciare in tutto il mondo. Dove li andiamo a pescare? Beh, sono quelli che si laureano all’Università. Prima sceglievamo soltanto quelli che facevano Scienze Economiche, adesso prendiamo anche quelli che fanno Lingue Orientali, che hanno studiato russo arabo, cinese, giapponese. Perché è più facile insegnare i rudimenti del commercio internazionale a qualcuno che ha già fatto tanti anni di studio di una lingua, piuttosto che andare a insegnare una lingua a uno che ha fatto soltanto Economia e Commercio.
Ed è straordinario vedere quelle trasformazioni di cui hanno parlato coloro che mi hanno preceduto, in ragazzi che escono dall’Università, spesso con poca motivazione. Uno mi disse una volta: “Personalmente sono sempre pronto a imparare, ma non mi piace molto che mi si insegni”, il che mi sembrò lì per lì una frase divertente, ma che la diceva lunga sulla sua voglia di imparare a lavorare. E allora, questi ragazzi li togliamo da un ambiente puramente astratto, di teorie, e li mandiamo nelle imprese, e raccomandiamo agli imprenditori di farli lavorare come se stessero sul loro libro paga. Dopo tre mesi, li mandiamo all’estero, nei nostri uffici o in altre aziende italiane all’estero, e loro imparano a cavarsela da soli: debbono affittarsi una stanza, badare alla loro biancheria, trovare un posto dove andare a mangiare. E’ incredibile rivederli dopo un anno di questa cura: non sono più le stesse persone. Erano dei ragazzi usciti dall’Università, che passavano il loro tempo, soprattutto il sabato e la domenica, gironzolando nei loro paesi o nella loro città, senza voglia di fare un gran che. Tornano con un coraggio da leoni, straordinariamente evoluti rispetto a quei quattro anni di Università. Non lo dico io, lo dicono i professori e coloro che li hanno avuti come studenti, ma con quei corsi, sono irriconoscibili. Ed è per questo che io trovo importantissimo questo incontro. Lo trovo importantissimo perché ciascuno di noi sicuramente conosce ragazzi o ragazze che non hanno ancora trovato bene la loro strada, e che invece, messi alla prova, introdotti in mercati che non conoscono, di cui all’inizio non sanno nulla, rivelano delle straordinarie capacità di adattamento, per svolgere un lavoro utile a quella miriade di piccole imprese italiane dove possono fare tutta la differenza.
Bene, non sono certo quelli che noi immaginiamo rimarrebbero lunghe ore in ufficio: e ha ragione Manuela Kron, nel dire che la performance è qualcosa di diverso dalla durata delle ore di lavoro. Perché se uno dovesse valutare quelli bravi soltanto per quanto tempo stanno seduti su una sedia, davanti a una scrivania, bisognerebbe prendere i pantaloni e passarli ai raggi x per vedere quelli che li hanno consumati di più. Ecco, non è quello che ci interessa. E noi siamo davvero sorpresi di vedere la capacità straordinaria di questi ragazzi e ragazze di adattarsi e scoprire una vocazione alla quale magari prima non avevano mai pensato. Noi ci siamo rivolti alle banche, agli istituti di credito, alle associazioni di imprenditori, per dire cosa l’ICE può fare come borse di studio, quello che fa. Abbiamo deciso di far contribuire in parte i ragazzi, per aumentare il numero dei frequentatori, ma se altri dessero borse di studio, se le aziende in qualche modo contribuissero per aumentare il numero di questi ragazzi e ragazze, che diventerebbero per loro i migliori alleati nella ricerca di nuovi mercati e di nuovi sbocchi, credo che faremmo tutti una cosa molto, molto utile. C’è una cosa che ha detto Vitali che mi è piaciuta, la diceva già Leonardo qualche secolo fa: se un ferro non è usato, arrugginisce, così come un ingegno inattivo non produce nulla.
Ecco, io credo che dobbiamo sempre di più tenere i nostri giovani all’erta su questo, non fare in modo che gli esami universitari si allunghino, che vadano fuori corso, che si entri in quella specie di routine nella quale non si esce più dall’Università, se non dopo anni e anni. Noi dobbiamo essere severi ed esigenti, e dobbiamo fare in modo che sempre si ricordi che il centro dell’universo, come dice del resto Sua Santità nell’enciclica Caritas in Veritate, è pur sempre l’uomo, non l’uomo inattivo ma l’uomo faber, quello che contribuisce con le sue mani, con i suoi talenti e le sue capacità intellettuali a portare avanti questo progresso che nel nostro Paese non si è mai fermato e che anzi vede – lo si vede molto chiaramente anche qui al Meeting – delle associazioni, delle aziende, delle imprese di primissimo ordine e che sono l’orgoglio del nostro Paese. Grazie.
BERNHARD SCHOLZ:
Vorrei fare a ognuno una brevissima domanda, chiedendo una brevissima risposta, visto che il tempo avanza. Francesco Bombelli, qual è stato il fattore che ha permesso alle persone di quella famosa cooperativa che hai incontrato, di arrivare a un’ottima qualità senza disastri? Qual è stato il fattore che ha mosso le persone? Perché ho capito che non è stato un approccio autoritario da parte tua. Qual è stato allora il punto che ha scatenato quella mossa nelle persone?
FRANCESCO BOMBELLI:
Non sarei sopravvissuto un mese, con un approccio autoritario. Non mi invento una risposta, avevo già in mente di leggervi quattro righe di una mail che mi è arrivata due giorni fa e che spiega perfettamente qual è la questione. È di una delle persone più centrali di questa esperienza, che mi scrive: “Grazie ancora dei pensieri notturni”, perché non ricordo a che ora gli scrissi, però tardi. E poi mi fa una domanda, o meglio, si fa una domanda: “Cosa qualifica in modo del tutto speciale la tua, la nostra impresa?”. E si risponde lei: “E’ l’incontro con un ragazzo perso, che rende l’educatore tale, è l’incontro con un bambino in germoglio, che accresce l’iniziativa e la responsabilità professionale, è l’incontro con un uomo educatore, che fa intravedere ad un ragazzo una possibilità buona per sé, è l’incontro di un imprenditore con una realtà viva e pulsante, che muove la sua iniziativa e la implementa. Il capitale del capitale è il cuore dell’uomo che incontra l’altro da sé: cuore e incontro, ciao, a lunedì”. E buon lunedì a tutti.
BERNHARD SCHOLZ:
Grazie. Federico, evidentemente un’azienda come la tua deve competere, e può competere solo se innova continuamente. Quale innovazione, dal punto di vista delle persone, non è qualcosa che puoi imporre? Come è possibile che poi abbiate sempre questo successo a livello internazionale? Quindi, qual è la leva che avete per muovere le persone a essere sempre innovative?
FEDERICO VITALI:
Direi che è quasi elementare, è il coinvolgimento, il far partecipare alla vita dell’impresa la persona. Bernhard, quando hai fatto la premessa “da capitale e lavoro a produttività e capacità innovativa” e hai detto che si è scoperto che questo risiede nelle persone, è così, non funziona diversamente. E’ la persona, la crescita culturale del mio collaboratore è una cosa sua, è una cosa personale che rimane a sé. Ma se io non lavoro per aiutare il mio collaboratore a crescere, non posso far crescere la mia impresa, quindi è questo coinvolgimento, è questa sorta di condivisione nella missione. Io sono emozionato quando penso che la piccola farm – noi siamo veramente piccoli, i nostri compagni sono due multinazionali con sede negli Stati Uniti, spaventose – è riuscita ad ottenere rispetto da queste multinazionali spaventose, con prodotti così innovativi che ci definiscono “la batteria risparmia-energie”. Siamo riusciti a fare un sistema che genera il 27% di risparmio energetico rispetto al miglior nostro competitore, perché rispetto a certi competitori cinesi siamo al 50% di risparmio energetico, cioè di efficienza energetica. Non sto parlando della batteria della vettura, sto parlando delle batterie per i carri elettrici, quelle che muovono le merci negli stabilimenti. Costa dai duemila ai cinquemila euro nell’arco della sua vita, e quanto costa in più a farla? Allora, la nostra missione è lavorare di più, faticando di meno, per proporre sul mercato il massimo di tecnologia sostenibile al miglior rapporto qualità-prezzo, per i prossimi 850 anni.
Questa è la chicca finale, ma perché, al miglior rapporto qualità/prezzo? Perché se facciamo una cosa che poi non è vendibile, non è fruibile, è inutile che la facciamo. Allora la nostra batteria, che risparmia il 27% di energia, sapete quanto costa in tutta la sua vita? Ci costa il 6% in più, il 7% cento in più, rispetto a quella volgare. E allora, sapete cosa significa questo? Che se in Europa si producessero sistemi di accumulo di energia con questa tecnologia, risparmieremmo due centrali nucleari, mi spiego? Altra cosa, e concludo, Bernhard, il litio; noi siamo una piccola azienda ma la cosa che siamo riusciti a fare è impressionante. Kawasaki aveva un problema nelle moto: Kawasaki non partecipa al Moto GP ma partecipa alla Superbike. La Superbike è una moto più vicina alla moto di strada che a quella da competizione, certe cose, certe modifiche non si possono fare. Aveva una batteria che pesava due chili e mezzo e due chili e mezzo pesano per il pilota, in curva. Vogliono una batteria più leggera, chiedono al loro fornitore ufficiale una batteria più leggera e gli danno una batteria che pesa un chilo e mezzo. Hanno tolto un chilo, sono stati bravi. Ma siccome uno degli ingegneri del team di Kawasaki sta in un paesino vicino al nostro, un suo collega di scuola delle superiori, che poi ha fatto economia, gli dice: “Tu stai su quella gabbia di matti” così ci definiscono “vedi un po’ se possono fare qualcosa per una batteria”. Ne abbiamo fatta una che offre loro cinque volte le esigenze, e sapete con quanto peso? 151 grammi. Ecco. Solo per dire che sono piccole soddisfazioni che fanno sì che Magneti Marelli, dovendo portare sul mercato dell’automobile il litio, abbia chiamato FAAM: è un passaggio, una cosa che ci impegna, ci fa paura e fa tremare le vene ai polsi, ma ci dà la forza per farlo.
BERNHARD SCHOLZ:
Manuela Kron, le multinazionali vengono spesso accusate di standardizzare il lavoro in modo tale che le persone entrano un po’ da robot ed escono ancora più robotizzate di prima: ma da quello che ho sentito, mi sembra un giudizio un po’ lontano dalla realtà. Comunque, come è possibile mantenere una multinazionale con standard alti in 186 Paesi, quindi in tutto il mondo, valorizzando la singola persona? So che è una domanda complessa.
MANUELA KRON:
Innanzitutto, vorrei ritornare a multinazionale: vuole dire azienda che lavora in più Paesi, non è sinonimo di standardizzazione: di fatto, pensate che solo in Italia abbiamo le aziende più disparate, che fanno dalla cioccolata alla pasta fresca, all’acqua minerale. Fondamentale per un’azienda che lavora in tanti Paesi, che forse può fare meglio di altre, è stabilire delle regole comuni, stabilire che un dipendente debba essere trattato in un certo modo, anche se il Paese dove lavora non obbliga a questo. Pensate a quanti tipi diversi di legislazione ci troviamo davanti: alcune molto rigide, molto protettive, come è giusto che sia, altre, dove vige la carne da macello. Allora, un’azienda che lavora in tante nazioni, dice: “Io non posso mettermi cappelli diversi, devo lavorare con un senso dell’etica che mi dice che devo trattare tutti allo stesso modo, anche perché, banalmente, viaggeranno e si renderanno conto se il trattamento è diverso”. Non viaggiano soltanto i manager, all’interno di un gruppo multinazionale, e in particolare Nestlè, possono viaggiare anche livelli molto diversi. Quindi, diciamo che la sfida è trovare delle regole che vengano applicate nello stesso modo. Probabilmente il mio gruppo è avvantaggiato dall’avere da tanti anni un fanatismo di base che è la cultura “incidenti zero”, la cultura della sicurezza in fabbrica, ma non solo in fabbrica, anche in ufficio. E’ qualche cosa che è veramente sentito e che, ogni volta che succede – e purtroppo, per quanto tu possa stare attento, la disgrazia può succedere – viene vissuto come una sconfitta personale da tutti. Questa è stata la base culturale che ha permesso il diffondersi, non di una standardizzazione ma di una cultura di motivazione verso certi comportamenti che devono essere validi, assolutamente, dovunque.
Circa un anno fa parlavo con un collega che fa il capo delle risorse umane in Arabia Saudita, è un egiziano che mi ha detto, ridendo: “Pensa cosa deve essere per me quando faccio i colloqui con delle signore, in Arabia Saudita”. Non voglio entrare nei dettagli, però la cultura è: “Tu con le persone ci parli e non importa dove sei”. A proposito di standardizzazione, ho lavorato in altre multinazionali di cultura americana, e la mia esperienza non è che all’interno ci sia standardizzazione. C’è una base culturale che ti dice: “Tu devi comportarti come minimo così”. Poi alcune sono più brave di altre a lasciarti libero: come minimo devi fare così, ma portami un po’ di più, là dove l’incentivo vero, quello in una grande azienda che opera in tanti Paesi del mondo, è quanto livello di rischio ti lasci prendere. Io trovo abbastanza buffo che tantissimi di noi siano disposti a spendere, a prendersi il rischio quando investono in Borsa, e non quando investono sulle persone. Perché togliere Internet e dire alla gente: “Non puoi navigare dove vuoi”? Ma che senso ha? In un mondo che è sempre più legato a questo, prenditi il rischio! Va bene, è vero, un’ora la passeranno a girare in siti dove non li porta necessariamente il lavoro, ma responsabilizzali. E se alla fine della giornata ti hanno portato comunque quello hai chiesto, che importanza ha se hanno anche navigato un po’ in rete, e magari si sono distratti, e magari hanno tirato fuori delle idee? Io, il mio gruppo di lavoro lo incentivo assolutamente a navigare quanto possono. Ho dato la responsabilità di sviluppare la mentalità dei Social media a una ragazzina di ventisei anni al suo primo lavoro. È un bel rischio che mi prendo, ma se non prendo questi rischi, dove andiamo? Quindi la standardizzazione non è la mia esperienza personale, magari sono stata fortunata, quello che è vero è una base certa per tutti.
BERNHARD SCHOLZ:
Grazie. Ambasciatore, se è vero quello che si è detto fino adesso, che la produzione dipende dalle persone, vuol dire che il famoso Made in Italy dipende da una specificità del capitale umano di questo Paese. Qual è questa specificità?
VATTANI UMBERTO:
E’ proprio questa straordinaria creatività che hanno gli italiani. Dai loro tre, quattro pezzi di ferro, e riescono a farti un motore, di quelli che superano perfino la Kawasaki, per velocità e per sicurezza. Riusciamo a fare gli alimentari più ricercati al mondo, non c’è un prodotto italiano nel campo dell’alimentazione che non si situi ovunque, con buona pace, ovviamente, di Manuela Kron, che è una concorrente. Siamo un po’ nazionalisti e credo che, quando si tratta di difendere il Made in Italy, noi dell’ ICE non facciamo sconti. Ma vorrei dire una cosa: è proprio l’orgoglio di questa straordinaria classe imprenditoriale italiana, che è il nostro fiore all’occhiello. Così come per la Farnesina, e c’è qui il mio amico Giovanni Marini, il fatto di rappresentare all’estero un Paese come l’Italia è di per sé un motivo di orgoglio. Noi siamo un grande Paese, lo siamo sempre stati: non c’è stato un momento storico, dall’antichità a oggi, in cui l’Italia abbia cessato di produrre il meglio in tanti campi, che si tratti delle arti, della letteratura o dei gioielli, dei damaschi o della meccanica. E credo che questo spinga i funzionari dell’ICE, così come i Diplomatici, a rappresentare il nostro Paese all’estero con un senso di fierezza.
Vi racconto una cosa buffa che mi è successa a New York tempo fa. Avendo dato al Direttore Generale di Saks Fifth Avenue, un grande magazzino della Quinta Strada, il mio biglietto da visita, lui lo guarda e fa: “ICE”, leggendo ais, come fosse ghiaccio, “Do you produce ice?”. “No, non lo produco, no” dico io. “Eventually, I breake the ice”, eventualmente rompo il ghiaccio. Allora mi è venuto in mente: come posso fare capire a questi americani che ICE non ha niente a che vedere con quel prodotto ghiacciato e che invece rappresenta il Made in Italy, come diceva Bernhard un momento fa? Pensa e ripensa, mi è venuto in mente, e l’ho già usato con gli americani: I for Italian, C for Class, E for Excellence, Italian Class and Excellence. E’ rimasto sorpreso, ma credo che abbia dato bene il senso di quello che noi cerchiamo di rappresentare all’estero, cioè questa straordinaria, incredibile, mitica, leggendaria produzione che fa sì che ci riconoscano non solo per la forma dello stivale, che è il nostro Paese, ma proprio per la quantità di beni che hanno raggiunto i luoghi più lontani del pianeta e che hanno contribuito a rendere le città del mondo più eleganti, grazie proprio alle nostre aziende. Dovunque vai, da Vancouver a Johannesburg, da Mosca a San Paolo, dal Messico a Praga, vedrai che nelle più belle strade di queste città ci sono nomi italiani che hanno abbellito il centro. Quindi, devo dire che noi italiani, da questo punto di vista, siamo dei privilegiati. Grazie.
BERNHARD SCHOLZ:
Bene, voglio solo fare un’osservazione finale. Forse sapete che il Consiglio d’Europa ha definito nel Duemila a Lisbona la competizione dell’Europa attraverso la conoscenza come scopo primario. Volevano poi investire il 3% del PIL nella ricerca. Che tutto questo non avvenga, già si sapeva, comunque il vero problema non è investire in ricerca, che va benissimo, anzi, è necessario, ma il primo problema che emerge ed è stato accennato in tutti e quattro gli interventi, è: come facciamo affinché rimanga vivo nelle persone questo desiderio del quale parla il Meeting. Perché, quando questo desiderio c’è, le persone trovano la strada per la formazione, per aggiornarsi, per dare il meglio nelle aziende. Questa è la cosa primaria che fa scattare poi tutti gli altri meccanismi necessari. In parte, è un problema educativo, delle famiglie, della cultura che un giovane sperimenta nella sua vita. Ma io penso che sia venuto fuori in tutti e quattro gli interventi, in modo molto chiaro, che anche il lavoro può diventare un’esperienza, non dico una conoscenza, un’esperienza di se stesso, che vuole dire del proprio desiderio.
Perché tante persone sprigionano questo desiderio proprio mentre lavorano. Faccio l’esempio che hai fatto tu prima, quando le persone sono lì e cominciano a essere messe alla prova, scoprono chi sono. E’ impressionante come una persona mentre lavora conosca se stessa. Quindi, una delle prime possibilità che abbiamo per rendere viva una base culturale che faciliti la crescita del capitale umano è proprio rendere l’ambito lavorativo un’esperienza dove le persone conoscano se stesse e scoprano questo desiderio, questo cuore di cui parla il Meeting. Perché è la cosa meno scontata, perché in una che società tende ad appiattire tutto e a rendere questo desiderio un istinto a breve, il lavoro dà la possibilità di fare un’esperienza di bellezza. Se andate a vedere le aziende, l’ufficio delle quattro persone che sono qua, saranno uffici e stabilimenti belli, perché la bellezza è una cosa straordinaria per far crescere questa cosa. E faccio l’ultima osservazione: perché in Italia c’è questo Made in Italy che vince? Perché chi va in giro per l’Italia non può non vedere bellezze, non solo naturali, soprattutto culturali. E’ un’educazione che tutti noi abbiamo giorno per giorno, senza che ce ne accorgiamo. Se c’è un Made in Italy con questo alto livello di creatività, come è stato detto, è perché qua ci sono persone che fanno esperienza quotidiana di una bellezza.
E quindi, terza e ultimissima osservazione, dobbiamo chiederci seriamente da dove è nata questa bellezza che vediamo quotidianamente in giro per questo bellissimo Paese. E qua dico una cosa molto personale, che ho detto comunque anche a diversi giornali negli ultimi tempi: bisogna tener conto di un fatto importante, che questa bellezza nasce da una cultura che ha duemila anni. Senza questo, non c’è spiegazione, perché, quando parliamo di capitale umano, non parliamo di una cosa scontata che può essere automaticamente, meccanicamente, con un clic, messa in moto. Questo dipende dal respiro di bellezza, dal respiro di dignità e di stima di sé, dalla conoscenza dei proprio talenti, dalla grandezza della persona, che va comunicata quotidianamente dentro l’ambiente culturale. Senza questo, penso sia difficile, non dico impossibile ma molto difficile. E con questo mi permetto anche di suggerirvi, alle 17, un incontro che reputo storico fra il cardinale Erdö e il metropolita Filaret. Perché lo reputo un incontro storico? E’ il primo incontro pubblico fra un rappresentante di tutte le Conferenze Episcopali Europee e uno dei Metropoliti più importanti del mondo Ortodosso. Storico, perché questo incontro fa ricordare l’origine di cui ho parlato prima e cerca di trovare l’unità nella testimonianza di quell’evento che ha fatto scaturire, nascere, quella cultura di cui ho parlato. Non possiamo pensare a tutte le cose che abbiamo detto prima, senza pensare che all’origine c’è la cultura cristiana che ha permesso questa crescita. Quindi, parlando di questo incontro cui possiamo assistere, parliamo della testimonianza, oggi, di una cultura che ci permette di vivere tutto ciò che abbiamo sentito. Grazie mille.
(Trascrizione non rivista dai relatori)