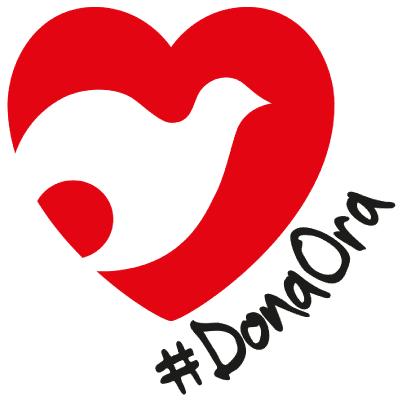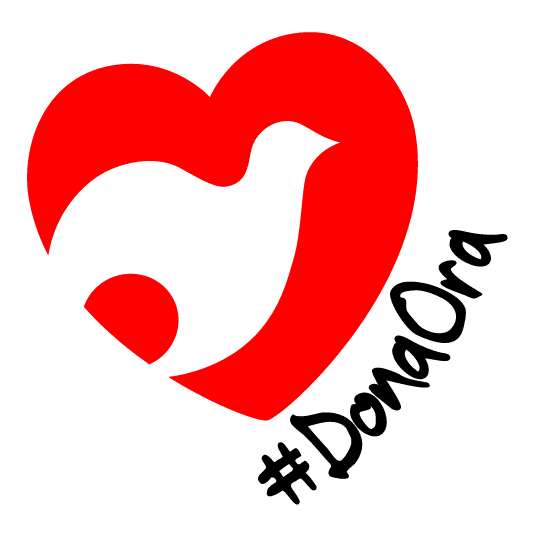Chi siamo
GUIDA ALL’ASCOLTO DAL VIVO – Collana “Spirto Gentil”
Dal vivo – Collana “Spirto Gentil” CD 38
Daniil Trifonov pianoforte; Roberto Andreoni relatore: Beethoven Sonata op. 31 n. 2, “La tempesta” e Sonata op. 57 “Appassionata”.
PIER PAOLO BELLINI:
Questo è il quarto incontro del ciclo Spirto Gentil e ci permetterà un passo in più nell’approfondimento del tema centrale di questo Meeting: “La conoscenza è sempre un avvenimento”. Abbiamo visto nei giorni precedenti come certi avvenimenti diventino immediatamente una provocazione ad un approfondimento, e come la musica sia in grado di arrivare più a fondo del linguaggio quotidiano. Abbiamo visto il primo giorno che cosa vuole dire lo stupore della vita e della bellezza in Schubert, l’impatto con la contraddizione e con la morte. Ieri, invece, i canti napoletani: una riflessione su quello che si sente come mancanza, come nostalgia di un bene assente. Quello che ascolteremo oggi è un’altra sfaccettatura, un’altra occasione di conoscenza. Queste due sonate di Beethoven sono state in qualche modo sottolineate alla nostra attenzione dalla preoccupazione educativa di don Giussani, tanti anni fa: e ancora oggi siamo qui a ringraziare per la sua sollecitudine. Che cosa aveva intuito, che cosa aveva gustato don Giussani in queste due particolari sonate? In particolare, soprattutto in quella che ascolterete per prima, la cosiddetta Tempesta, un po’ di questo vento impetuoso che si manifesta in ogni occasione di prova, perché si abbia a riflettere se la vita sia una cosa seria. Molto interessante, considerare così la prova: immaginiamo o ricordiamo i nostri amici dell’Abruzzo, per esempio, come quella circostanza, quell’avvenimento sia stato per tanti di loro l’occasione di un approfondimento drammatico sulla domanda se la vita sia una cosa seria. La prova che inevitabilmente capita nella vita è una tempesta, mette in evidenza la sostanziale posizione che l’uomo assume di fronte ad una verità che lo colpisce e da cui rimane colpito, è un urto. Ben venga allora la prova, che è paradossale per risvegliarci e riscuoterci, perché nella vita si riaffermi la verità, perché della realtà venga riconosciuta la consistenza, il significato, perché alle cose vengano restituite le giuste proporzioni. Ben venga la prova. Può dire una cosa del genere soltanto chi è veramente appassionato, come abbiamo sentito nei canti napoletani ieri, appassionati a conoscere la verità. Le due sonate che vengono proposte saranno introdotte da un amico e professionista che abbiamo imparato a conoscere in tanti anni, anche nell’occasione dei Meeting a cui ha partecipato. Abbiamo qui con noi il maestro Roberto Andreoni, compositore e docente del conservatorio di Bari, amico e collaboratore della collana. Ha curato molte mostre importanti, qui al Meeting: nel 2006, quella dedicata a Stravinskij, nel 2007, quella dedicata a Beethoven. Abbiamo invece, come esecutore, un ospite illustre, al di là della sua giovane età, Daniil Trifonov: ha solo 18 anni ed è già avviato ad una brillante carriera internazionale, vincitore assoluto della III° edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale di San Marino. Nello scorso mese di giugno si è esibito presso la prestigiosa Carnaby Hall. E’ un onore per noi avere un amico come Roberto, capace di introdurci alla grande musica, e un grande artista ancora in progressione di carriera, come questo musicista. Lascio la parola a Roberto, un applauso per accogliere Daniil. Come sempre, ricordo che è necessario spegnere i telefonini.
ROBERTO ANDREONI:
Qualcuno mi faceva notare: mi raccomando, semplice, stasera, perché non solo c’è tanta musica ma ci sono tanti bambini in sala. Ho detto: non c’è problema, perché è bambino anche quello che suona. Ma in realtà sarà un’occasione favolosa per vedere come la giovane età non equivalga affatto all’immaturità, come talvolta ci sia una pregnanza, una densità, una profondità, proprio in chi sembrerebbe non aver avuto lunga esperienza né della vita né della musica, come questo non precluda la capacità di toccare certe profondità espressive. In realtà, se parliamo di espressione, è una sfida anche questo nostro duetto questa sera, perché io non parlo russo, lui non parla italiano e dice di non parlare inglese: in realtà, come tutte le persone di origine slava ha un dono pentecostale per le lingue, per cui lo capisce meglio di quello che dica lui stesso. Comunque cercheremo di capirci a fonemi, non so, oppure in qualche altro modo, perché si è prestato molto gentilmente a eseguire delle piccole cose per quello che penso possa essere il mio contributo di questa sera. Di solito, si fa una sonata di queste proporzioni ed è già serata. Ne abbiamo ben due, due delle sonate più importanti, più dense, più intense, più tragiche della produzione beethoveniana: e anche lunghe. Quando ho sentito il programma, ho detto: “Io, a che cosa servo?”. Giusto il titolo, come a Radio Tre, “di Ludwig Van Beethoven…”, e fine, perché non c’è tempo di parlare troppo. Però proviamo almeno a fare un assaggino dei temi, perché questo possa servire nel riascolto di chi non è magari abituato ad un ascolto analitico. Anche se poi ho già visto che ci sono in sala tanti musicisti, tanti professionisti, studenti, pianisti, che hanno probabilmente anche studiato e conoscono la partitura meglio di come la conosco io. Però noi parliamo ai bambini e a chi non ha l’abitudine a questo ascolto, la frequentazione di un’idea musicale e ciò che la rende chiara, le dà il senso che ci aiuta a capire. Non serve altro, non serve nessuna altra patente per ascoltare la musica. Ce lo ha insegnato don Giussani, che non era né musicista né musicologo ma batteva sia i musicisti sia i musicologi nella comprensione della musica, solo grazie all’ascolto attento e all’immedesimazione con ciò che ascoltava.
Trifonov eseguirà, per prima, la sonata cosiddetta Tempesta, opera 31, n. 2. Il soprannome Tempesta non fu dato da Beethoven, che lo odiava. Questi titoli, che poi sono rimasti nella storia, quasi sempre venivano dati dal suo segretario, dall’editore o da altri illustri ascoltatori, nemmeno al tempo dell’esecuzione. Ma è dimostrato che questa tempestosità è proprio la categoria che di fatto associa il repertorio di questa sera, quello che hanno in comune queste due formidabili sonate, una categoria di cui parla don Giussani, non necessariamente il tormento, anche, ma anche qualcosa che è possibile associare al momento particolare della vita di Beethoven, che in questi anni scopriva la sordità, a ciò che questo avrebbe implicato per la sua vita, per la sua storia umana, per la sua carriera. Innanzitutto, bisogna dire che, nella sonata La tempesta, tutti i movimenti, i tre movimenti, sono in forma di sonata. E’ un termine che già abbiamo introdotto gli anni scorsi, e anche i giorni scorsi: credo sia un concetto familiare alla maggioranza di voi. Per riprenderlo in pochi secondi: quando diciamo forma sonata, intendiamo un rapporto di tipo drammatico fra le idee musicali. La forma sonata è un dramma in musica, il dramma è l’interazione tra un io e un tu, affinché io o tu, o entrambi, cambiamo alla fine: pensate a un film, pensate a un brano teatrale, la categoria del dramma è proprio là dove l’interazione muta il soggetto. Questa è la forma sonata. Volevo chiedergli del primo movimento, che si dice largo-allegro, un po’ come dire lentissimo-velocissimo: ma allora, lentissimo o velocissimo? Sentiamo soltanto le prime otto battute di questo famoso primo movimento.
musica
Avete già sentito come un indugiare, quasi un trattenere il più possibile il respiro, e poi una perturbazione? Ecco, in fondo che cos’è una tempesta se non la perturbazione di qualcosa che era quieto? Iniziamo con una sola battuta, ma quello che si stabilisce all’inizio è una quiete che viene subito interrotta da un movimento centripeto molto tempestoso.
musica
Centripeto, perché la mano destra scende, la mano sinistra sale, per ritrovarsi al centro. Allora, è questa idea di una specie di mulinello che si crea, proprio una tempesta, un vento che si alza. Questo è solo il preludio, e già stabilisce la cifra della nostra comprensione.
Poi abbiamo il primo vero tema, che sentiamo, dove comincia ad agitarsi, con tuoni e lampi in lontananza. Sentiamo questo tema eroico, molto assertivo.
musica
La mano sinistra al basso fa sentire questo arpeggio e una risposta, quindi abbiamo già anche questo altro dualismo, sempre centripeto, cioè grave e acuto, botta e risposta, domanda e risposta: qualcuno dice tuono e lampo. Non so se vogliamo andare più sull’immaginazione o sulla immedesimazione, che credo fosse ciò che realmente interessava a Beethoven. Il secondo tema è stranamente in la minore. Sentiamo.
musica
Qua non c’è dubbio, non c’è dualismo, qua c’è veramente il turbine, ma è un turbine fatto di che cosa? E c’è anche una irregolarità. Questo modo di fraseggiare così asimmetrico è proprio l’idea di una perturbazione, cioè di un disordine, meteorologico o psicologico, ed è fatto – le appoggiature, come si dice in gergo tecnico – dello stesso elemento che avevamo sentito nelle prime battute, all’inizio. Tutti i critici dicono: oltre a questa tempestosità, un’altra introduzione, nuova, arrivò proprio con questa sonata di Beethoven. E’ l’immissione di un recitativo dentro una sonata strumentale. Ascoltiamolo, e proviamo a capire perché è importante.
musica
E’ come se nel ciclone ci fosse un occhio del ciclone, c’è un punto in cui tutto è calmo, o meglio, c’è spazio anche nel casino della vita, c’è quel punto, quell’istante, quel momento in cui uno può avere una lucidità su di sé. Può esserci una specie di silenzio profondo e anche, quindi, di ragione, di pensiero, di giudizio, in mezzo all’agitazione generale. Il recitativo vuol dire: parlato. Quando è che si usa il recitativo in musica? Quando voglio far capire bene le parole. Nell’opera, se uno dice “che bello, che bello, come son felice”, lo fa con un’aria. Se invece deve dire: “quello è andato là, lei è andata là, abbiamo fatto questa cosa, han detto quell’altra e quindi gli altri han fatto quest’altro”, se deve spiegare una storia, far capire delle cose, usa il recitativo. Ma il pianoforte mica ha le parole: quindi, è la prima volta che viene introdotto, nella musica strumentale, l’idea di un recitativo, come se la musica avesse raggiunto una maturità sintattica, morfologica, e quindi anche semantica sufficiente da poter dire delle cose solo con delle note, senza concetti, senza parole. E’ come se in quel momento Beethoven alzasse, nella tempestosità che lo circonda, una domanda, una preghiera. E infatti, questa tempesta, questo temporale, alla fine non si chiude come normalmente si chiudono le sonate, cioè: dominante tonica più i due accordi finali. Ma con una lunga dominante, con un accordo preparatorio per il finale e un lungo accordo finale, come se fosse una caduta o un passo definitivo, ma un atterraggio lento, un planare, esattamente come, di solito, una tempesta, un temporale se ne vanno, non istantaneamente e di botto: arriva di botto ma se ne va piano piano. Ascoltiamo il finale.
musica
E quindi è veramente uno sciogliersi, come arrivare sulla riva di questa musica, un finale che chiaramente ci fa desiderare altro. Sentiamo l’adagio.
musica
E’ chiaramente una continuazione di ciò che era accaduto prima, sia il recitativo, cioè il dire, l’esprimere, e sia quella calma assoluta dell’inizio e della fine del primo movimento.
Sembrerebbe mancare un elemento, che è quello della tempestosità, ma in realtà, subito dopo questo tema, anche qua emerge, ma in lontananza, come quando un temporale se ne sta andando e si sentono ancora gli ultimi tuoni in lontananza.
musica
Anche questo movimento lento è in forma sonata, vuol dire cioè a due soggetti, ma è esattamente come nell’altro e come sarà nella Appassionata che ascoltiamo dopo. I due soggetti appartengono l’uno all’altro, anzi, uno sviluppa l’altro, cioè, quello che abbiamo sentito ha questa specie di ritmo solenne, come da processione, che viene fuori nel secondo tema, in un modo diverso, più assertivo, più positivo, dolce, sereno. Quella serenità di cui parla Giussani, de “la quiete dopo la tempesta”.
musica
E quindi, fra queste due facce della stessa medaglia c’è questo lirico secondo movimento.
Il terzo, allegretto, è uno dei momenti più formidabili della produzione pianistica di Beethoven, è indimenticabile. E’ uno di quei momenti in cui la verve ritmica di Beethoven prende il sopravvento, come sarà in certe sinfonie, la Settima e altre, che abbiamo ascoltato in passato. Una forza ritmica che lo rende sincopato, grintoso, potente come può essere la più grintosa delle rock band, oggi, anche solo con un pianoforte. Ascoltiamo.
musica
Avete sentito? Intanto, il ritmino della tempesta torna fuori, diventa il tema di questo arpeggio quasi ossessivo. Cosa è ossessivo? Respira, è un’ansia, è un momento veramente di tormento e di ansia, paura di non so cosa, di qualcosa, probabilmente è immaginabile di che cosa, conoscendo Beethoven in quel periodo, ma trascolorato nell’armonia di questi accordi che vengono percorsi dagli arpeggi, tanto che, per esempio, ci sono un paio di accordi un po’ strani.
musica
Ecco, questo tipo di armonia sembra un po’ strana, è la così detta sesta napoletana, è un accordo particolare che, fra l’altro, c’è proprio nella musica anche folk napoletana, che sembra non essere parte dell’armonia. Questo è l’effetto della sesta napoletana che abbiamo sentito nel primo movimento, lo risentiamo qua e lo risentiremo ancora, come una cosa particolarmente presente anche nell’Appassionata. Proprio nel finale di questo turbinoso rondò-sonata, abbiamo un episodio potremmo dire di climax.
musica
La musica, di fatto, sono movimenti in su e in giù, suoni, salto e poi caduta, salto di più e poi cado di più, allora salto ancora di più e poi scendo fino a inabissarmi. Questi sono i due principi su cui Beethoven basava tanto del suo comporre: il principio di forza e il principio implorante. Il principio di forza spinge sempre verso l’alto, forza, voglio, tento, ci provo. Il principio implorante è: ma non ce la faccio, quindi ho bisogno, quindi chiedo, ed è quasi sempre mimato da semitoni discendenti come questa scala cromatica. E così finisce questa scala estremamente emozionante, tormentata: é forse uno dei momenti in cui possiamo intravedere l’inizio del Beethoven maturo, potremmo dire, del beethovenismo di Beethoven, quello che ricordiamo delle grandi sinfonie, delle grandi sonate, forse anche l’affacciarsi del romanticismo. Togliamo il disturbo e l’ascoltiamo interamente.
Sonata op. 31 n. 2, "La tempesta"
ROBERTO ANDREONI:
Poveretto, si è avvicinato e mi ha detto: “Adesso c’è l’intervallo, vero? C’è pausa?”. Veramente no, anzi, cercherò di fare un intervento più breve possibile. Sono due sonate importanti, dense e lunghe, come vi dicevo. Mentre chi deve andare può uscire, adesso, introduciamo la Sonata n. 23 in fa minore, op. 57, soprannominata L’appassionata. Beethoven, a quanto pare, si ispirò nel primo movimento a un tema esistente, una canzoncina folk scozzese, e la usò citandola letteralmente per diverse battute, come secondo tema del primo movimento. Cominciamo con l’ascoltare questo, che fra l’altro è famosissimo.
musica
Forse lo conosciamo tutti, almeno nell’orecchio qualche volta ci è capitato, ma il tema che ascoltiamo nelle primissime battute non è questo. Adesso che avete ascoltato la canzoncina ispiratrice di Beethoven, sono sicuro che riconoscerete come questo prima tema sia nato dopo ma posto prima. Nasce proprio dalla costola, è anzi una variazione vera e propria, un piccolo sviluppo, di questa canzone folk.
musica
Famosissimo anche questo. Ma come sentite, l’inizio va a toccare il fa basso, la nota più bassa del pianoforte dell’epoca, e su quella molto spesso insiste, proprio perché cerca i toni più scuri del pianoforte. Qua la direzione è verso il basso, mentre nel secondo tema è eroica e molto più bilanciata, ma tende a salire. Su questa dicotomia si svolge tutto il primo movimento. Allora, perché – come abbiamo visto nella sonata La tempesta di prima e ora, in questa L’appassionata – Beethoven tira fuori le idee dei due temi l’una dall’altra, invece di fare come ha fatto Mozart, come ha fatto Schubert, come facevano tutti gli altri, e cioè trovare due idee diverse, un io e un tu, due esseri diversi che non abbiano proprio niente in comune nel DNA? E lui, invece, ci tiene, e quasi sempre nelle sue sonate ha questa appartenenza di entrambi i temi ad una stessa cellula. Io ho una sola risposta: non è fra lui e un altro, qua, la questione, ma fra sé e sé. Sono due aspetti di sé. Quello che conta per lui, in questa unità così ossessivamente cercata, è l’io, la questione che lui mette a tema per primo nella storia della musica è proprio il sé, il compositore si mette a nudo, si dichiara e pone la propria problematicità, la propria domanda, la propria incompiutezza e il proprio desiderio indomabile nella propria musica. Deve far sentire che non è solo: io vorrei quella donna lì ma non ce l’ho, io vorrei quella felicità lì, che ho sentito nella canzone, ma per il momento vado verso il basso, come faccio a essere così sicuro di me, come in quel tema che ho ascoltato e che mi piace? Questa è la questione. Il secondo movimento è un capolavoro, secondo me, proprio nella sua staticità più che statuaria. Non so come dire, in effetti non è marmoreo, anche se sembra immobile. Si muove proprio sui tre accordi: tonica, sottodominante, dominante e tonica. Proviamo ad ascoltare le prime otto battute, sentiamo come il movimento musicale sia ritmico, armonico e melodico.
musica
E’ proprio di una immobilità assoluta. Ma da questo tema così bello, così semplice e così immobile, questi piccoli movimenti sono come un embrione, cioè un inizio di una vita. E per le variazioni che seguono, le quattro variazioni che seguiranno, l’immagine che mi sembra più analoga a questa musica è quella dello sbocciare di un fiore, dove non c’è nemmeno una grande azione. Bisognerebbe stare lì ore a guardare, e vedere la fogliolina, e piano piano si scopre che dentro c’è la corolla, c’è altro. E così sarà l’ascolto di queste quattro variazioni. Alla fine, quando risentiamo come quarta variazione questo tema, abbiamo un’altra cosa tipica di Beethoven, un non finale, un passaggio al movimento successivo. Ascoltiamo.
musica
Basso, acuto, trasforma in un dialogo il monologo, dovrebbe esserci l’ultimo accordo, così… E via che inizia con il movimento successivo, che è un infernale moto perpetuo. Di nuovo, torna per concludere il tormento di questa sonata Appassionata, un movimento inesauribile. Ci sono cose che poi sono diventate, in musica, effetti usati e strausati per secoli: l’interrompere il flusso ieratico, tranquillo, sicuro, in un accordo, un cambio dinamico, un cambio di tempo, un cambio armonico, che ci fa capire che la questione non è finita ma si riapre, in un senso probabilmente anche drammatico e imprevisto. Così è l’inizio di quest’ultimo movimento.
musica
Si sente l’orchestra? È ovvio che Beethoven, quando è al pianoforte, è ristretto, sembra di sentire quasi l’orchestrazione già fatta dentro il pianoforte. E va avanti in questa emozionante cavalcata, dentro una foresta misteriosa, che poi è la foresta dei sentimenti, della percezione della foresta di sé, che finisce come è finita la sonata Tempesta. Alla fine c’è un presto, che è una di quelle cose al limite del pacchiano che talvolta fa Beethoven, come in alcune sinfonie. Di colpo – non era già veloce abbastanza, e turbinosa -, la situazione da allegro passa a presto, cioè da un camminare veloce a un correre: diventa quasi un’orchestrina balcanica.
musica
A un certo punto è proprio la fanfara dei bersaglieri che arriva, e alla fine l’inabissarsi. E’ proprio un Dante che scende agli inferi, questo finale qua. Ci sono tanti aneddoti sulla sonata Appassionata, che stupì generazioni di poeti, scrittori, filosofi, pittori. Famosa perché è stata utilizzata per cinema: L’uomo che non c’era, Il Vampiro Armand, e altri film. Ne Le vite degli altri, per esempio, che è un bellissimo film recente, c’è la citazione di Lenin che disse: “Devo smettere di ascoltare questa Sonata, se no esito a portare a termine la rivoluzione”. Io ci ho pensato, a questa citazione, perché? Uno come Lenin non è che fosse un sentimentale: “Oddio, mi commuovo a tal punto, ho una tale emozione che smetto la rivoluzione”. Cosa voleva dire? Perché diceva una cosa così? Non per le emozioni, ma perché Beethoven, imperiosamente, pone al centro un’altra questione rispetto a quella che interessava a Lenin, cioè l’io. Ascoltando Beethoven, si capisce che il problema non è la società ma sei tu. E’ questo che inquietava l’ascoltatore dell’epoca materialista, perché, al di là della psicologia che non esisteva ancora, c’era proprio una questione che veniva posta su un altro piano che non quello dell’ordine sociale: quello dell’ordine interiore e la coscienza di sé. Allora, entriamo nei meandri della conoscenza di sé, come ci invita a fare questo Meeting, della conoscenza dell’uomo, della conoscenza di Beethoven e della cultura da cui proveniamo, ascoltando questo capolavoro da Daniil Trifonov. Grazie.
Sonata op. 57 “Appassionata”
PIER PAOLO BELLINI:
Allora, velocissimamente ricordo gli avvisi: prima di tutto il cd di Spirto Gentil con le sonate di Beethoven è disponibile all’esterno. Ricordo che domani l’appuntamento sarà con Rachmaninov, al pianoforte Nazareno Carusi, e che la presentazione sarà fatta da un nostro amico, Pier Paolo Bellini.
(Trascrizione non rivista dai relatori)