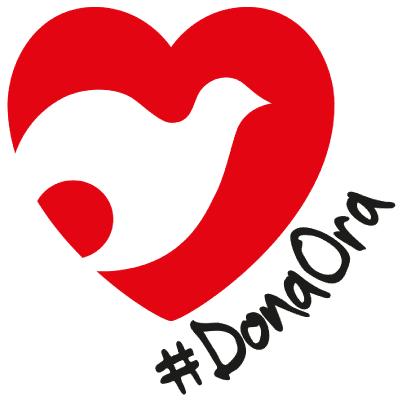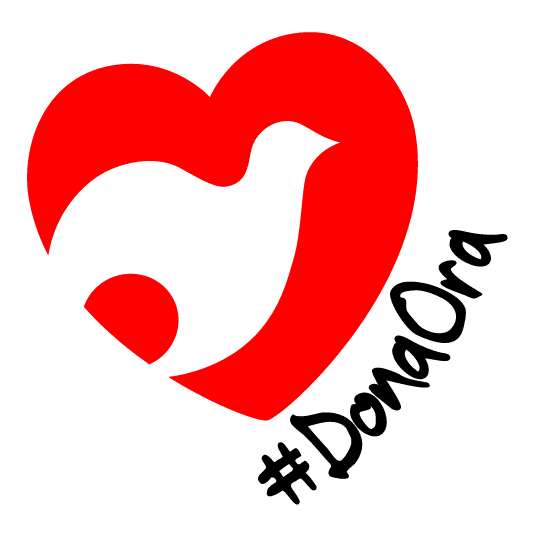Chi siamo
GUIDA ALL’ASCOLTO DAL VIVO – Collana “Spirto Gentil”
Dal vivo – Collana “Spirto Gentil” CD 7
I Cameristi Toscani; Luca Belloni relatore: Schubert Quartetto per archi n. 14 in re minore, D 810 “La morte e la fanciulla”.
PIER PAOLO BELLINI:
Bene. Se prendiamo posto possiamo cominciare. C’è da fare un piccolo ringraziamento al Meeting per questa sede che ci ha offerto quest’anno, molto più adeguata degli altri anni, è un ringraziamento sentito. Dopo l’introduzione di ieri, un passaggio successivo che è stato quasi involontariamente suggerito dal testo che è stato letto di don Giussani, che riguardava appunto il preludio di Villa-Lobos, è un accostamento, proprio fatto da Monsignor Giussani, tra quel preludio e un’altra composizione drammaticamente attuale, come quella che ascolteremo oggi, esattamente questo brano di Schubert che ascolteremo, “La morte e la fanciulla”. Io ho detto anche ieri, e LO riprendo, perché vedo molta gente che ieri giustamente non c’era, spero che questo ciclo proposto da Spirto Gentil sia un contributo dato dalla musica a quello che è il tema centrale di questo Meeting. Penso che anche la musica e l’esperienza artistica possano in qualche modo far emergere la verità di questo titolo, “la conoscenza è sempre un avvenimento”, ed è di fronte a un avvenimento che è possibile comunicare anche la profondità, anche la bellezza del Mistero che sta dietro ad ogni avvenimento. Ieri siamo partiti con un suggerimento, come faremo anche oggi, un suggerimento introduttivo di don Giussani, che diceva: “Nei pezzi di Villa-Lobos si sente immediatamente una cosa sola, la vita”. Ecco, la vita è il primo avvenimento, che può diventare testimonianza artistica, può diventare stupore, può diventare commozione. Oggi ascolteremo una cosa diversa, intensamente e drammaticamente diversa, anche se con la stessa profondità e con lo stesso spessore, che è un bramo dedicato a quello che normalmente consideriamo il contrario della vita, cioè la morte. Il tema di questo brano, scelto da Schubert, è un dialogo tra la fanciulla, tra una giovane donna, tra una speranza di vita e quello che invece sembra essere la sua contraddizione, cioè la morte. Non so quanti di voi abbiano visto, ieri ripensavo a questo, il film, il documentario registrato della Moldava di Smetana, diretto da Fricsay, ed è commovente, perché questo direttore, che sarebbe morto di lì a pochi mesi, dice una frase stupenda: “Come è bello vivere”. Ecco, quello che ascolteremo oggi sembra una contraddizione: di fronte al desiderio di vita, l’incombere inevitabile della morte. Leggo queste due righe di don Giussani: “La morte è un fatto e il fatto, presto o tardi, si impone. Contro i fatti non si può fantasticare all’infinito. Davanti alla morte cerchiamo di vivere con la nostra cautela, ma l’evidenza del fatto è troppo forte e l’uomo sembra cadere e piangere”. Questo lo sentirete dal brano di Schubert. Non aggiungo altre parole, perché abbiamo qui un amico e un maestro che ci guiderà. Passo a presentarvi i nostri ospiti, molto velocemente, ci sarebbe un curriculum molto lungo da leggere, ma siamo essenziali per via del tempo. Abbiamo qui tra di noi ad eseguire questo brano – oltretutto lo sentiremo in versione integrale, perché il tempo c’è – i Cameristi Toscani. È un gruppo da camera fondato nel ’96, che svolge un’intensa attività cameristica in tutta Italia. Gli strumentisti che lo compongono, collaborano stabilmente con importanti orchestre italiane – Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Nazionale della RAI – e svolgono attività didattica presso conservatori e importanti istituzioni musicali. Abbiamo, li nomino semplicemente per nome, Marco Zurlo e Alessandro Alinari al violino, Andrea Pani alla viola e Francesco Fontana al violoncello. Saremo aiutati a penetrare, a essere introdotti dentro questo capolavoro musicale da un amico, ormai fedele del Meeting, un amico personale, un amico anche della collana, il maestro Luca Belloni, che è compositore e direttore d’orchestra. Sue composizioni sono state eseguite in prestigiose sedi, ha fondato e dirige l’Ensemble “Webern”, con il quale svolge un’intensa attività concertistica volta alla valorizzazione del repertorio contemporaneo; ha realizzato molte guide all’ascolto di Spirto Gentil. Gli lascio immediatamente la parola. Ho dimenticato un’ultima cosa: come ieri ricordo, i suoni qui sono importanti, qualunque tipo di rumore è fastidioso, soprattutto quello dei telefonini, per cui controllate lo spegnimento delle vostre suonerie. Grazie.
LUCA BELLONI:
Intanto buona sera a tutti. Vorrei dire che io avevo pagato i miei parenti per venire a questo incontro, anche alcuni amici, insomma fin dove arrivava il mio conto in banca, il mio piccolo conto in banca, facendo il musicista. Il vero avvenimento è vedere tutta questa gente qua davanti, venuta a sentire Schubert. Questa è una cosa, voi non avete presente, ma non si trova molto in giro per il mondo. Quando fanno i quartetti di Schubert normalmente ci sono 50 persone in sala, già quando uno ha più persone in sala che sul palco, dice: “è già una buona cosa, sono in 4 di qua, sono in 10 di là”, senza nulla togliere ai quartetti di Schubert, per carità del Signore. Questo come introduzione. La cosa che vi chiedo soltanto è di non avere nessun tipo di chiusura o di apertura preconcetta nei confronti di questa musica. Siete venuti tutti a sentire una pagina che è indubitabilmente un capolavoro, ma se voi siete venuti solo ad ascoltare un capolavoro, non lo ascoltate davvero, perché qualsiasi cosa vi venga detta non riesce ad arrivare fino a voi, perché avete lo schermo “Oh mamma, che bello, è un capolavoro”, qualsiasi cosa dica Schubert, non vi interroga. Una pagina così drammatica, una pagina che inizia come sentiremo adesso, è una pagina che ha bisogno di tutta l’apertura di cui voi siete capaci, di cui sono capace io. Voi avete fatto anche fatica per venire qua, perché siete in tanti, il Meeting è un posto climatizzato, ma fuori non è climatizzato, c’è tantissima gente, per andare in libreria prima ci ho messo 20 minuti, poi io peso più di 100 chili, 20 minuti di cammino sono quello che faccio normalmente in 2 settimane di movimento, quindi è veramente…è stato un avvenimento anche quello per me, è stata la conoscenza che è diventata un avvenimento. Ora, bando alle ciance. Cominciamo. Quello che presenteremo è il quattordicesimo quartetto di Schubert, si chiama “La morte e la fanciulla” per un motivo che vedremo tra poco. Intanto iniziamo subito con una domanda, che è posta all’inizio del brano.
musica
Abbastanza impressionante, non so che cosa pensate voi, ma… è una domanda. Schubert ha il coraggio di chiedere quello che normalmente noi non chiediamo mai, anzi è l’unica cosa che noi normalmente alla mattina non vogliamo vedere. Schubert dice: “Che cosa è la vita? Che cosa è la morte?”, perché chiedendo che cosa è la morte uno chiede che cosa è la vita. A uno non gliene frega niente della morte; a meno che qua fra voi non ci sia un necrofilo, a uno della morte, a me della morte non me ne frega niente, se non per la vita che sembra contraddire. E infatti Schubert inizia così proprio per questo, è una specie di lama. Questo quartetto si chiama “La morte e la fanciulla” per un motivo molto banale se volete, ma in realtà molto più profondo, perché è preso, è ispirato, soprattutto nel suo secondo movimentoche sentiremo più avanti, ad un Lied, cioè a una composizione per voce e pianoforte che Schubert scrive nel 1817, quindi circa 7 anni prima di questa composizione, che si chiama appunto “La morte e la fanciulla”. E’ uno strano dialogo, vi leggo il testo rapidamente, vi ricordo soltanto una cosa, che in italiano la traduzione non rende giustizia a una particolarità del tedesco. In tedesco la morte non è femminile è der Tod, è maschile, per cui il dialogo è tra la fanciulla e la morte che è in realtà un essere non meglio identificato, ma di sesso maschile. La fanciulla dice così: “Vai via, sparisci, vattene orrendo scheletro, io sono ancora giovane, vattene, non toccarmi”. La morte risponde in una maniera stranissima: “Dammi la tua mano, bella creatura delicata, sono un amico, non vengo per punirti, su coraggio, non sono cattivo, dolcemente dormirai tra le mie braccia”. È una cosa strana, c’è una specie di inversione di segno fra quello che normalmente si immagina essere la morte, questo essere con la falce, e la vita rappresentata dalla ragazza, che in realtà è lì che si mette la mano intorno al volto. Questo atteggiamento di Schubert è molto significativo, perché tutto il quartetto è segnato da questa cosa. E il dialogo, questo dialogo, è un dialogo che tutti comprendiamo abbastanza bene. Chi di voi vorrebbe trovarsi faccia a faccia con la morte? Vorrei fare alzare le mani se fossimo in classe. Penso che nessuno si vorrebbe trovare faccia a faccia con la morte. C’è una persona che vorrebbe trovarsi faccia a faccia con la morte? Uno. Non ho capito. Ah, stai scherzando. Insomma, si scherza con il fuoco, comunque,…In realtà dopo questa domanda, che è una domanda profondissima, è una domanda che tutti si possono porre, il problema è essere all’altezza di questa domanda, cioè rispondere in qualche maniera. Vediamo che cosa fa Schubert. Sentiamo tutto l’inizio, proprio la primissima frase del quartetto. State attenti perché succedono molte cose in questa prima parte del quartetto.
musica
Che cosa strana! Fa questa domanda, pone questa domanda, uno dice: “Oh Madonna, adesso sicuramente risponderà, darà una risposta, cercherà,…no. La voce si affievolisce ta ta ta ti, ta ta ta ti, pieno di pause, non sa più che cosa fare. È come uno che ha trovato una cosa vera e poi dice: “Boh, io non sono mica all’altezza di questa cosa. Cosa faccio? Io non sono capace di rispondere, forse non vale neanche la pena”, come dicono tutti, no, ma che cosa te ne frega, hai da lavorare, abbiamo gli immigrati alle porte, che vadano dal papa, tutte queste cose qua, no…figurati se te ne frega della vita e della morte. Queste sono le domande che si pongono normalmente al bar dello sport e dell’estate. Non voglio parlare di politica, ovviamente, ma è po’ questo il livello, il livello è cosa te ne frega a te, ma sì, mangia, c’è la sagra – io, per altro non sono esattamente un igienista dell’alimentazione, sono un sostenitore della tesi che “morire sani, che gusto c’è”, sempre un problema di rapporto con la morte e con l’alimentazione, ovviamente – però, quello che sto dicendo, è come se Schubert tirasse un po’ i remi in barca in questa parte qua, ma non può, non può farlo, come non potete voi. Chi di voi può dire: “Ho visto una cosa vera e poi me la metto via, come se non fosse mai esistita”, me la posso metter via, ma non posso fare come se non fosse mai esistita. Ogni gesto che voi fate, ogni gesto, qualsiasi gesto, dall’alzarsi alla mattina al lavarsi i denti o fare qualsiasi altra cosa, venire a sentire un cretino, ciccione che fa le presentazioni di Spirto Gentil – che ovviamente non sono io, perché sono magro, non perché non sono cretino – tutto questo ha un valore implicito, che viene esplicitato nel gesto. Voi prendete e, invece di andare al bar a bervi una bella birra gelata, venite qua a sentire questa cosa. Evidentemente c’è qualcosa che vi muove, ed è la stessa cosa che fa in modo che Schubert non possa in nessuna maniera cancellare quella domanda, che vi faccio adesso risentire nel suo aspetto germinale. Fate bene attenzione perché musicalmente sono 5 note che scendono per due volte. Questa cosa ritornerà diverse volte, soprattutto nell’ultimo tempo, in maniera completamente cambiata. Fate attenzione all’asse portante di questa domanda.
musica
Ricordatevi questa cosa, ricordatevi, perché è veramente una cosa, come dire, fondamentale, perché questa domanda comincia a pervadere tutto quello che fa Schubert subito dopo quello che avete sentito. È una cosa talmente urgente che non c’è niente che non sia fatto di questa domanda. È come quando avete una preoccupazione o come quando c’è una cosa molto bella nella vostra vita, tutto è tinto di quella cosa lì, anche se non ci pensate, tutto in qualche maniera sgorga da quella cosa lì, da quella passione, da quell’ amore, oppure da quel dolore, da quella lacerazione, da quel desiderio, da quello che volete voi, ma tutto è tinto di quella cosa. Infatti Schubert tinge tutto con queste note, la melodia portante sembra un’altra, ma se ci fate caso, le voci interne continuano a fare sempre queste, questo tema della domanda, prima piano, poi più forte, ma è costantemente presente.
musica
Avete sentito? Avete notato che c’erano continuamente queste 3 note? Non nella melodia principale, nelle voci interne, solo che Schubert continua a domandare, domanda e domanda, ma questa risposta non arriva. E allora che cosa si fa? Purtroppo nella dinamica quotidiana dell’uomo quando la risposta non arriva uno abbassa il tiro, giusto? Che cosa fate voi? Quando desiderate talmente tanto una cosa – e da soli, uno non è mica che se la può dare, non se la può fare di legno, dicono al mio paese. E allora Schubert prova a girare la testa per un momento, prova a fare un’altra cosa, a dire una frase lieta, se non lieta almeno spensierata, ma sentite che cosa gli salta fuori, sentite che cosa salta fuori. A me fa impressione, perché è come se io vedessi una parte della mia giornata, perché queste cose capitano tutti i giorni, non è che capitano a Schubert perché era…Schubert ha avuto la grazia di saperle dire, ma queste sono cose che capitano a tutti voi, a me, a Pier Paolo, tutti i giorni, o quasi, spero insomma che non capitino a molti di voi, ma temo che così sia. Sentiamo che cosa fa. Il secondo tema è come se fosse spensierato, senza drammi, volesse essere senza drammi. Fate attenzione. Dopo vediamo se qualcuno di voi ha notato la persistenza di qualcosa di un po’ singolare.
musica
Ci sono due cose che a me colpiscono in questa frase: uno, il fatto che il ritmo della domanda, trasformato, rimane anche in questo tema. È un tema apparentemente, deliberatamente di segno opposto rispetto all’altro, ma è segnato profondamente da quell’altro tema, e poi un’altra cosa, non so se avete fato caso: le frasi non finiscono, non vanno mai là dove voi immaginate che vadano. E’ come se uno progettasse tutto. Guardate a me è capitato così questa mattina. Io stamattina ho detto: “adesso parto, faccio tutto”, io abito a 200 km da Rimini; per strada è successo di tutto, in albergo è successo l’“ira di Dio”, non è andato niente come avrei immaginato che potesse andare. E Schubert fa un pochettino la stessa cosa; prova a fare una cosa lieta, cercando di cancellare; dice “ma quella domanda chissà che cosa…”, resta sotto, perché non può non essere così, ed a un certo punto il tema stesso deraglia e va nell’altra direzione, tanto è vero che non soltanto fa così ma addirittura quel tema diventa quasi una nuova ossessione, diventa il sostituto di quella domanda. Guardate come trasforma Schubert questo tema, facendolo diventare una cosa drammaticissima, con imitazioni, con gli strumenti che si gridano da una parte all’altra questo secondo tema che doveva essere lieto e si è trasformato nelle mani del compositore in qualcosa di assolutamente drammatico.
musica
Avete visto cosa è successo in pochissime battute? Adesso sentirete tutto il movimento. In pochissime battute è successo qualcosa di impressionante. È come se da un barlume di sole si sia passati a una tormenta, è terribile, e ancor di più questa cosa si nota quando nella parte centrale del quartetto, che adesso vi farò ascoltare, i due temi vengono avvicinati deliberatamente; è una specie di corpo a corpo, si avvinghiano, cominciano a lottare uno con l’altro. Mi veniva in mente quello che dice il “Victime Pasquali” la sequenza del giorno di Pasqua “la morte e la vita combatterono a duello in un duello mirabile”. Sembra quasi veramente che Schubert e la vita si avvinghino l’uno contro l’altro, cercando di trovare una soluzione ad un problema che da solo Schubert non può risolvere. Sentite che cosa succede
musica
Avete sentito cosa succede? Il tema, quello della terzina, ad un certo punto dilaga e l’altro gli si oppone. È come se si avvinghiassero continuamente, è come se il problema fosse talmente rovente da non poter essere risolto. Ma a voi non è mai capitato una cosa del genere? Sono quelli che vengono chiamati inconvenienti o disgrazie nella vita. Penso, temo che sia capitato a tutti voi. L’evidenza con cui lo dice Schubert non toglie il fatto che questo per ognuno sia una domanda, sia un’interrogazione, tanto è vero che, dopo questo, Schubert tenta di rimettere tutte le cose a posto. Ripresenta i due temi, quello della domanda e quello tentativamente spensierato, e sembra che tutte le cose debbano andare come la buona creanza, cioè le forme musicali classiche, vogliono; ma Schubert non si può accontentare di una cosa così. Ma chi si può accontentare di una cosa così? Chi può accontentarsi di fare un gesto senza significato e infatti Schubert ad un certo punto, quando sembra che tutto vada a finire, guardate che cosa fa:
musica
Che cos’è? È come qualcosa che incombe. Quella domanda non può essere rimossa e quindi incombe su tutti noi. È impressionante quel punto, e ancora più impressionante è la fine, la fine del primo movimento. Schubert sembra non riuscire ad essere all’altezza di questa cosa e si abbandona ad una specie di bruma, dopo un momento di accensione, che è veramente sconsolante. Se voi pensate che il mondo potrebbe essere così, vi viene da piangere, vi viene davvero da piangere.
musica
Finisce come in un sospiro, sembra finire nel niente. Vedremo dopo se è effettivamente così. Adesso ascoltiamo tutto il primo movimento
musica
Siamo arrivati a questo punto; l’applauso lo facciamo alla fine dei 4 movimenti, ringrazio per la bellissima esecuzione; siamo arrivati a questo punto e da questo punto Schubert riparte. Vi vedo un po’ straniti; tutto questo tuonare e poi non piove; anzi sembra queste giornate. A casa mia ogni giorno passano delle nuvole, passano, ci salutano allegramente e poi ritornano da dove sono venute e ci sono sempre 37°; più o meno Schubert fa la stessa cosa. Il secondo movimento però e molto più eloquente da un certo punto di vista, perché è quello che prende il tema della morte di quel pezzo per canto e pianoforte di cui vi dicevo, “La morte e fanciulla”. Le note che sentirete, all’inizio, sono prese direttamente dall’introduzione di quel pezzo, di quel Lied, trasportati di tonalità, sono in Re minore mentre qua sono in Sol minore, ma sono la stessa cosa e la cosa che mi colpisce di più è che qui Schubert vede tutto quello che è successo come se fosse una scatola. Voi vivreste bene in una scatola? Ricordo un esempio di don Giussani, un esempio molto famoso: immaginatevi l’universo come una scatola infinitamente grande ma non infinita, appunto. Ditemi se non vi sentite soffocare; prima o dopo il fatto di sapere che c’è un confine è una cosa che vi disturba e qua Schubert sembra vinto da questa idea della morte come un confine oltre il quale non c’è niente, anche se uno non può accettare questa idea perché uno è lì che desidera la vita, come diceva Pierpaolo prima, e tu mi dici che non c’è niente? E allora che cosa fa? Fa una specie di trasposizione musicale di questo confine, di questo cielo plumbeo. Baudelaire diceva “quando il cielo basso e greve pesa come un coperchio sull’anima che geme in preda alla lunga noia”, è quello che Baudelaire chiamava lo “spleen”. Ecco, un po’ questa cosa c’è all’inizio; perché sentite il primo violino: per quasi tutta la frase tiene soltanto una nota e quando si sposta, si sposta di un piccolo passettino e poi torna indietro; è come se fosse un tappo che tiene giù qualsiasi forma di anelito; nessuno può salire, nessuno può andare verso il cielo, perché la morte è l’ultima parola. All’inizio Schubert sembra dire questo. Proviamo a sentire il tema:
musica
Avete sentito? È tutto tappato verso il basso; è come se non ci fosse possibilità di sbocco. Ma questo per l’uomo, non è possibile. Per voi non è possibile! Se io vi dicessi che la morte è la fine di tutto, anche chi dice di crederci, no, non ci può credere! Perché dentro di lui c’è una cosa più grande di lui! È questo l’avvenimento vero della vita, che oggettivamente dentro l’uomo c’è qualcosa di più grande dell’uomo che gli dice che anche se lui pensasse un miliardo di volte che la morte è la fine di tutto e la vita non ha un significato, c’è qualcosa dentro di lui che usa la vita in una altra maniera rispetto a quello che lui sta dicendo. Fortunatamente noi facciamo diversamente da quello che diciamo, sia quando facciamo il male sia quando facciamo il bene. Questa è una grande fortuna. Infatti Schubert immediatamente che cosa fa? Mostra che questa visione è inquietante e infatti questa inquietudine si trasforma nel fatto che il violino fa un ritmo tutto sospirante e gli altri strumenti fanno una terzina, il secondo violino fa una terzina, fa un ritmo diverso da quello. Sentite la prima variazione, subito il primo il commento che Schubert fa a questo plumbeo cielo della morte è questo:
musica
Sentite come vuole salire, non può non salire, è fatto per quell’altra cosa là, ma non sa come andarci. E allora questo desiderio ad un certo punto (c’è la seconda variazione che non vi faccio sentire), quando non trova più sbocco, è un po’ come qualcosa che viene continuamente compresso e che cosa succede? Succede che, come nella legge delle molle, scoppia con tanta maggior veemenza. Un uomo tormentato così rischia di diventare ossessivo e violento. Quando a uno che ha dentro il cuore il desiderio dell’infinito viene detto che l’infinito non c’è, questo si “incazza”, scusatemi; se è un uomo si “incazza”, perché dice “com’è? Io ho fame e mi danno da mangiare, ho sete e mi danno da bere, voglio essere amato e posso aver qualcuno che mi ama e il desiderio più grande che ho non me lo soddisfa nessuno? Ma io ti spacco la faccia! E questo è quello che fa Schubert, nella terza variazione. La terza variazione comincia a diventare ossessiva, sempre lo stesso ritmo, come una cavalcata, come qualcosa di impetuoso, è violenta perché è sempre in fortissimo. Ad un certo punto si assottiglia ma il ritmo rimane sempre ossessivo. Ascoltiamo:
musica
Avete sentito? Questa ossessione continua è qualcosa che ancora una volta non può bastare, ovviamente. A chi di voi basterebbe un’ossessione nella vita? Infatti Schubert ad un certo punto fa una cosa che assomiglia molto a quello che potremmo chiamare il barlume di un miracolo. Questa sera ho trovato una frase sintetica, in un librettino, di quello che succede in questo quartetto; succede qua e succede alla fine del secondo movimento; questa frase dice così: “mi feci trovare da chi non mi cercava; dissi eccomi! a chi non invocava il mio nome”. Schubert andando a tentoni, come direbbe San Paolo, cercando di qua e di là questo significato, “incazzandosi”, essendo un uomo, ad un certo punto capisce che si può guardare la realtà in un’altra maniera, senza tutta quella pretesa di avercela in mano. E questo genera una variazione, che non vi faccio sentire per non togliervi la sorpresa, in cui sembra che tutto si apra; ma non è ancora l’ultima parola. Infatti la variazione successiva ancora ritorna tormentata; il primo violino è come se trafiggesse le note; ci sono continuamente delle note ribattute. È come se questa disillusione, dopo questo iniziale albore di speranza, fosse ancora più crudele, ma non è l’ultima parola.
musica
Avete sentito questa continua trafittura? Ebbene adesso questa trafittura, questa inquietudine, questa cosa che non dà pace, Schubert non ha pace!, ma chi di voi potrebbe avere pace se io gli dicessi che suo marito, sua moglie, la donna che ama, suo figlio non servono a niente, sono destinati ad andare a concimare la terra? Chi di voi starebbe tranquillo pensando che lui o le persone che ama sono destinate a questo? Ma chi? Tutti vi ribellereste! Schubert è capace di dirlo, ma ognuno di voi è capace di dirlo. Infatti la fine è quella in cui Schubert si aggrappa all’unica intuizione di positivo che ha avuto in tutto il movimento. Ha avuto come quel dono, quel momento in cui Qualcuno si è fatto trovare pur non cercato, non cercato esplicitamente, con un nome “mi feci trovare da chi non invocava il mio nome” ma mi invocava in un’altra maniera, e quel momento di positivo ritorna alla fine e accende un specie di alba un po’ più duratura. Avete presente appena sorge l’alba quando uno non riesce ancora a distinguere se sia notte, se ci sia un “polline di luce”, come diceva Rebora, ecco quella cosa lì comincia a prendere una dimora un po’ più stabile all’interno del quartetto, diventa tutto un po’ trasfigurato. Tutto in pianissimo, è ancora precario. È come se fosse di vetro, però c’è, però non è uguale a niente. Sentite la fine di questo movimento
musica
Bene. E da questo barlume di speranza adesso ascoltiamo tutto il movimento e poi vediamo che cosa succede.
musica
Bellissimo. Sì, un applauso ci vuole. Scusate, sarò lapidario sul terzo movimento. Dico agli amici: “volete fare il quarto direttamente, vista l’ora?”. Sarò lapidario sul terzo movimento. Allora il terzo movimento è il momento della prova. Una volta che uno ha scoperto questa cosa che non si è dato lui, che cosa succede? Vediamo se “tiene botta” di fronte a tutto quello che succede nella realtà. Sentite che cosa fa Schubert
musica
Bene. Ora rapidamente l’ultimo movimento che è un po’, stranamente, il cuore di tutto quello che succede; è il punto in cui il risultato si stabilisce: chi vince? La vita? La morte? È una cosa stranissima quello che succede; l’avete sentito, quella speranza che si era accesa nel secondo tempo è rimasta nel terzo, tutta la parte centrale, quella specie di danza. E ora che cosa succede? È una delle rarissime volte della produzione di Schubert, soprattutto della produzione tarda, in cui fa una cosa che poche volte nella storia della musica avviene: prova a vivere in una maniera avventurosa. L’ultimo movimento è veramente un’avventura. Ne succedono di tutti i colori. Parte con una specie di cavalcata, una specie di danza, che si trasforma di volta in volta in un inno; c’è un tema centrale fatto in fortissimo da tutti gli strumenti e ad un certo punto sembra che si stia sfaldando; è come se uno affrontasse tutta la realtà con un barlume di ipotesi positiva. Perché ha quell’ipotesi positiva? Perché sa che non dipende da lui. Sa che non dipende da lui; nessuno gliela può togliere. L’ha messa alla prova nel terzo movimento e ha visto che non dipende da lui. Per quanto lui sia miserabile, per quanto lui sia una schifezza, per quanto io sia miserabile, nessuno me la può togliere. E questa è la fonte di quel finale (che è l’unico esempio che chiedo di fare della battuta 707, quello della doppia stanga finale per cortesia; ringrazio il quartetto anche per questa prontezza e gentilezza nel seguire), che è una cosa che io non ho quasi mai sentito, perché sembra un finale trionfale ma è anche un po’ drammatico e contemporaneamente c’è questo zampillo di gioia e questo dramma, presenti non uno da una parte e uno dall’altra, come accade normalmente, ma mischiati, mischiati come se fossero la stessa cosa. Io mi domandavo che cosa c’è nella storia, nella vita, di fatto così? L’unica cosa che mi è venuta in mente, l’unica cosa, perdonatemi, è il Corpo glorioso di Cristo, che ha le piaghe del costato, delle mani, dei piedi per sempre, per l’eternità. Il Corpo glorioso di Cristo è fatto così, è pieno di gloria, è il corpo di un risorto e contemporaneamente porta i segni di quel dolore. È come se fosse il paradigma di cosa può essere l’uomo, è il paradigma dell’uomo, è il destino dell’uomo e Schubert lo fa vedere miracolosamente in questo finale. Provate ad ascoltare.
musica
Con questa baldanza impressionante, con questo coraggio, con questo non aver paura di nulla perché si sa che c’è Qualcuno che mi sta portando, Schubert svolge tutto questo movimento che adesso vi propongo all’ascolto e vi ringrazio per la disponibilità che avete avuto.
musica
PIER PAOLO BELLINI:
Scusate, ma ho l’ingrato compito di chiudere questa sala. Do due brevissimi avvisi. Innanzitutto ringraziamo sia i Cameristi toscani che il Maestro Luca Belloni per questa grande introduzione al capolavoro di Schubert. Ricordo velocemente che all’uscita è disponibile la registrazione del CD “La morte e la fanciulla” dentro la collana di Spirto Gentil e ricordo che l’appuntamento è per domani, per un’ altra presentazione, un po’ sui generis. Sono dei canti napoletani realizzati, cantati da Antonio Attanasio e introdotti da Massimo Bernardini. Alle 19.00, sempre qui, in Sala Neri. Grazie e arrivederci a domani.
(Trascrizione non rivista dai relatori)