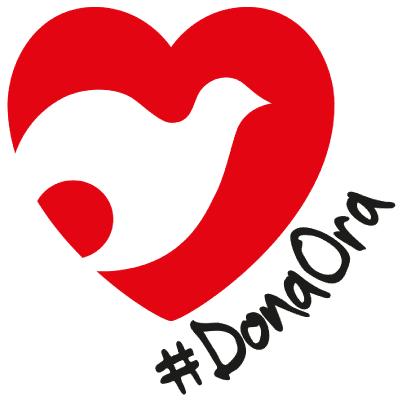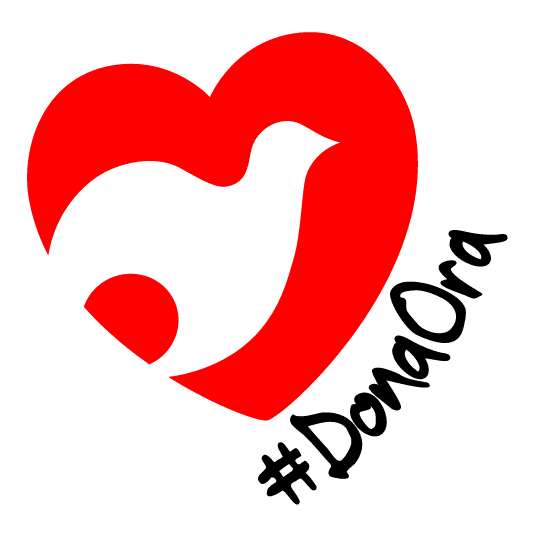Chi siamo
GUIDA ALL’ASCOLTO DAL VIVO – Collana “Spirto Gentil”
Brahms – Quarta Sinfonia in Mi minore Op. 98. Introduce Luca Belloni.
MODERATORE:
Ieri abbiamo visto come il protagonista può essere inteso come l’uomo che tenta di emergere, di distinguersi da tutti, di distinguersi da tutto il resto attraverso lo sforzo, attraverso le sue capacità, attraverso anche la capacità di bellezza, attraverso il virtuosismo come era il violino di Beethoven.
Questa sera saremo aiutati a fare un passo ulteriore. Questo programma di Spirto Gentil quest’anno forse ci aiuta a prendere più coscienza attraverso la musica del contenuto di questo Meeting. Il brano che ascoltiamo oggi è molto diverso da quello di ieri, non solo formalmente: non c’è nessuno strumento solista, è un brano orchestrale, molto impegnativo, che abbiamo deciso di fare ascoltare nella sua versione orchestrale, quindi inevitabilmente non dal vivo. La Quarta Sinfonia di Brahms è stata letta e intuita da don Giussani come una cattedrale, una cattedrale enorme, stupenda, caratterizzata – questa è l’idea che vorrei lanciare poi al Maestro Belloni che è venuto qui ad aiutarci – caratterizzata da un desiderio, da una volontà. Ieri abbiamo visto qualcuno che si stacca da tutto; l’idea di questa Quarta Sinfonia, almeno lo spunto dato da don Giussani, è invece il tentativo di abbracciare tutto. Don Giussani dice, commentando questa Sinfonia di Brahms: “In essa vedo lo slancio della ragione che si protende verso la realtà, che si spalanca ammirata alla totalità del mondo nella sua ricchezza di particolari organici, è un abbraccio cosmico”. Io penso che come idea, come metafora, sia un interessante punto di partenza per addentrarci dentro questo capolavoro straordinario e anche grandissimo – non potremo ascoltarlo tutto evidentemente. Per aiutarci in questo abbiamo qui tra di noi un amico, che è già venuto altre volte, è il Maestro Luca Belloni, attualmente docente di Analisi delle Forme Compositive presso il Conservatorio di Adria. Oltre ad avere questo titolo, personalmente lo conosciamo come una persona capace di condividere, di immedesimarsi con i brani che ascolta e che propone, per cui gli chiediamo di aiutarci in questo.
Forti dell’esperienza di ieri sera, vi chiederei di dare un occhio ai vostri cellulari, perché i suoni in questo caso sono molto importanti e anche molto fastidiosi.
Grazie Maestro, a lei la parola.
LUCA BELLONI:
Grazie mille a Pier Paolo della bella introduzione e un saluto a tutti voi. Vi ringrazio soprattutto dell’applauso, perché è meglio avere prima un applauso così, almeno se dopo non succede niente, posso almeno dire che uno l’ho beccato.
Io inizio ricollegandomi a quello che diceva Pier Paolo, alla citazione di don Giussani, facendo un’altra citazione: “Tutti i giorni che passano nella mestizia, Dio li compirà alfine in gaudio”.
Questa potrebbe essere tranquillamente una definizione un po’ poetica, ma sicuramente efficace, di quella virtù che i cristiani chiamano speranza. Perché, cito da un caro amico che mi ha scritto una lettera su questo argomento, si chiama Giuseppe Ratzinger, detto Benedetto XVI per gli amici, “nella speranza siamo stati salvati, dice San Paolo ai Romani. E anche a noi la redenzione, la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto, la redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il presente”. Non sto facendo catechismo, centra con la Quarta Sinfonia di Brahms, perché è l’opera di un uomo che cerca disperatamente la speranza. Vi dico il finale, così almeno se qualcuno non vuole vedere il film sa come va a finire, però è appassionante sapere come va a finire, e soprattutto come ci arriva. Brahms, ed è molto curioso, prende queste parole che vi ho letto dall’ultimo movimento di una Cantata di Bach, musicista sacro per eccellenza – la quasi totalità della produzione di Bach che ci arriva è musica sacra – e prende proprio il passo – poi vi farò sentire come – dell’ultimo movimento di una Cantata che ha come testo “Tutti i giorni che passano nella mestizia, Dio li compirà alfine in gaudio”. Brahms, per fare il monumento più maestoso, quello che davvero, come diceva Per Paolo, come diceva don Giussani, vuole abbracciare tutto il mondo senza più vergogna, senza più reticenza, senza più nulla, ecco prende fra i milioni di temi che la storia della musica nel 1885 gli offriva, prende proprio un tema che ha queste parole. Ora voi direte: bene, che problema c’è? Il problema “piccolo” è che Brahms si è sempre dichiarato, scandalosamente anche, ne parlavamo prima in un salottino con Pier Paolo, si è sempre dichiarato ateo. Era un ateo con qualche contraddizione, devo dirvi la verità, perché era un ateo che tutti i giorni che Dio mandava in terra, o che il nulla secondo lui mandava in terra, leggeva una pagina della Bibbia; ed era un lettore così attento da arrivare addirittura a selezionare quella magnificenza che sono i testi del Requiem tedesco, un Requiem che lui dedica alla madre. Per cui è un’opera, la Quarta Sinfonia, che nasce già da una contraddizione, nasce da una contraddizione fra quello che uno dichiara di essere e le scelte che fa. Brahms, dichiaratamente ateo, sceglie come tema per le Variazioni dell’ultimo tempo di questa Sinfonia, che è il coronamento delle sinfonie di Brahms – Brahms scrive soltanto quattro sinfonie, contro le nove di Beethoven, contro le quarantuno di Mozart, contro le più di cento di Haydn – sceglie questa cosa. La cosa mi ha incuriosito molto e ho cercato di risalire la corrente dell’ultimo Movimento fino al primo – noi ascolteremo il primo e l’ultimo Movimento, non inquietatevi, non tentate il suicidio in un’ora ce la caviamo!,- ho cercato di risalire la corrente e mi sono domandato: da che cosa parte Brahms?
Da che cosa può partire la speranza? La speranza non è una roba… io sono milanese di nascita, poi abito in Veneto, e sono uno strano ibrido… Che cosa è la speranza per una persona che veramente la prende sul serio? Non è dire: boh, chissà cosa succederà, speriamo che vada bene, quello che in milanese si dice sperèm; la locuzione in milanese sperèm è esattamente quella di alzare le spalle e dire “boh, chi lo sa?”, la cita addirittura don Giussani in Si Può Vivere Così quando parla della speranza; ma è un’altra cosa: è la certezza di qualcosa che io spero di poter possedere, è la certezza di qualcosa che c’è, di un’eternità, di un bene, di un amore che mi viene consegnato, che io spero ardentemente di poter ottenere. Non è: boh, speriamo che ci sia qualcosa; questo è dubbio, è un’altra cosa, non è speranza cristiana. Quello che diceva Benedetto XVI e don Giussani è esattamente questo: il desiderio che in ogni cosa che io vivo, che io faccio, ci sia un significato che mi porti fino alla fine, e porti con sé tutto quello che io amo, tutte le persone a cui voglio bene, tutte le cose che mi piacciono, che mi interessano, fino al dettaglio, fino al dettaglio minimo, fino alla Fanta, fino alle scarpe, fino al rossetto.
Ritornando alla Quarta di Brahms, essa parte da un tema bellissimo, chi lo conosce non lo dimentica più, da un tema bellissimo ed estremamente struggente. Perché la Quarta di Brahms parte con una domanda che è proprio una domanda radicale, è come un uomo nudo, nudo nell’anima, che domanda ad un cielo muto cosa sta per succedere, perché lui è lì. Sembra un po’ Leopardi, il Pastore errante dell’Asia, che dice: Ed io che sono, perché ci sono tutte queste stelle, che cosa vale il vivere?, perchè uno deve soffrire se tutto poi finisce nel nulla? Ecco, questo inizio fa così- poi ve lo farò sentire anche con l’orchestra, portate pazienza – le note sbagliate che io suonerò sono in partitura, perché sono la versione originale, diciamo, della Quarta di Brahms.
Un tema fatto di sospiri…
Sempre due note e due note…
Sapete qual è la cosa impressionante di questo tema lirico bellissimo che forse molti di voi conoscono? Che in realtà questo tema, che sembra proprio nascere dalle profondità insondabili dell’animo umano, è un tema pensatissimo. In Brahms, questo abbraccio di tutto quello che c’è, è innanzitutto un abbraccio della ragione e del sentimento contemporaneamente. Questo tema adesso ve lo suono nella sua forma solamente discendente. Prestate attenzione, questo è un passaggio un po’ difficile ma è l’unico, se capite questa cosa qua tutto il resto è in discesa. Sentite: questo tema è fatto di note che continuamente scendono e poi salgono, scendono e poi salgono [pianoforte]
Se noi queste note le mettiamo invece tutte in ordine discendente, otteniamo questa sequenza di note [pianoforte]
Questo frammento che non è un tema, Brahms non lo espone mai come tema, almeno non nel primo Movimento, lo espone moltissime volte, è come se fosse la colonna vertebrale di tutta la Sinfonia. La Sinfonia è fatta di un numero altissimo di trasformazioni di questa cosa qua, che per i musicisti presenti in sala non è altro che una sequenza discendenza di terze: Si, Sol, Mi , Do, La, Fa, Re, Si. Che cosa vuol dire? La Sinfonia è una cosa complicata, che ha quattro tempi, scritti in una forma molto magniloquente per grande orchestra, utilizzando praticamente un’idea sola. E’ che io sto cercando una cosa, sto cercando la varietà di tutte le cose afferrandone una sola. Questa cosa non è la speranza, scusatemi? Quel ritrovare il significato in tutte le cose che vivo, dall’aranciata al cielo sublime colmo di stelle che vedo sopra di me. Non è la stessa cosa? Beh, vediamo come va avanti Brahms in questo cammino. E’ molto istruttivo: io, preparando questo incontro, mi sono reso conto di molte cose che capitano a me personalmente. Per esempio oggi è stata una giornata in cui ho fatto un viaggio di andata verso Rimini abbastanza terrificante; dovevo trovarmi a pranzo con degli amici, e per dei problemi legati banalmente al mio cane non sono riuscito ad arrivare a questo pranzo. Ora, la cosa normalmente non fa piacere a nessuno; come faccio io a trovare il positivo in una cosa del genere? Bene, la stessa domanda se la pone Brahms, e se la pone in una maniera un po’ singolare, innanzitutto ponendo la domanda. Pone la domanda: perché questa malinconia, perché mi sento sempre mancante di qualcosa? Sarà capitato almeno una volta, me lo auguro, a ognuno di voi che qualcosa mancasse irrimediabilmente, e non sapeste che cosa; proprio un vuoto costitutivo, non un vuoto come per dire… E’ proprio una cosa che se uno comincia a farti un elenco… tu non la trovi. Brahms si trova a partire da questa situazione, ma va avanti in una maniera abbastanza comune. Voi cosa fate quando avete questa specie di… Oggi gli psichiatri tendono un po’ a schematizzare: questo è un disagio che tu in fondo dovresti sublimare trovando qualcosa che ti interessi… No, non è vero! Quel vuoto lì tu lo devi lasciare vuoto fino a quando tu non trovi qualcosa che lo colmi veramente. Brahms cosa fa nella Sinfonia? Ogni tanto fa spuntare qua e là una specie di fiorellino, qualche volta è un fiore imponente, lo sentirete, che è una fanfara. La fanfara è come il preludio di una festa che uno attende, e che continuamente…
Compare una fanfara che fa così: [pianoforte]
Compare ogni tanto, e compare in molte forme, a volte è misteriosa, a volte è addirittura gridata, ma comunque è una fanfara che in qualche maniera prelude ad una festa. Brahms dimentica questo preludio di una festa, cioè questo annuncio di una possibile risposta, che ancora lui non sa quale sia, ma comunque c’è: tutta la realtà, destando il mio interesse, dice che una risposta c’è… Devo essere totalmente irragionevole per dire che non esiste… Bene, Brahms ogni tanto la fa questa cosa, che cosa fa? Cerca di dare unità, nella seconda idea melodica della Sinfonia, a quella cosa che era frammentata. Quel sospiro dell’inizio cerca di farlo diventare qualcosa di monolitico, di imponente e soprattutto di lirico. E allora canta un tema che non ha, al contrario del primo tema, pause. Fa così questo tema: [pianoforte]
Allora ci è riuscito, si è dimenticato di quella malinconia dell’inizio? No. Perché non se ne è dimenticato? Perché non si può dimenticare quella cosa. Infatti, e qui si vede perché… Quella sequenza discendente che vi ho fatto sentire all’inizio, il riassunto delle note che Brahms fa sospirare all’orchestra è importante, perché le voci più basse suonano questa cosa qua:… [pianoforte]
Che cosa è questa cosa qua? E’ un frammento di questa linea. Mentre lui canta disteso, dicendo: io me ne frego di tutta quella malinconia, me ne frego di tutto quello che costituisce quella domanda urgente, contemporaneamente un’altra voce gli dice: non la puoi dimenticare, non puoi dimenticare che tu sei fatto per qualcosa che non è alzare le spalle davanti a una domanda così grande. E allora Brahms genialmente contrappone alla prima melodia quell’altra melodia, che vi suono per aiutarvi nell’ascolto: [pianoforte]
Cioè contrappone questa continuità ad un ritmo così frazionato da essere quasi un ritmo che assomiglia vagamente al ritmo di tango… [pianoforte]
E’ un ritmo continuamente nervoso. Continuità: mi disinteresso di tutto questo ritmo che mi riporta alla realtà.
Quindi: abbiamo l’elemento del sospiro, l’elemento del tentativo di continuità, abbiamo l’elemento importantissimo della fanfara, che comparirà in tutti i movimenti, poi c’è un altro elemento in questa Sinfonia. Un altro elemento che potrei definire in maniera un po’ generica il tema del Mistero. Ogni tanto tutti i temi, che sono come dei discorsi, diventano completamente nebulosi. Brahms fa così: ogni tanto tutta questa enorme forza dirompente la porta all’interno di un bisbiglio. E’ una figura che, per farvi un esempio [pianoforte]
La sentirete molte volte, perché questa figura è collegata in maniera significativa con il tema della fanfara. Come dire, la fanfara è il messaggero di una cosa misteriosa che ti preannuncia la possibilità di una festa, ma contemporaneamente ti dice che non è ancora la festa, che tu quella festa la devi ancora aspettare.
Adesso vorrei proporvi di ascoltare, mi permetto – mi scuserà sia Kleiber che è un grandissimo direttore di orchestra, sia Brahms – di farvi ascoltare il primo Movimento della Sinfonia, commentando qua e là quello che succede, per cercare di richiamare gli elementi di cui abbiamo parlato. E vedrete che la parabola di Brahms è impressionante, perché alla fine del Movimento noi assistiamo realmente ad una persona che non riesce ad accettare che lui non sia in grado di rispondere a quella domanda. Si ribella. Ne parlavamo prima con Pier Paolo, c’è un punto nella penultima battuta dove un timpano… [pianoforte] fa quattro note ribattute che significativamente sono, se qualcuno c’era ieri, molto simili alle quattro note che aprono, in tutt’altra maniera, il Concerto per violino di Beethoven. Qui è come dire: non mi arrenderò, è una forma di violenza assoluta. L’uomo non accetta, l’uomo Brahms non accetta di non essere lui quello che può rispondere a quella domanda. E quindi quello che sentirete è un enorme dispiegarsi di energie per tentare di rispondere a una domanda che non si può eludere.
Adesso siccome il tempo stringe vi racconto la fine della storia, di modo che la parte in mezzo ve la leggerete da soli.
Quello che succede nei due Movimenti centrali è molto semplice, è una cosa umanissima: Brahms cerca di fare quello che a Napoli si dice: nun ce pensà. Prova a non pensarci. Come? In due maniere molto diverse: nel Secondo Movimento attraverso una specie di oasi di pace che prova a costruire e che a un certo punto, come un castello di carte, lui stesso fa crollare. A un certo punto scompagina tutte le carte venendo gridato dall’intera orchestra con una perorazione di una tale violenza che evidentemente denuncia la falsità di quella pace che Brahms stava mettendo in atto. Il Terzo Movimento invece prova la strada contraria: una scrollata di spalle atletica su ogni cosa dell’universo: chi se ne frega…Tenete presente che la fanfara è presente nel Secondo Movimento, nel Terzo Movimento, è lo stesso quel tema discendente che vi ho fatto sentire.
Il Quarto ed ultimo Movimento è una composizione che si ispira, appunto come vi ho detto, ad una composizione bachiana, ed è una serie di 35 variazioni su un tema di 8 misure, un tema che è, diciamo, l’ultima apparizione possibile della fanfara che abbiamo sentito all’inizio. Brahms che cosa fa? Alla fine capisce una cosa semplicissima: che quella domanda è così urgente che l’unica cosa ragionevole che posso fare è non tagliare fuori qualcosa ma, come diceva genialmente don Giussani e con lui Pier Paolo, tentare di abbracciare tutto. Vedere come faccio, non censurare niente di me. E allora voi vedrete che veramente questo ultimo Movimento, che è una serie di 35 brevissime variazioni su un tema molto imponente ricavato da quel testo bachiano pieno di speranza – ed è singolare che Brahms prenda proprio quello come abbiamo già detto-, è una specie di viaggio all’interno dell’uomo, all’interno di ogni più piccola sfumatura del sentimento. Sono divise in quattro grandi blocchi; li sentirete, perché il primo finisce con una variazione bellissima, tristissima, del flauto, proprio una specie di pianto, un uomo come Brahms che si abbandona al pianto… Poi c’è una specie di oasi di pace, quasi una sacralità, sentirete delle cose molto solenni, e poi di nuovo ritornare quella domanda, il tema iniziale, con un’urgenza che non ammette più sconti. La fine è quanto di più imprevisto ci potrebbe essere, perchè tutti si aspettano finalmente il lieto fine, che alla fine Brahms riceva questa risposta… Beh Brahms non riceve questa risposta. Ma Brahms capisce una cosa: Brahms ha imparato che bisogna restare nella domanda. Se una domanda è così urgente da non accontentarsi di nulla, bisogna continuare a domandare. Infatti il finale di questa Sinfonia sarà un continuo domandare e ridomandare. Sentirete sempre le stesse note che si ripetono sempre più velocemente, in modo da dire: se non riesci a trovare una risposta almeno devi continuare a domandare, non puoi chiudere questa partita, e questo è secondo me veramente l’unica cosa che rende possibile l’alba di quella speranza di cui parla il testo bachiano.
Adesso per non sforare coi tempi, vi faccio ascoltare l’ultimo Movimento, facendovi soltanto sentire il Tema al pianoforte, che è un tema di otto battute molto bello, e all’acuto porta la melodia lievemente variata che usa Bach. Come sentirete, già il tema è profondamente instabile; i musicisti fra voi che ci sono sentono che questo tema non è collocabile totalmente. Voi non riuscite a capire bene in che tonalità sia, addirittura è talmente grande l’abbraccio di Brahms che tentativamente lui abbraccia più di una tonalità, addirittura all’interno del tema. Questo tema fa così, ed è esposto da tutti gli strumenti a fiato più i timpani: [pianoforte]
E’ un tema potente, come è potente la domanda che esprime. Ora vi chiedo di avere la massima disponibilità umana, non abbiate preclusioni, lasciatela entrare questa musica, lasciatevi portare. Io, la prima volta che ho ascoltato l’introduzione all’ascolto di questa Sinfonia che è stata fatta da Pier Paolo a Bergamo sono rimasto colpito da una cosa che lui ha detto e che mi ha accompagnato per tantissimi anni. Lui ha detto che ascoltare della musica è come accettare di fare un viaggio a cui vi invita qualcuno senza dirvi la meta. Lui vi dice: fidati di me, è bellissimo. Ecco, ascoltare questo ultimo Movimento di Brahms è come dare fiducia a Brahms. Quando siete arrivati alla fine potete giudicare cosa vi ha chiesto, però ha bisogno di tutta la vostra disponibilità. Buon ascolto.
Concludo augurando davvero a ciascuno di voi di trovare la risposta alla domanda che Brahms ha così grandemente posto, e spero che anche lui abbia trovato alla fine questa risposta. Grazie.
(Trascrizione non rivista dai relatori)