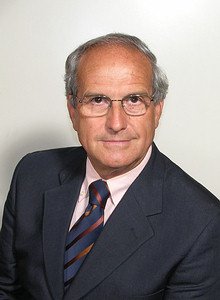GIUSTIZIA E LEGALITÀ: QUALE RUOLO PER IL NON PROFIT?
Giustizia e legalità: quale ruolo per il non profit?
Workshop Rivista Non Profit. Partecipano: Salvo Andò, Rettore della Libera Università Kore di Enna; Nicola Boscoletto, Presidente del Consorzio Sociale Rebus; Guido Brambilla, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Milano; Giovanni Maria Pavarin, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Padova; Ettore Randazzo, Avvocato; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Paolo Sciumé, Direttore Rivista Non Profit. Modera Andrea Simoncini, Docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Firenze e Coordinatore Scientifico Rivista Non Profit.
ANDREA SIMONCINI:
Scusate, io inizierei questo incontro che ha come titolo, come tema Giustizia e legalità: quale ruolo per il non profit? Presenterò dopo chi partecipa, darei subito la parola per l’introduzione di questo incontro all’avvocato Paolo Sciumé, che è anche direttore della rivista Non Profit che trovate sulle sedie e che ha affrontato in un numero monografico proprio il tema di giustizia e legalità.
PAOLO SCIUMÉ:
La rivista è ospite, in questo numero come in tutti gli altri, di una presenza nella società che rappresenta una dimensione che non è solo una dimensione particolare, il non profit non è solo un settore. Ha come origine un modo di guardare l’orizzonte delle cose che pretende anche di dominare in qualche modo il settore che sembra contrapposto, quello del mercato. In realtà recentemente anche questa crisi fa vedere come le cose tendono ad unirsi, tendono ad unirsi in un momento in cui è la prevalenza della forza dei soggetti che può forse determinare il futuro. Questo numero che avete trovato sulle vostre sedie ha una mia introduzione che la dice lunga sul problema della giustizia, perché si connette a quelle che sono delle energie nel nostro paese fortissime, quella della giustizia e quella dell’educazione. Non a caso la Costituzione, l’unica volta in cui parla, in cui usa la parola educazione, è quando la usa per la rieducazione delle persone condannate. E’ l’unico momento in cui la usa, perché l’educazione non può essere un compito dello stato. E spesso l’educazione è un compito di realtà non profit proprio perché hanno un orizzonte ampio. La rivista è ospite di questo incontro, e il Meeting è ospite di quello che la rivista ha promosso. Sono nessi da non dimenticare, come sono da non dimenticare gli interventi che seguiranno, guidati dal prof. Simoncini. Prego.
ANDREA SIMONCINI:
Grazie. Allora, diceva l’avvocato Sciumé nell’introduzione, il tema della giustizia e della legalità e il tema dell’educazione, che apparentemente sembrerebbero piuttosto distanti, in realtà sono invece proprio l’oggetto dell’incontro che abbiamo proposto. E da un lato questo perché chi ha frequentato e frequenta il Meeting da tempo conosce esperienze come la cooperativa Giotto, di cui avremo poi anche una testimonianza, che sono un caso, un esempio, un pezzo della realtà che sta a dimostrare quanto in realtà il mondo della giustizia, del carcere, del sistema penitenziario abbia queste potenzialità educative. Molto spesso non conosciute, del tutto dimenticate, posteggiate in certi casi. Dall’altro c’è il tema più generale, giustizia e il sistema giudiziario, il sistema penitenziario, che in maniera sempre più forte, più chiara, è sotto i riflettori. Tutti i giornali di oggi e i giornali in questi ultimi tempi non fanno altro che mettere a tema, al centro della discussione, parti, pezzi del sistema giudiziario, la giustizia nel suo complesso, se non poi sullo sfondo il tema della riforma dello stato. Allora per discutere sulla scia del suggerimento dell’avvocato Sciumé, per discutere di questo tema, oggi abbiamo la possibilità di ascoltare il prof. Vittadini, che non ha bisogno di presentazioni. Diciamo solo che presiede la Fondazione per la sussidiarietà. Il prof. Salvo Andò, poi le presentazioni diciamo più nel dettaglio le farò dopo. L’avvocato Ettore Randazzo, il dott. Nicola Boscoletto, e poi abbiamo invitato ma non possono essere presenti, due magistrati di sorveglianza, Giovanni Maria Pavarin e Guido Brambilla, per provare, in questo workshop, a mettere sotto i riflettori il tema della giustizia e della legalità. Prima di dare la parola ai presenti, io vorrei chiarire che i due giudici non hanno potuto prendere parte a questo nostro workshop, perché entrambi sono trattenuti da motivi di lavoro, da motivi istituzionali. Uno è di turno, è magistrato di sorveglianza, e l’altro invece è dovuto andare a Roma per una riunione tecnica, sempre in materia di magistratura di sorveglianza. Quindi avevamo nella scaletta due magistrati di sorveglianza, non possono esserci ma ci hanno mandato degli interventi. Allora io vorrei iniziare e poi subito dare la parola ai nostri relatori, citando soltanto un paio di pezzi, due brani dei loro interventi, perché mi pare che ci aiutino ad introdurre un po’ i temi generali che vogliamo affrontare. Premettendo che tutti gli interventi del workshop di oggi, nella versione estesa poi saranno pubblicati dalla rivista Non profit, chiederò subito ai relatori di essere stringati nelle loro esposizioni.
Comincerei dall’intervento del dottor Brambilla che è magistrato di sorveglianza a Milano il quale ci ha mandato questo lungo intervento dal quale vorrei leggervi questa parte:
“A mio parere – dice il dottor Brambilla – giustizia e legalità, oggi ampiamente oggetto di accesi dibattiti a livello politico, scientifico e tecnico, sono esperienze ormai defraudate della loro sorgente nativa, quasi fossero semplici ingranaggi di un meccanismo che si vorrebbe solamente più efficiente e celere, limitato, nelle sue finalità, alla pratica soluzione dei conflitti sociali, quale essa sia ed indipendentemente da una domanda di senso.
Ecco perché ritengo che, anche con riguardo alla giustizia e alla legge, il nodo cruciale da affrontare sia quello educativo. Riguardando i più svariati e complessi bisogni dell’uomo, nei suoi rapporti interpersonali e con la realtà tutta, la giustizia è prima di tutto una esigenza costitutiva ed originaria del cuore umano, di come questo possa essere condotto al suo compimento e poi, ma solo come conseguenza necessaria, un percorso tentativamente risolutivo dei problemi che attengono all’ordinata convivenza sociale e alla soddisfazione dei bisogni dei singoli. L’io non è un prodotto del cervello, come affermava il premio Nobel John Eccles; così come la giustizia non è un prodotto della legge, non è l’esito automatico di una norma positiva, bensì un bisogno che preesiste come urgenza di compimento dell’essere, che va dunque riconosciuto, sostenuto e favorito dalla legge stessa.
Per cui alla domanda, oggi ampiamente diffusa, di come può efficacemente tradursi la giustizia a livello normativo e processuale, mi sembra corretto anteporne un’altra, più importante: quando l’uomo è giusto? o, meglio, cosa rende l’uomo giusto?, sì da poter conformare a giustizia la stessa interpretazione ed applicazione della legge”.
Il dottor Brambilla poi prosegue con un intervento nel quale esamina nel dettaglio queste sfaccettature, che mi pare però siano già contenute, quanto meno in nuce, nell’esordio del suo intervento e mi sembra interessante soprattutto la parte dove passa a delineare le conseguenze pratiche, propositive delle sue osservazioni.
“Tra il carcere, così come attualmente esistente, e le misure alternative potrebbero poi essere realizzati carceri leggeri, strutture detentive a bassa sicurezza, recuperando caserme o edifici pubblici dismessi, per soggetti non particolarmente pericolosi, gestite con accordi tra il settore pubblico ed il privato sociale, senza presenza di personale di polizia penitenziaria all’interno, con la permanenza, per contro, di controlli solo al di fuori della cinta muraria, come nel sistema cd. Modulare spagnolo”.
Ovviamente, ci tengo a precisare che questa proposta il dottor Brambilla la situa in un intervento più articolato, quindi è semplicemente un’estrapolazione, però mi pare interessante perché a questa idea di giustizia lui affianca anche una possibile strada da percorrere e questo modello spagnolo – che io ricordo citato dal professor Vittadini in una riunione del comitato di redazione della rivista – potrebbe essere proprio una di queste, tra l’altro con l’idea di abbinare mondo del non profit e gestione delle strutture penitenziarie.
La relazione del dottor Giovanni Maria Pavarin, Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova, inizia invece nel modo seguente: “Il titolo del tema sul quale siamo oggi chiamati a riflettere, prima di interrogarsi sul ruolo del non-profit, richiama i termini di giustizia e legalità.
Giustizia e legalità non corrispondono però ad un concetto unitario, nel senso che i due termini non costituiscono un’endiadi, che è quella figura retorica che esprime con due termini coordinati un unico concetto. Giustizia e legalità sono, invece, termini assolutamente distinti.
Legalità significa rispetto delle leggi che il cittadino è tenuto ad osservare, e poco importa se a loro volta queste leggi siano il frutto di una decisione democratica oppure discendano da scelte imposte dal dittatore di turno.
Il termine ‘giustizia’ evoca, invece, un concetto più ampio, più alto, che può coincidere, come anche non, con la lettera e con lo spirito delle singole leggi che il cittadino è comunque tenuto a rispettare”. Anche qui troviamo un esordio su questa idea ampia di giustizia che può anche entrare in conflitto con l’idea di legalità e che lui analizza nel corso del suo intervento che si conclude con una proposta.
“Da questo punto di vista il ruolo degli enti non-profit impegnati negli istituti di pena è fondamentale: un’organizzazione che si basa sul non-profitto, che lavora per gli altri più che per sé, che è obbligata a reinvestire gli utili in altrettante opere per gli altri, è il segno della controtendenza, il segnale rieducativo che per eccellenza può indurre chi ha delinquito, soprattutto per ragioni collegate al proprio profitto materiale o morale, all’osservanza delle regole dell’altruismo, della solidarietà, dell’umanità.
In sostanza alle dimensioni di quel cuore che è insito nella natura dell’uomo e che lo spinge a desiderare quelle cose più grandi che stanno oltre i suoi confini”.
Ricordo che il dottor Pavarin è il Magistrato di sorveglianza di Padova e quindi è il Magistrato di sorveglianza di Padova nella cui giurisdizione lavora la Cooperativa Giotto.
Allora io ho soltanto rapidamente letto un paio di frasi, diciamo, da questi interventi, però mi pare che delineino già, quanto meno, due grandi temi sui quali io chiederei ai nostri relatori di intervenire.
Il primo è un po’ in generale il problema della giustizia, il rapporto giustizia legalità, un tema che è stato ed è oggetto come aspetto particolare del più generale tema della riforma dello Stato, dell’autorità pubblica, da sempre, potremmo dire, ma che non riesce mai a trovare una soluzione. C’è un conflitto sempre più evidente, sempre più stridente, ma sembrerebbe essere il sistema politico, il sistema istituzionale, le regole che abbiamo, la Costituzione troppo difficili da cambiare. O sono le abitudini, che forse sono più difficili da cambiare che una Costituzione? Non lo so. Qualcosa c’è che inceppa il meccanismo.
L’altro grande tema che, mi pare, emerge da questi due punti che ho colto nelle relazioni dei magistrati, è il ruolo che devono giocare la società civile e gli enti non profit, come una sorta di immagine sintetica di questa. Ma più in generale, se la finalità della pena è la rieducazione – correttamente diceva l’avvocato Sciumé, l’unica volta che la Costituzione Italiana cita l’ educazione è per parlare della ri-educazione, nell’articolo 27, del condannato – può l’educazione essere fatta da una struttura? L’educazione è un rapporto, l’educazione inevitabilmente è un legame, un rapporto, perciò che ruolo può avere la società in questo?
Comincerei dando subito la parola al professore Giorgio Viittadini, per una sua riflessione su questo tema e poi proseguirò presentando anche gli altri relatori.
GIORGIO VITTADINI:
Mi scuso perché poi dovrò abbandonare l’incontro perché ho altre cose. Io, evidentemente, non essendo un giurista, do il mio apporto su quella che è stata un’esperienza, non cercata, di conoscenza delle carceri da qualche anno per, diciamo, un’attività di volontariato, nata da incontri che mi hanno portato a frequentare regolarmente alcune carceri italiane. Penso all’incontro con Nicola Boscoletto in particolare, per il carcere di Padova, e la sua avventura della Giotto.
Allora io dico alcune cose che sono una provocazione per chi è al tavolo ed è competente sull’argomento. La prima che, secondo me, visto che si parla tanto di costrizione, è che l’articolo forse più disatteso della Costituzione è quello citato prima da Simoncini, dall’avvocato Sciumé.
Oggi come oggi il sistema carcerario italiano non è pensato come rieducazione, ma non per un errore pratico. Il pensiero del nostro mondo in molti casi prima era, diciamo, garantista, adesso è diventato giustizialista. L’idea dominante è: “butta via la chiave, punisci il colpevole, l’ha pagata e quindi rimanga lì”. E questo ha strane assonanze tra mondi di estrema sinistra e di destra, oggi emergenti, perché l’idea è che devi punire il colpevole che ha fatto del male, anzi, il problema è che non è punito, quindi, c’è questo pericolo per la cittadinanza tutta. Quindi il problema di quello che avviene non è un errore rispetto a qualcosa che c’è, è un pensiero ben radicato, che è entrato con l’idea di punire il colpevole. Si dovrebbe, se fosse coerente, avere il coraggio di dire che la Costituzione dovrebbe dire che la legge punisce i colpevoli, punto. Non è vero che oggi, quello che facemmo anche alla mostra del Meeting alcuni anni fa intitolata “Vigilando redimere”, sia il punto di vista di gran parte delle forze politiche e della popolazione. Questo, secondo me, anche per una confusione tra il detenuto in attesa di giudizio, il non detenuto con l’avviso di garanzia, il condannato a pene lievi e il condannato a pene gravi.
Oggi come oggi, la giustizia punisce soprattutto chi va sui giornali con un avviso di garanzia e ha contro, per certi momenti, una parte del mondo giornalistico, una parte del mondo giudiziario. Perché se pensiamo ai reati politici che in gran parte sono stati, dopo le prime indagini, comminati, sono la minoranza.
Il giornalista Da Rold mi ricordava come uno dei grandi imputati di tangentopoli, Necci, che era presidente delle ferrovie, ebbe 40 processi e uscì innocente. Ma Necci fu ucciso dal punto di vista pubblico e sfido qualcuno che si ricordi quei tempi, a non ricordarselo come semplicemente uno che era di tangentopoli. Finì assolto. Quanti altri finirono assolti! Quindi la prima questione per cui non c’è quello che c’è nella Costituzione, è la confusione gravissima per cui il più grave condannato è innanzitutto quello che poi alla fine può non essere condannato ed è messo nel calderone generale. Allora, parte del mondo giornalistico che si è indignato per la questione delle intercettazioni dovrebbe ragionare sull’idea che c’è un bavaglio che è messo alle persone e che tocca molti che poi sono assolutamente, per la stessa giustizia, quindi non per altri ma per i magistrati, innocenti.
Quindi il primo grave problema è la grave confusione per cui tutto è insieme, il detenuto in attesa di giudizio che finisce in carcere insieme a gente appesantita di gravi reati e il detenuto per piccoli reati che finisce con altri di altro tipo.
Questa confusione, secondo me, è il primo modo con cui si sta facendo fuori la Costituzione, in modo molto più grave che la legge sull’intercettazione. Io sono rimasto colpito che, mentre c’era la discussione sulle intercettazione, arrivarono sui giornali le intercettazioni della P3 di gente che poi non è neanche stata, come dire, non è neanche diventata indagata. Per fare un nome, Formigoni, che andò sui giornali in palese violazione della legge, mentre ancora si stava parlando di, come dire, di una persona che viene interrogata.
Questo provoca il primo grave problema, il fattore moltiplicativo, terzo aspetto, del reato.
Io ho fatto pubblicare in un giornale, proprio per una frequentazione delle carceri dove avevo conosciuto un ex camorrista, una lettera che lui mi diede, in cui raccontava la sua storia di essere entrato a Poggio Reale per piccolissimi reati, furtarelli e di essere poi stato assoldato dalla camorra, per la promiscuità in cui si è dentro. C’è un fattore moltiplicativo del crimine a cui, proprio quelli che vorrebbero evitarlo, i giustizialisti di destra e di sinistra, dovrebbero pensare. Oggi le carceri, per come sono organizzate, fanno sì che uno che entra per un furtarello, molto facilmente entri nella grande criminalità. Quindi questo non è il problema della pena. Se in una struttura che ha lo scopo di redimere viene invece inevitabilmente diffuso il crimine, c’è qualche cosa che non funziona! C’è qualcosa che non funziona se la gente che continua l’attività criminale in galera può avere un rapporto con gente che invece avendo sbagliato potrebbe uscire.
Oggi i carceri sono un fattore moltiplicativo. Boscoletto può dire meglio di me, che la recidività è altissima, non so quanto, il 90%. Quindi vuol dire che questa trafila di confusione, di mancanza di giustizialismo, a volte porta a provocare un moltiplicativo di questo aspetto.
Allora noi capiamo che un quarto aspetto, sempre legato alle questioni di prima, è l’aspetto del rapporto da persona e persona, perché oltre al fattore moltiplicativo c’è un fattore che interroga tutta la società. Una società è definita dal modo con cui definisce la colpa e la pena. Una società può essere una società farisaica, come questa, soprattutto su certo mondo mediatico, giudiziario e politico, quando ritiene che la pena sia, la colpa sia di una parte. Abbiamo dei talk show che vivono di questo, dei giornali che vivono di questo, in cui lo spunto farisaico è un metodo: “la colpa è di quelli!” Ci sono le mani pulite e le mani sporche. D’altra parte lo stesso nome della indagine giudiziaria più famosa dà questa idea, censurando qualcosa che per noi non è un fattore secondario, è un fattore fondamentale, antropologico: l’uomo è fatto per il bene ma sbaglia, l’uomo è fatto per la vita ma cerca la morte, ha dentro di sé il peccato, il peccato di chiunque. Una società che confina in alcuni il male, non ha l’idea di se stessa, perché è ipocrita, è farisaica e questo metodo delle carceri è farisaico: confina su alcuni la colpa di tutti. Non che tutti sono colpevoli allo stesso modo, noi siamo per la certezza giuridica che pur è largamente disattesa in molti aspetti. Ma siamo per una certezza giuridica che ha questa idea di fondo, non l’idea di confinare e punto. Qui critico fortemente l’idea giustizialista: “i colpevoli là”, come fossero solo là. Invece un’ idea vera di giustizia, come quella della nostra Costituzione, ha presente l’idea del percorso. Un percorso in cui, sia ben chiaro, non è che si confonde la pena con la colpa: uno ha sbagliato, paga! Ma questo vuol dire che io posso sperare ed è mio scopo un suo percorso umano, che non avviene solamente quando uno si pente sotto il profilo giudiziario e quindi diventa collaboratore di giustizia – altra cosa su cui si dovrebbe andare a vedere – ma anche e soprattutto quando uno fa un percorso umano di cambiamento, cosa che oggi non ha nessun valore dal punto di vista della ripresa, se non per la buona condotta che in molte carceri e da molti giudici non è considerata.
Allora, quinto aspetto, secondo me, c’è il problema di questa educazione di cui parlava Paolo Sciumé. Educazione che ha l’aspetto, anche per chi rimanesse giustizialista, di una diminuzione dell’incidenza sociale. La recidiva, nel caso del lavoro nel carcere – Nicola, quanto è? – è l’1%. Quando la gente lavora in carcere ricomincia a, come dire, a riprendere coscienza di se stessa, di un percorso, e quindi è molto più difficile che queste persone, come dire, ritornino al reato. Perché evidentemente c’è una questione positiva, ma, quinto aspetto fondamentale, anche il lavoro è l’esito di un percorso, dell’idea che io posso dare a un detenuto che per lui non è finita! Che come vita non è finita! Non è finita e, quindi, non essendo finita c’è un’alternativa al ritornare al reato e c’è un’alternativa a riconsiderare la vita finita. Cioè la possibilità di una ripresa umana, innanzitutto ideale, usiamo queste parole prima di quelle giuridiche, di coscienza, di una dignità umana, perché questo viene negato nella concezione giustizialista: l’idea che ci sia una possibilità di dignità che possa riprendere. Il lavoro, essendo uno strumento, come dire, esprime questo, ma il lavoro esprime questo come una delle due possibilità, perché prima ancora del lavoro, e questo è il primo impegno delle realtà non profit, questa ripresa della dignità avviene attraverso l’attività delle associazioni di volontariato, in cui gran parte del lavoro, prima ancora del lavoro in senso stretto, è quello. Molti casi in cui è avvenuta una ripresa di coscienza, hanno visto all’opera personale carcerario che collabora in un dialogo. Il primo lavoro della realtà non profit è il dialogo, è la ripresa di coscienza, è la ripresa della mentalità, è l’idea di un giudizio che viene dato su quello che è avvenuto che dice: “tu puoi ricominciare! Puoi rimanere in galera a scontare la pena ma puoi ricominciare”. La prima attività non profit è un’attività strettamente educativa perché è un dialogo, un dialogo, un’attività caritativa che diventa il fattore di ripresa umana di queste persone, che quindi all’interno delle carceri diventa un fattore educativo, anche di testimonianza.
Il secondo aspetto, punto b di questo punto 5 dell’attività non profit, è l’attività di lavoro. Quando c’è un percorso umano, un percorso volontario, c’è una possibilità di lavoro che, secondo me, in molti casi è sempre anche legato all’educazione, perché può essere anche attività di formazione professionale, attività di istruzione, ma che arriva fino al lavoro. Andate a visitare il carcere di Padova ed è impressionante. E’ impressionante cosa avviene lì dentro, nei settori delle biciclette, del call center, dei famosi panettoni, del dolciario, della moda. Vedete una realtà lavorativa impressionante, di gente che la parola espiazione la vive e quindi è un fattore di costruzione.
Sesto ed ultimo aspetto, questo riguarda tutti, perché ribadisco che non è contro qualcuno, non è contro i magistrati, non è contro il personale di sorveglianza, non è una lotta di classe dei carcerati verso altri. E’ un immagine di quella sussidiarietà sociale che è un fattore di crescita per tutti. E le forme giuridiche sono un esito di questo. Perché, secondo me, riprendendo lo spunto di Simoncini, non si è fatto nulla finora? Ma perché non si può partire da leggi che non abbiano una concezione alle spalle. La Costituzione è arrivata a quel punto perché ha avuto dietro un dibattito pluralistico di concezioni, che prima di diventare leggi sono ideali, che solo dopo devono formularsi secondo l’articolazione. Ma se non si ha un posizione ideale non si arriva a leggi, perché evidentemente è una contrattazione di una parte con l’altra. Quindi, io penso, che tutta la società debba porsi questa domanda, questa ripresa di concezione ideale che, ripeto, guardando chi sbaglia riguarda se stessi e che possa arrivare ad una legislazione sulle carceri, secondo me anche sulla giustizia, che riprenda un’immagine generale sociale che non sia, ripeto, il fariseismo. Noi non per niente, e concludo, siamo impegnati su questo tema delle carceri, perché non si può avere una concezione di salvezza cristiana, ma non si può neanche avere un’idea di giustizia umana della società se non si ha un’idea di questo percorso ideale errore – rinascita, che è ciò che è comune ad una cultura, come quella italiana, che per fortuna non ha raggiunto i livelli di violenza sociale in cui l’1% della popolazione, come in America, è in galera. Le percentuali basse dipendono dalla concezione. Noi non possiamo permetterci di scivolare su questo perché altrimenti la violenza diventerà un fattore non delle carceri ma della vita comune sociale italiana.
ANDREA SIMONCINI:
Allora ringrazio ancora il professor Vittadini che mi pare abbia messo sul tappeto tanti degli argomenti che adesso mi piacerebbe discutere con i nostri ospiti. Allora io comincerei subito: professor Salvo Andò. Professore, Magnifico Rettore della libera università della Sicilia centrale Kore di Enna e professore ordinario di diritto pubblico comparato. E’ stato deputato dal 1979 al 1994, membro della direzione centrale del Partito Socialista dal 1981 al 1994, è stato anche Ministro della Difesa nel 1992 e 1993 e soprattutto si è occupato dei problemi della riforma dello Stato e della giustizia. E allora io prenderei lo spunto da un’osservazione iniziale di Vittadini. Parrebbe che destra e sinistra non riescano, seppur affermando teoricamente entrambe di voler riformare la giustizia, lo Stato, a far questo. Qual è il problema, c’è un intoppo sostanziale, dal punto di vista, ripeto, non solo accademico scientifico ma di uomo che conosce bene il nostro sistema politico?
SALVO ANDÒ:
Ma, io, per rispondere a questa domanda molto pertinente, partirei invece da un dato. Le questioni che sono state sollevate anche nel corso di questo nostro incontro sono questioni antiche del sistema giudiziario e questioni antiche con riferimento al rapporto tra politica e giustizia. Da almeno trent’anni si discutono temi che sono quelli che sono stati affrontati anche dai due relatori non presenti, e da quasi trent’anni, soprattutto con riferimento a questi temi, si propongono dei rimedi, alcuni dei quali sono stati anche adottati. Penso, per esempio, alle riforme che hanno interessato il sistema carcerario, riforme importanti, dalla riforma dell’ordinamento, alla riforma Smuraglia, che dà un’organizzazione assolutamente originale al lavoro carcerario, intramoenia ed extramoenia. E’ stata modificata la Costituzione ed è stata modificata la Costituzione in modo significativo con riferimento agli istituti processuali. Si è parlato di una riforma del giusto processo, questa riforma è stata così importante da avere comportato un inserimento in Costituzione di una norma lunghissima, cioè, i problemi erano tali e tanti che non bastava limitarsi ai principi, bisognava entrare proprio nel merito delle singole questioni. Il risultato di questo processo riformatore è un risultato deludente, è un risultato deludente per le cose che sono state dette anche in questa sede, ma è soprattutto deludente perché sempre più si registra una pericolosa simmetria tra l’idea della giustizia che circola tra la gente e l’idea di giustizia che circola nei palazzi del potere. E io credo che, a mio giudizio, noi dobbiamo affrontare questo tema della giustizia come è sentita dalla gente e della giustizia com’è usata dal potere soprattutto in presenza di uno scenario come quello di questi giorni. Oggi noi ci troviamo di fronte alla riproposizione di un conflitto, quello tra politica e giustizia, che ha segnato la vita politica italiana da almeno trent’anni con delle conseguenze clamorose. Il conflitto più importante degli anni ’80 è stato quello tra il Presidente Cossiga e il Consiglio Superiore della Magistratura. Un conflitto durissimo, un conflitto che ha esposto il Presidente della Repubblica, morto nei giorni scorsi, a rischio di impeachment, e che forse sta anche alla base delle dimissioni anticipate del Presidente Cossiga. Al Presidente Cossiga subentra il Presidente Scalfaro, sono gli anni difficili in cui esplodono le inchieste di tangentopoli, il Presidente Scalfaro con riferimento ai problemi che tangentopoli poneva in grande evidenza – c’era anche una forte partecipazione emotiva del Paese – decide, sulla base di una presa di posizione della Procura di Milano, sostanzialmente, di bloccare una decisione del Governo con questa motivazione: i giudici non vogliono questa legge. Nasce un conflitto molto duro e precipita la situazione, il Governo Amato cade sulla base di questa posizione del Presidente Scalfaro. Vi è una crisi di regime, comincia una nuova storia, la storia della Seconda Repubblica e l’esordio di questa storia registra un conflitto tra l’uomo nuovo, il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente Scalfaro, attraverso una vicenda che parte da un avviso di garanzia che viene notificata a Berlusconi nel corso di un summit internazionale. Berlusconi si dimette, si rompe la maggioranza e nasce un altro conflitto da questa vicenda giudiziaria. Il Presidente Scalfaro interpreta la crisi di governo in termini tali da determinare o sostanzialmente da avallare un ribaltone. Allora io credo che questa situazione continua fino ai giorni nostri. Infatti si è aperta una quasi crisi sulla base di questioni che riguardano una diversa cultura della legalità del Presidente del Consiglio e del suo maggior alleato. Probabilmente sulla base dei punti, i giornali oggi ne parlano abbondantemente, che sono stati posti come base di discussione per risolvere la crisi, la questione della giustizia resta una questione aperta. La risposta dei finiani è stata: “noi siamo d’accordo su tutto, non siamo d’accordo sulla questione del processo breve”. Cioè la questione della giustizia rischia di portare ad una nuova elezione anticipata.
Ma, allora, qual è oggi, come dire, la patologia vera che non ci consente di venire a capo di un conflitto che rischia di diventare un conflitto eterno tra politica e giustizia? A mio giudizio alla base di questo conflitto c’è una, come dire, carenza culturale che ormai connota il mondo delle istituzioni, connota la cultura delle istituzioni ed è l’idea che difficilmente i poteri riescono ad accettare un limite, come dire, alla loro tendenza ad espandersi. Questo è un problema che riguarda il giudiziario, è un problema che riguarda la politica. Si tende ad affermare, per esempio in politica, l’idea che maggioritario significa che chi vince si prende tutto, si prende anche la Costituzione, le garanzie; ma si è già affermato – condivido le cose che ha detto Vittadini – all’interno del giudiziario, l’idea che i giudici sono chiamati ad applicare delle leggi rispetto alle quali c’è un loro preventivo gradimento. Quindi non tutte le leggi approvate dal Parlamento, in un certo senso li vincolano ad attuarle, ma soltanto quelle rispetto alle quali c’è un gradimento preventivo, tant’è che il Consiglio Superiore spesso comunica preventivamente al Parlamento e all’opinione pubblica: “questa legge si può approvare, questa legge non si può approvare”. Ora io credo che questo tipo di limite, che è l’assenza della cultura del limite, è un problema che riguarda, a mio giudizio, lo stesso patto sociale. Cioè, in sostanza, noi ci troviamo adesso in una situazione nella quale è molto difficile affrontare i temi della legalità, perché la legalità è diventata terreno di scontro politico e di scambio politico. Sui giornali di oggi c’è una notizia molto grave. Quando il lettore, come dire, meno avvertito delle malizie dei palazzi della politica, legge che probabilmente il diktat di Berlusconi si riduce a questo, tu Lega mi dai la giustizia, io Berlusconi ti do il federalismo, non coglie cosa c’è sotto. L’idea, in un certo senso, che questioni di grande rilevanza costituzionale possano essere oggetto di scambio politico, per cui ciascuno si prende un pezzo di Costituzione, dal punto di vista delle aspettative di giustizia del cittadino è sconvolgente, perché significa che nei palazzi del potere esistono, come dire, dei vasi comunicanti, dei canali di scambio all’interno dei quali tutto è possibile. Tutto è possibile nella misura in cui è conveniente. E allora quelle che prima erano, come dire, posizioni che si potevano considerare anche gratuitamente polemiche, – noi quante volte abbiamo detto: “vogliamo la giustizia giusta”, o abbiamo scritto: “queste sono norme per il processo giusto”, hanno avallato l’idea che ci possa essere un processo ingiusto, una giustizia ingiusta. Beh, quale può essere il patto di legalità che tiene insieme il Paese? Questa è una grande questione che abbiamo di fronte. Ed è una questione che riguarda in modo emblematico la giustizia, perché riguarda tutto il sistema dei rapporti pubblici che si svolgono in questo Paese. E’ vero che chi vince le elezioni si prende tutto? O che invece la sovranità del popolo come dire si esprime attraverso forme, quindi attraverso limiti? Ecco io credo che quando noi affrontiamo questo problema e ci rendiamo conto di queste difficoltà, in noi subentra una situazione di rassegnazione, di impotenza. Io guardavo l’agenda del governo stamattina, con riferimento al punto riguardante la giustizia: c’è il problema della riforma del Csm, un organo importantissimo, poi le norme che riguardano le personalità più significative, norme a tutela delle personalità più significative della vita istituzionale. Poi il processo breve. Si badi bene, il processo breve ormai nella pratica corrente, nel linguaggio normale, nei palazzi a Roma, è il processo non che produce la sentenza breve, ma che produce una breve certificazione dell’estinzione del processo. Ecco, dietro tutto questo, io mi son chiesto, dov’è la parte che riguarda i diritti del cittadino? Per esempio, se il processo è breve, e quindi passato un certo termine chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto, le vittime del reato, quale sarà il destino delle vittime del reato? Chi si occupa di una causa civile infinita? E tutta la materia del carcerario che qui è stata abilmente, giustamente sviluppata? E’ mai possibile che noi ci preoccupiamo del processo breve, perché, ho sentito dire, ce lo ordina l’Europa? Ma l’Europa ci ordina anche un regime carcerario che sia rispettoso dei diritti umani. Ci ha messo in mora più volte rispetto a comportamenti disumani che conosciamo e in relazione ai quali non provvediamo. E tutta la parte relativa al reinserimento sociale del detenuto? La parte relativa all’accesso alla giustizia? La parte per esempio che riguarda i nuovi cittadini che non sono in grado di difendersi, di cui spesso non siamo in grado neanche di ricostruire l’identità personale. In sostanza, è possibile che tutte le questioni della giustizia siano le questioni che nell’agenda della politica entrano grazie al conflitto tra i poteri? O invece non c’è una parte prevalente, più importane, inevasa, che riguarda i diritti del cittadino solo, il cittadino che ha come unico tutore la legge, perché non può avere a propria disposizione né il partito né il sindacato né la stampa né un gruppo di potere. Ecco, questi cittadini soli, che cosa rappresentano dal punto di vista delle politiche della legalità? Io credo che questo deve essere il punto di partenza del ragionamento che noi dobbiamo fare, anche con riferimento al ruolo che su questi temi può avere la società civile.
ANDREA SIMONCINI:
Ringrazio di cuore il professor Andò, perché immagino sia difficile contenere in un’immagine sintetica i problemi della politica e i problemi dei cittadini, anche dando, in parte, un affresco realistico di come la nostra politica sia oggi bloccata da questi scambi che non trovano un equilibrio. Concludeva il professor Andò, dicendo: “Non c’è solo il sistema politico che si occupa della giustizia, ma c’è la giustizia dei cittadini, del cittadino solo di fronte a questo meccanismo”. Ora, il cittadino in realtà quasi mai è solo di fronte a questo meccanismo, perché esiste una professione nel senso alto del termine che è quella dell’avvocato e che ha proprio questo scopo, quello di affiancare le persone che per qualsiasi motivo si trovano ad entrare in questo meccanismo. Proprio per approfondire quest’aspetto, darò la parola all’avvocato Ettore Randazzo, che è appunto un avvocato penalista, importante professionista siciliano. L’avvocato Randazzo non soltanto è un professionista impegnato da un punto di vista professionale, ma ha da sempre avuto importantissimi ruoli all’interno della categoria degli avvocati. Sin dall’istituzione è membro della Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense, che è quella che redige le norme cui un avvocato deve ispirarsi dal punto di vista della correttezza della sua professione. Tra i molti incarichi che lui ha avuto, è stato presidente delle Camere penali dal 2002 al 2006, cioè dell’organizzazione che mette insieme gli avvocati penalisti. E allora io volevo proprio chiedere a lui una valutazione avendo quest’altro punto di vista, il punto di vista del cittadino. i Oggi si va in galera non solo perché c’è stata una sentenza di condanna, molto spesso di va in galera prima, anzi le carceri sono strapiene di persone che hanno la libertà ristretta ma non hanno avuto la sentenza definitiva. Quindi qual è il suo parere dal punto di vista professionale ma anche di visione complessiva?
ETTORE RANDAZZO:
Non pensava certamente al nostro sistema carcerario, però ha tristemente ragione Pascal nel sostenere che l’uomo, non riuscendo a far sì che il giusto fosse forte, ha fatto in modo che il forte fosse giusto. Nel nostro paese la realtà detentiva e spesso persino le norme che dovrebbero regolarla faticano non poco a richiamare criteri di giustizia e di legalità costituzionale.
Il carcere è sotto molti aspetti un bollettino di guerra: strutture inadeguate, angherie e vessazioni impensabili, spazi pro capite indecorosi, igiene inesistente, organici dei dipendenti e degli agenti di custodia insufficienti, condizioni di vita degradanti. Di conseguenza, in un trattamento che oggettivamente (seppure non intenzionalmente) sfiora talvolta la tortura e comunque comprime fortemente la dignità personale, si registrano un suicidio (accertato) ogni 5 giorni, un morto ogni due. Decessi ancora più gravi perché sepolti dall’indifferenza dell’opinione pubblica (la peggiore delle opinioni, secondo un umorista), a sua volta per niente educata dai mass media, sempre più interessati (interesse di mercato, dico) a pettegolezzi da cortile et similia.
In questi giorni le cronache hanno dedicato molto spazio ad altri suicidi: senza voler minimamente sminuire il giusto rispetto e affetto per i cani e tanto meno la civilissima battaglia contro il maltrattamento degli animali, mi limito a considerare con tristezza che il suicidio di un detenuto solitamente non occupa più di due o tre righe. Si dirà: perché ce n’è troppi, non fanno più notizia. Ciò non basta a lavarci la coscienza, o per lo meno non dovrebbe bastare.
Ormai Voltaire, secondo cui la civiltà di un popolo si saggia visitando le sue carceri e non i suoi bei palazzi, non può visitare le nostre carceri. Chissà se lo fece ai suoi tempi; e se c’erano poi tante differenze con quelle “moderne” (se mi si passa l’eufemismo).
I precetti costituzionali di riferimento (articoli 13 e 27, soprattutto: inviolabilità della libertà personale, funzione rieducativa della pena e presunzione di innocenza) vengono calpestati platealmente, con una certa fatica e molte alchimie giuridiche della Consulta. Astrattamente si richiamano presupposti finti: eccezionalità del carcere, qualità e finalità della pena. Se si raffrontassero i principi con la rude concretezza della realtà, ci si chiederebbe come si siano tollerate certe barbarie. L’assuefazione, non solo in questo campo, a quel che è sempre stato così ci nasconde anche fatti incompatibili con la nostra civiltà; e, ciò che è più grave, persino la loro previsione legislativa.
In altri paesi, in ciò più progrediti, il giudizio sulla colpevolezza viene distinto da quello sulla sanzione da infliggere specificamente a chi venga condannato. A questa fondamentale decisione, che tiene conto di quel condannato con l’aiuto di psicologi ed altri esperti che si occupino di quella persona, si dedicano apposite udienza. Ovvio, no? Certo, ma il nostro codice non lo prevede: ce n’è qualche traccia soltanto nel processo per i minorenni e in quello dinanzi al giudice di pace. Eppure la personalizzazione della pena è uno dei cardini della rieducazione costituzionalmente invocata.
Senza dimenticare la deleteria promiscuità tra condannati e “giudicandi”, e la sostanziale inflizione di una pena a questi ultimi che la subiscono in corso di causa e che invece nella maggior parte dei casi non avrebbero dovuto espiare (assoluzione, sospensione condizionale, indulto, affidamento in prova al servizio sociale e misure alternative alla detenzione in genere).
Sono tante ed enormi le tematiche carcerarie, e nonostante la migliore intenzione di affrontarle seriamente il rischio in un breve intervento come questo è di rimanere in superficie. Così, senza alcuna pretesa di escludere la superficialità, ho preferito concentrarmi su un profilo limitato ma fondamentale, se non altro perché curiosamente trascurato: la detenzione (che di detenzione si tratta, comunque la si voglia chiamare) in attesa di giudizio.
La privazione della libertà personale, anche se si riuscisse a garantire modalità meno afflittive di quelle carcerarie, è per chi la subisce profondamente ingiusta e contraddice indubbiamente la presunzione di innocenza di cui ipocritamente si beneficerebbe. Subire una permanenza in carcere nonostante la responsabilità sia tutta da accertare (e statisticamente poi per lo più esclusa) è inutile e dannoso anche per la società, oltre che di per sé palesemente irrazionale.
Siamo ormai talmente abituati, assuefatti proprio, che non ci chiediamo più per quali ragioni una persona sottoposta solamente ad indagine viene a volte (troppe volte) rinchiusa in una patria galera, dove le viene riservata la stessa accoglienza dei condannati.
L’art. 13 della nostra ammirata ed invidiabile carta costituzionale in effetti ci rassicurerebbe sancendo che la libertà personale è inviolabile, che è punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, e che la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La carcerazione preventiva è dunque prevista dalla Costituzione, pur affermandosi l’inviolabilità della libertà personale e bandendosi ogni forma di violenza. Per individuare le modalità della carcerazione preventiva (ora custodia cautelare in carcere) bisogna accertare la ratio e lo scopo della stessa. Senza dimenticare che l’indagato è innocente fino alla condanna definitiva, un innocente con il quale probabilmente dovremmo scusarci di averlo incriminato (senza risarcirlo, né rimborsargli le stesse spese legali che ha sostenuto per difendersi da un’accusa ingiusta: peggio, senza consentirgliene nemmeno la detrazione fiscale).
Indubbiamente, la società deve tutelarsi, evitando che l’indagato continui a rappresentare un pericolo. Il problema riguarda le modalità e quindi la loro conciliabilità con i principi fondamentali dell’ordinamento.
L’art. 272 c.p.p. stabilisce che le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Sempre che vi siano gravi indizi di colpevolezza (art. 273) e si tratti di reati compresi in una certa fascia di sanzione, secondo il successivo art. 274 è necessario riscontrare concretamente nella fattispecie l’esigenza di ovviare ad almeno uno dei seguenti pericoli: di inquinamento probatorio (lettera A), di fuga (B), o di reiterazione di reati della stessa specie di quello contestato (C).
Ciò sempre che l’indagato si trovi … nel “binario” giusto. Gravano infatti sulla nostra disciplina leggi emergenziali che hanno creato il cosiddetto “doppio binario”, una trovata non proprio liberale secondo cui per chi è indagato di reati di un certo tipo si presume che sussistano tutte e tre le esigenze cautelari, e dunque -a meno che non si riesca fornire la prova (di solito diabolica) della loro insussistenza- i gravi indizi giustificano da soli la detenzione in attesa di giudizio … (Qui dovremmo dare conto di restrizioni particolarmente degradanti, armoniosamente inflitte da tutti gli schieramenti politici del Parlamento, a tenore di una legge emergenziale, dapprima temporanea e ora stabilizzata, che ha introdotto il famigerato articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, con i suoi divieti disumani, con le sue costrizioni ulteriori).
La prassi giudiziaria, interpretando con molto rigore una disciplina che invece intendeva contenere gli eccessi della carcerazione preventiva, tende a ravvisare molto spesso questi requisiti, sì che la misura coercitiva è molto diffusa, e che in molte strutture carcerarie il numero dei “giudicandi” supera quello dei condannati con sentenza definitiva. Incidentalmente, ci sono diverse misure cautelari che possono sostituire quelle carcerarie: dagli arresti domiciliari ai braccialetti, dal divieto all’obbligo di dimora. Il carcere dovrebbe essere l’extrema ratio. Purtroppo non è così.
Ora, la domanda è: se è vero che il nostro sistema è governato dalle garanzie costituzionali, prime tra tutte il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, qual è il motivo per cui non ci si limita a tutelarsi, bensì si ricorre al carcere -e al nostro carcere- durante l’accertamento processuale?
Si oppone il diritto-dovere di salvaguardare la collettività, ciò che può ottenersi solamente sospendendo le garanzie del singolo. Già, ma allora bisognerebbe occuparsi solamente delle tre esigenze cautelari sopra indicate. A questo scopo, però, sarebbe sufficiente una struttura abitativa debitamente attrezzata per evitare fuga, inquinamento e reiterazione. E ciò si può ottenere organizzando un’adeguata sorveglianza per impedirli: a cosa servono manette, irriferibili mortificazioni personali e igieniche, funesta promiscuità con condannati, porte blindate, spazi ridotti al di sotto dell’immaginabile, brutture indecorose e indecenti?
Nella struttura abitativa sostitutiva del carcere si potrebbe beneficiare di psicologi e assistenti sociali che si preoccupino dell’eventuale tendenza a delinquere e combattano la disperazione che porta al suicidio. Suicidio che del resto è strettamente connesso alle condizioni di vita, che in quest’ipotesi sarebbero ben diverse da quelle incriminate.
In casi estremi poi e con apposito, motivato provvedimento potrebbero adottarsi le eventuali cautele necessarie in caso di effettive e insuperabili esigenze di cautela detentiva connesse alla persona o al delitto a lei ascritto.
Orbene, devono costruirsi nuove carceri, il Ministero lo promette da tempo. E allora, dato che c’è in programma la realizzazione di nuovi edifici detentivi, perché non realizzare semplicemente delle case di permanenza provvisoria finalizzate al solo scopo di evitare che l’ospite si dilegui o si metta in contatto illegittimamente con estranei? Dovrebbero essere ben distinte dalle strutture carcerarie, delle quali rimarrebbero solamente i penitenziari, magari finalmente caratterizzati da attività rieducative e lavorative?
Pare che in altri paesi, ad esempio in Svezia, si goda di stanze singole, con computer, televisore, telefono e quanto occorra per una normale vita di relazione. Non si potrebbe uscire liberamente, insomma. Punto. Ma quel che rimane delle nostre libertà, e dignità, e umanità sarebbe salvato. Non so quanto sia vero, non ho potuto effettuare verifiche attendibili. So quanto sarebbe giusto.
C’è una ragione valida per cui non provvediamo anche noi in questo senso, così rispettando la nostra Costituzione e la persona? C’è una ragione valida per privare un presunto innocente, e dunque per privare la collettività, di valori e diritti di cui si potrebbe continuare a godere perché pienamente compatibili con lo stato detentivo?
I costi? No, sarebbero certamente inferiori a quelli che prevedono materiali e arredi da carcere vero. E comunque non sarebbero un argomento da opporre a diritti e valori di questo rango. Anzi, sarebbe la conferma della bontà del principio, seppure con la necessità di reperire i relativi fondi.
Il pericolo di inquinamento? Assolutamente no: da una struttura comunque chiusa non può certo inquinarsi (a meno che non si pensi a stratagemmi complessi che prescindono dalla restrizione abitativa e ai quali si può ricorrere anche dal carcere).
Il pericolo di fuga? Nemmeno: ci si potrebbe attrezzare, e comunque si potrebbe prevedere per chi violi le regole un inasprimento di sanzioni, oltre che -in caso di evasione- una detenzione autentica anche in fase cautelare.
Il pericolo di reiterazione? E come, se non con i sotterfugi di cui sopra, come tali astrattamente compatibili anche con il regime carcerario?.
Infine, potrebbe obiettarsi che l’effetto deterrente sarebbe sicuramente minore. Ma la custodia cautelare in carcere di un presunto innocente non è una punizione, né potrebbe esserlo prima della condanna. Ancor meno può essere utilizzata quale dissuasore: sarebbe ancor più inspiegabile una detenzione così motivata, oltre che palesemente illegittima e ingiusta.
Allora, che cosa osta veramente alla costruzione di strutture abitative? E intanto alla discussione, allo studio tecnico, al progetto di simili soluzioni? Prima ancora: perché mai non se ne parla nemmeno?
Una risposta ci sarebbe, banale e amara. Ma anche semplice nel suo cinismo. Non se ne parla nemmeno perché noi non vogliamo. Siamo noi, noi cittadini, noi elettori, noi opinione pubblica a rimuovere il problema carceri. E a liquidarlo negandolo. Tranne quanti beneficino di particolare motivazione sui diritti umani, siamo più tranquilli e intimamente soddisfatti dell’ennesimo, allarmante inasprimento normativo. Allarmante per tutti, si badi: ché si ritaglia anche la nostra libertà, seppure miopi non ce ne accorgiamo e plaudiamo stoltamente a pessime leggi autoritarie.
Ciascuno di noi, uti singulus, se avesse la ventura di visitare interamente una struttura carceraria probabilmente si indignerebbe e si vergognerebbe della disumanità delle carceri, e dunque delle involuzioni legislative che la peggiorano periodicamente. Io me ne vergogno (inutilmente, dato che non ho poi fatto niente per attenuare il mio senso di colpa, e anzi ho tentato di rimuovere il mio sconcerto) sin da quando preparai la mia tesi di laurea, appunto sulle carceri, ed ebbi l’opportunità di visitare quelle della mia zona insieme al giudice di sorveglianza, che generosamente me lo consentì. Non ho più dimenticato gli orrori dei luoghi (non potendo assistere a quelli delle persone), il letto di contenzione innanzitutto. Alle mie domande un agente di custodia rispose che quando un detenuto aveva bisogno di una “calmata” (o espressione simile che non ricordo più) lo legavano su quel tavolaccio da tortura, con un buco all’altezza dei genitali da cui lasciava defluire urina e feci. Ingenuamente lo raccontai al mio professore di procedura penale. Ricordo ancora che sostanzialmente si dichiarò impotente. Non ignaro né sorpreso. E non mi diede alcun conforto. Una recentissima ispezione della Commissione d’inchiesta del Senato presso gli ospedali psichiatrici giudiziari (ieri manicomi criminali, oggi il nome è cambiato …) di Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Napoli Secondigliano, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere, tra le altre mortificazioni degli ospiti ha ritrovato il letto di contenzione. La Commissione, che parla di ergastoli bianchi ai quali vengono condannati di fatto (per dimenticanze, per mancanza di alternative, etc.), conclude che il 40% dei degenti potrebbero essere scarcerati e ha trasmesso la sua relazione alle Procure competenti.
La reazione della singola persona, dicevamo, sarebbe quasi certamente di sdegno per queste mostruosità. La folla no. La folla si rassicura e più o meno segretamente si complimenta con le istituzioni e con le forze di polizia quando quei delinquenti (si noti, non gli imputati presunti innocenti) marciscono in galera.
Alcuni, più ipocriti, e ciò a lungo è successo anche a me, si consolano dicendosi che è questo il sistema, dunque… Non ci sono alibi, invece. Non possiamo rassegnarci né rasserenarci. Il sistema siamo noi: i nostri parlamentari, vittime mediocri della tirannia del consenso, raggiungono l’unanimità proprio (forse solamente) nell’approvazione di leggi regressive. Che, per quel che qui ci riguarda, eliminando o riducendo notevolmente i benefici carcerari e le misure alternative alla detenzione, aggravano anziché ridurre il fenomeno criminale del paese. Chi è costretto ad espiare brutalmente la sua detenzione col trattamento che sappiamo (e con quel che di peggio non immaginiamo nemmeno) ha il 90% di probabilità di tornare a delinquere, mentre chi impara un lavoro, al contrario ha il 90% di probabilità di non tornarvi; i nostri magistrati, soprattutto quelli di sorveglianza, delle cui decisioni ci occupiamo soltanto quando un sacrosanto permesso, tra i tantissimi che giustamente concedono, sia stata l’occasione per un’evasione o un altro delitto; i nostri avvocati, le cui organizzazioni storiche come le Camere Penali si battono da sempre (e anche quest’anno lo stanno facendo su tutto il territorio nazionale) per reclamare i diritti dei loro assistiti. Spesso nelle singole vicende giudiziarie dovrebbero impegnarsi di più, anche se si tratta di stranieri o comunque di non paganti; noi cittadini, quando va bene indifferenti a problematiche che al contrario avvertiamo in termini opposti: di eccessiva indulgenza nei confronti dei delinquenti (tali ritenendosi quanti siano sottoposti ad indagine, specie se per reati gravi).
È vero: a lenire la pena (qui in senso stretto) vi sono le associazioni di volontariato. L’umanità degli angeli delle carceri supplisce magnificamente per quel che può. Ma non in tutte le carceri, né può darsi carico compiutamente di quanto occorre. Alcune preziose gocce di serenità e speranza in un subbuglio di miserie e infamie non possono esonerare né il legislatore, né il Ministero della giustizia, e specificamente il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dai loro compiti e dai vincoli costituzionali e internazionali. Noi tutti, a tutela di un patrimonio che è della collettività, abbiamo il dovere di reclamarli. Il 10 agosto scorso, proprio a Rimini, l’ennesimo tentativo di suicidio in carcere. Fortunatamente non è riuscito. Forse è un segno. Rimini potrebbe dare una sterzata in direzione della retta via. Ancora una volta, dipende da noi.
ANDREA SIMONCINI:
Grazie, grazie Avvocato perché tra l’altro ovviamente il meeting di Rimini non è una commissione parlamentare in cui si discutono i disegni di legge, è un luogo dove però le idee emergono e vengono messe sul tappeto. Questa direi singolarissima coincidenza che un ex presidente delle Camere penali faccia una proposta che è simile a quella di due magistrati di sorveglianza, è un fatto che già di per sé dovrebbe suscitare aspettative positive cioè positive sulla fattibilità. Questa idea di prendere coscienza del fatto che oggi le nostre carceri sono abitate in prevalenza non da persone condannate in via definitiva ma da persone che appunto godono di tutti i diritti puramente sulla carta, come è stato detto, ecco questa mi sembra una cosa molto interessante, su cui se manteniamo questi tempi forse c’è anche lo spazio per una rapidissima brevissima replica a tutti. Però ecco si è evocato dunque l’ambiente carcerario concreto, non come è descritto nei libri e nei manuali di diritto penale o di diritto dell’esecuzione penale, e allora io adesso do la parola a Nicola Boscoletto che, oltre che essere mio amico da tanto tempo, è il presidente del Consorzio sociale Rebus, all’interno del quale ci sono queste esperienze di cui Vittadini parlava all’inizio. Allora io gli chiederei proprio un po’ una sua valutazione.
NICOLA BOSCOLETTO:
Innanzitutto grazie per l’invito e grazie a chi ha pensato di utilizzare un po’ di questo tempo venendo oggi ad ascoltarci. Mi ero preparato un pensiero ma adesso lo cambio. Il motivo principale per cui lo cambio – a parte che sono state fatte delle relazioni esaustive, approfondite e quindi diciamo sottoscrivo tutto e quindi è inutile ripetersi – è soprattutto perché venendo qui a Rimini, anche se non ho ancora visitato approfonditamente niente, non ho ancora partecipato a un incontro, il solo percorrere qualche corridoio, vedere qualcosa mi ha subito stimolato. Allora adesso dirò delle cose che se capite possono essere di aiuto altrimenti magari possono anche ingenerare confusione ma è un rischio che mi prendo, insomma. E cioè riduco all’essenziale un breve pensiero, per leggervi due lettere che mi sono arrivate ieri da due detenuti che entrambi non possono essere qui, perché ergastolani, e che hanno ancora un po’ di strada da fare ma che reagiscono alla giornata che lunedì 16 agosto abbiam fatto in carcere tra un centinaio di detenuti, la Rose e i ragazzi ugandesi: sono venuti a trovarci e abbiam fatto un incontro insieme. Io credo che queste due lettere possano contenere una risposta reale al nostro problema. Il pensiero, prima di leggere queste due lettere, è che abbiamo parlato molto di giustizialismo, legalità, non profit, ma l’altra faccia della stessa medaglia è sicuramente il buonismo e il pietismo, una certa modalità di affrontare il bisogno, dove primariamente invece che rispondere a sé diventa più facile rispondere ai bisogni degli altri. La testimonianza di questo è che oggi il cosiddetto terzo settore, e questa era una paginetta che volevo fare oggi ma che non faccio, dico solo il titolo, oggi è un far west, oggi è dentro la confusione che c’è, in cui si trova tutto il resto delle problematiche, dalla giustizia alla sanità, alla scuola, alle strade, a qualsiasi cosa. C’è dentro anche la confusione totale di questi milioni di persone, di questo far west di confusione tra volontari, associazionismo, imprese sociali eccetera, in cui c’è un misto. L’unica cosa che allo stato va bene è quando gli conviene, o a gratis o al 50%; quando invece è una cosa reale, improvvisamente l’attività non è più un’attività al servizio della persona, ma è un’attività di tipo economico. Ma qui ci vorrebbero degli approfondimenti normativi, legali, nazionali, europei. Questo mi interessa dirlo perché è l’altra faccia della medaglia del giustizialismo, che ci deve assolutamente non vedere esonerati. E dico questo perché io ho maturato una certezza, e la certezza è che nessuna soluzione a nessun problema, dal più piccolo al più grande, può arrivare da riforme, piccole, grandi o medie riforme. Questa è una utopia, è una pura illusione. Anche quando in qualsiasi settore noi oggi partissimo con una riforma giusta a una velocità alta, anche se partissimo con l’alta velocità, dovremmo ammettere che da questo momento a quando arriveremo a una situazione dignitosa, decorosa, tutte le persone che passeranno, moriranno in questi trent’anni son state prive di una possibilità, son state prive di una dignità vera, di una libertà vera, di una felicità vera. Questa è una sconfitta inaccettabile, vuol dire che manca qualcosa che potrà essere raggiunta solo se: ma il solo se è un’utopia quindi non sarà mai raggiunta. Questo è per una serietà e una correttezza, per non prenderci in giro, primo per quanto ci riguarda, per non prendere in giro i detenuti, per l’andargli a dire che facciamo la battaglia, i diritti e l’acqua calda e eccetera eccetera eccetera. Questo non vuol dire che non si cerca l’esito, che non si battaglia, che non si sta in prima linea, no, anzi il contrario, però si sa perché, per cosa si battaglia e a che cosa e che cosa effettivamente risponde: alla necessità della persona, che il bisogno ce l’ha mentre respira. Quando ha bisogno di mangiare, non gli puoi dire “tranquillo stiamo facendo per te, vedrai che fra trent’anni ti portiamo da mangiare” no, c’ha bisogno in quel momento lì, ok? Nella mia esperienza, nell’esperienza dei miei amici, questa modalità di affronto del problema è stata fondamentale per noi e per generare grazie e Dio quello che ha generato. Ci sono queste tre righe di questo pensiero dell’ottanta, che ci hanno distribuito all’inizio di questo Meeting, di Giussani, che dice: “un adulto non può non essere appassionato a una vita, altrimenti o è un vecchio oppure è un bambino”. L’adulto è serio nella vita, la serietà nella vita è la passione per il significato. Perché questo ci fa dire che anche la battaglia a ciò che non va, e questo scrivetevelo perché mi è venuto proprio durante questa oretta qua, questo pensiero, anche la battaglia a ciò che non va può essere della stessa natura di ciò che si combatte. Questo ci può servire a capire chi siamo, dove siamo, che cosa vogliamo costruire, che cosa vogliamo combattere. E combattere è sempre per me un termine negativo, perché conta di più che cosa fai. Oggi lo sport nazionale è quello di dire ciò che non va e di lamentarsi. Questo è lo sport mondiale, non nazionale, mondiale perché poi noi siamo dentro un contesto mondiale non più nazionale. Passeggiando nel centro della fiera, dove è stato fatto questo omaggio a don Giussani che io ho avuto la fortuna di conoscere, mi è venuto questo pensiero, vedendo quest’uomo che ha fatto e ha costruito, vivendo lui in prima persona questa passione per la vita, rischiando lui in prima persona questa passione per la vita. Vi leggo la prima lettera: “ciao a tutti cari amici sono Dingiabledar, ora Giovanni Dingiabledar” – un albanese buddista che ha deciso di farsi cristiano, uno con mandato di cattura internazionale, un killer, uno che se lo vedevate prima di avere incontrato il significato della vita vi faceva veramente paura. Allora “ciao a tutti cari amici, una giornata splendida, piena, quella del 16 agosto, una giornata splendida piena di sole al Due Palazzi di Padova, con i fratelli e con le sorelle ugandesi. Nella mia rinascita, dopo la sofferenza che solo oggi mi fa rendere conto, mi trovo pieno di emozioni così grandi che mi fanno scoppiare il cuore, mi trovo con una pena grande, non ho il fine pena, ma non mi fa sentire in prigione, ero in prigione quando credevo di essere libero. Oggi grazie al buon Dio che mi ha fatto incontrare degli amici veri, grazie al Signore che mi ha donato la rinascita, oggi posso finalmente procedere nell’anno di catecumenato con il mio catechista don Lucio. Perché dico queste parole? Le dico perché vedo nei miei occhi la bellezza di tutti voi fratelli, che mi circondate di quel bene vero di cui ho bisogno. Rose, i suoi ragazzi e ragazze, gli amici di Padova, ma soprattutto i miei fratelli detenuti, mi hanno fatto partecipe di una giornata così bella che mai potevo immaginare prima. Condividere tutte queste emozioni mi fa scoppiare il cuore di gioia, mi fa sentire l’abbraccio di Gesù, quell’abbraccio che Franco mi diceva sempre ma che io non capivo con le parole. Oggi capisco cosa mi volesse dire, sapere che dall’altra parte del mondo c’è qualcuno che ama Gesù nello stesso modo che lo amo io, mi fa stringere il cuore. Ho visto che Rose e i suoi paesani sono delle persone speciali e con tanti progetti, desiderano realizzare tante cose. Come la Chiesa non ha mai dimenticato l’Africa, anche il mondo lì fuori non deve dimenticare che, sebbene siano di un altro colore, il loro cuore batte come il nostro. Io so che ho fatto del male e che sono un detenuto, so che c’è qualcuno che soffre per colpa mia ma in qualche modo cerco di aiutare un bambino ugandese a crescere bene e permettergli di non commettere gli stessi errori che ho fatto io nella vita precedente. La giornata del 16 agosto mi ha fatto capire che senza l’amore di Gesù Cristo, di Dio Padre noi siamo solo delle ombre nel buio. Abbiamo passato mezza giornata assieme a Rose e ai suoi ragazzi, abbiamo parlato di noi, di loro ma soprattutto del Signore che ci ama veramente come suoi figli. Momenti così intensi ne ho vissuti pochi, prima perché ero piccolo, poi perché c’era il disordine civile nel mio paese, poi perché ero diventato brutto e non vedevo più nulla che mi andasse bene. Mi rendo conto che la mia vita, che credevo fosse bella, era solo la vita che voleva per me il diavolo. Il Signore mi ha strappato dalle mani del diavolo: ecco perché sono ancora in vita e sono felice anche in prigione. Quando ho avuto l’incidente ero tutto rotto e stavo molto male, il mio amico che era in macchina con me è morto nell’impatto, io sono stato salvato perché il Signore voleva farmi insegnare ad amare, voleva far conoscere pure a me che cosa significasse il voler bene. Oggi capisco cosa vuol dire dolore nell’amare, perché quando si dà del bene si pretende di ricevere del bene, ma oggi anche se non ricevo nulla sono felice ugualmente. Prego per quella persona, perché anche lei venga presa dal Signore come sono stato preso io. In prigione non si può dire di stare bene ma neppure lì fuori potrei stare bene se non stessi bene con me stesso. Ho imparato un mestiere, ho imparato a fare le pizze, i dolci, a lavorare mentre prima non avevo mai lavorato. Oggi posso dire che con poco si può vivere bene. Il Signore mi dà sempre tutto quello che mi serve per vivere bene, se io lo ascolto e mi faccio guidare da lui non sbaglio più come prima, continuerò a peccare ma lui lo sa già, il mio impegno sarà sempre più per non sbagliare. Questo ho capito di tutto quello che è successo il 16 agosto. Vi saluto tutti ad uno ad uno con un forte abbraccio e con un grazie per il bene che mi donate ogni giorno. Un saluto particolare a don Carrón e il rinnovo dell’invito che non scadrà mai: se lui vuole le porte potrebbero aprirsi per farci una visita, anche se la sua presenza è presente in ogni nostro cuore. A volte serve pure una visita, soprattutto per chi non potrà mai uscire. Con tutto il bene di Gesù Cristo, Giovanni”.
Credo che non servano applausi, soprattutto perché questi non cambiano per un discorso, non cambiano per una legge perfetta, non cambiano per i diritti rispettati, non cambiano per la dignità, non cambiano per uno in cella, non cambiano per il medico, per la psicologa, per l’assistente sociale. La cosa grande di quello che sta succedendo, è che in tutta Italia, in più parti d’Italia, nelle carceri, grazie a loro, alla loro testimonianza prima di tutto, qualcosa sta succedendo, e questi sono gesti veri di carità e di gratuità. Nel termine volontariato, e così ritorno all’inizio, è stata attuata una grande riduzione. I cristiani il gesto di carità, di caritativa e di gratuità l’hanno sempre fatto, e con un significato vero, e non hanno bisogno di essere annacquati dentro il grande termine della generalità, della genericità, per perdere di contenuto e di valore. Grazie.
ANDREA SIMONCINI:
Io ringrazio Nicola, e ancora tutti voi per aver partecipato a questo workshop su questo tema. Ricordo ancora che sia gli esiti di questa discussione che i testi saranno disponibili sulla rivista. Ringrazio di nuovo ancora tutti quelli che hanno partecipato e vi auguro buon proseguimento del Meeting.
(Trascrizione non rivista dai relatori)