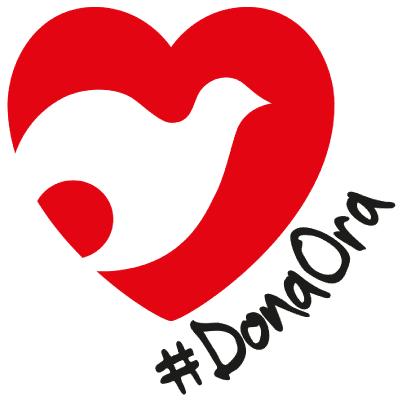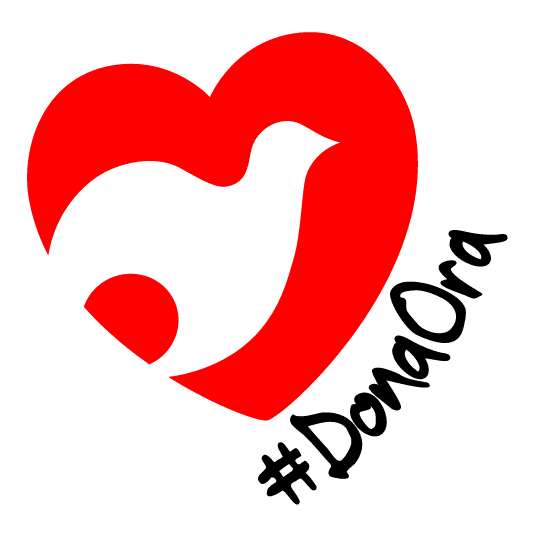Chi siamo
FRATELLI TUTTI. TESTIMONIANZE DI UN’AMICIZIA OPERATIVA SULLE ORME DI PAPA FRANCESCO
In collaborazione con Centro Sportivo Italiano.
S.Em. Card. Matteo Zuppi, Presidente CEI, Arcivescovo di Bologna in dialogo con Alberto Bonfanti, Presidente Portofranco; Vittorio Bosio, Presidente Centro Sportivo Italiano (CSI); Regina De Albertis, Direttore tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri e Presidente Consorzio Scuole Lavoro. Modera Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.
Nella sua enciclica “Fratelli tutti” Papa Francesco ha riassunto in modo particolarmente approfondito le sue proposte ed esortazioni per promuovere “la fraternità e l’amicizia sociale”. Dieci anni dopo la sua elezione vogliamo ascoltare e confrontarci con esperienze che possono documentare la fecondità di questo messaggio centrale del suo pontificato, in modo particolare nell’educazione e nell’integrazione. A partire da queste testimonianze il dialogo con il presidente della CEI, Cardinal Matteo Maria Zuppi, metterà in luce aspetti fondamentali per la costruzione di una amicizia sociale e della pace in un mondo sempre più segnato da solitudini, disuguaglianze, frammentazioni e conflitti.
Con il sostegno di isybank, Generali-Cattolica, Confagricoltura, Consorzio Scuole Lavoro, Gros Rimini SPA, e Tracce.
FRATELLI TUTTI. TESTIMONIANZE DI UN’AMICIZIA OPERATIVA SULLE ORME DI PAPA FRANCESCO
FRATELLI TUTTI. TESTIMONIANZE DI UN’AMICIZIA OPERATIVA SULLE ORME DI PAPA FRANCESCO
Martedì 20 agosto 2023, ore 15.00
Auditorium isybank D3
Partecipano
S.Em. Card. Matteo Zuppi, Presidente CEI, Arcivescovo di Bologna
In dialogo con
Alberto Bonfanti, Presidente Portofranco; Vittorio Bosio, Presidente Centro Sportivo Italiano (CSI); Regina De Albertis, Direttore tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri e Presidente Consorzio Scuole Lavoro.
Modera
Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS
Scholz. Un caro benvenuto ad ognuno di voi qua presenti e agli amici collegati per questo primo convegno del Meeting di quest’anno con il titolo “Fratelli tutti. Testimonianze di amicizie operative sulle orme di Papa Francesco”. In questo cambiamento d’epoca Papa Francesco ci ha consegnato l’Enciclica “Fratelli tutti”. Di fronte alle tante incognite del futuro ci invita a costruire luoghi di amicizia, di fratellanza, di aprire dialoghi per costruire la pace. Un invito che è rinnovato anche nel suo incoraggiante messaggio a questo Meeting del quale lo ringrazio di nuovo a nome di tutti voi. Vogliamo quindi mettere in luce la fecondità, l’importanza delle sue esortazioni, delle sue indicazioni, dei suoi suggerimenti e siamo molto grati ed onorati di poter farlo con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana il cardinale Matteo Zuppi, grazie.
Zuppi. Grazie, grazie a voi. Grazie.
Scholz. Saluto e ringrazio i quattro amici che abbiamo invitato per poter ascoltare le loro testimonianze. Saluto prima di tutto Regina De Albertis, Direttore tecnico e consigliere delegato di Borio Mangiarotti e Presidente di Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza, Brianza che è collegata con noi. Benvenuta, grazie.
De Albertis. Buongiorno a tutti, buongiorno.
Scholz. Iniziamo questo incontro allora con le testimonianze. Abbiamo chiesto ad ognuno di riflettere rispetto alla propria esperienza e di portarci la sua testimonianza rispetto a un brano che abbiamo scelto dell’Enciclica “Fratelli tutti”. A Regina De Albertis abbiamo proposto questo brano dell’Enciclica: “L’attività degli imprenditori effettivamente è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti. Dio ci promuove e si aspetta da noi che sviluppiamo le capacità che ci ha dato e ha riempito l’universo di potenzialità. Nei suoi disegni ogni persona è chiamata a promuovere il proprio sviluppo e questo comprende l’attuazione delle capacità economiche e tecnologiche per far crescere i beni e aumentare la ricchezza”. La domanda a Regina De Albertis è duplice – lei è imprenditrice, lavora nel mondo dell’edilizia e al contempo è mamma e ha un’attenzione particolare per il futuro della città nella quale vive – come vive lei allora queste parole a livello personale e come nell’edilizia, nell’urbanistica possiamo superare il rischio di creare periferia sociale invece di creare luoghi inclusivi. Grazie Regina, a lei la parola.
De Albertis. Grazie mille. Allora prima di tutto ci tengo a ringraziare tantissimo per l’invito e sono veramente dispiaciuta di non poter essere lì in presenza perché ci tenevo tantissimo, ma sono all’ottavo mese di gravidanza e quindi, di conseguenza, il ginecologo mi ha messo un po’ a riposo e quindi mi ha, diciamo, mi ha vietato di venire. Però l’anno prossimo, promesso, che non mancherò con i miei due bimbi perché è un’esperienza straordinaria e quindi vi ringrazio tantissimo per l’invito. Allora la sua domanda mi riporta un po’ alla parabola dei talenti che ho riletto, ho cercato di rileggere preparando questo intervento. Come imprenditrice io mi sono trovata più volte a fare scelte importanti per il futuro della mia impresa, per i posti di lavoro dei miei dipendenti e domande delle loro famiglie, per la soddisfazione dei clienti a cui appunto vendo i prodotti che realizzo, per l’impatto sulla collettività tutta delle scelte immobiliari fatte e, bisogna ammettere, in fasi critiche qualche volta l’imprenditore può capitare di pensare, di seppellire in una buca il talento ricevuto, ma non è mai stato così perché i doni ricevuti, i talenti ricevuti servono per vivere con responsabilità, per condividere, per fare il proprio mestiere con un approccio diverso. In più credo fortemente – perché il valore reale di un’impresa non è più determinato solamente dal livello di profitto, dalla pura redditività che appunto l’impresa genera, ma è strettamente connesso – in questo, appunto, credo fortemente – al valore condiviso che l’impresa è in grado di generare. Vi racconto brevemente, rapidamente di me per farvi capire come cerco, appunto, di applicare questo nell’attività quotidiana e per rispondere alle domande, alle domande poste. Sono un’imprenditrice edile di quarta generazione. Sin da piccola ho respirato l’aria dei cantieri. Mio papà mi portava in giro per i cantieri e mi diceva con passione e gioia: “Costruire è il lavoro più, più bello del mondo” e così, appunto, ho fatto ingegneria edile e lavoro, appunto, nell’impresa di famiglia. Uno dei lavori più importanti che ho seguito è riguardo alla rigenerazione di un ambito degradato periferico della mia città che è Milano. E, appunto – così rispondo alla sua seconda, alla sua seconda domanda – attraverso un piano integrato di intervento abbiamo trasformato questo ambito in un quartiere veramente all’avanguardia con tutte le dotazioni domotiche e la massima efficienza energetica. abbiamo realizzato un parco di oltre 16 ettari, quindi con tantissimo, tantissimo verde al servizio sia di chi appunto andrà ad abitare il quartiere ma di tutta la città di Milano. L’intervento appunto è in consegna adesso, quindi se vi capiterà di passare per la mia città vi invito a vederlo, ma la componente principale di questo intervento che consiste nella realizzazione di 1000 unità immobiliari è che la metà di queste sono destinate all’edilizia sociale, quindi si mette proprio effettivamente a terra un mix di destinazioni veramente importanti che fa in modo che appunto vengano eliminate quelle periferie ghetto a cui faceva cenno lei precedentemente. Sarà un quartiere dotato di tutti i servizi di tanti spazi condivisi che possono aiutare le persone possono aiutare anche le donne come me che sono mamme e anche lavoratrici. E secondo me questo è proprio un esempio di come bisogna progettare e costruire modelli diversi per il nostro futuro e questi devono essere messi al centro delle strategie del nostro settore. In particolare il mio settore, il settore delle costruzioni, ha molte colpe per lo sfruttamento indiscriminato delle risorse e ha una grandissima responsabilità per lo sviluppo futuro, per la rigenerazione dei nostri territori e per la rigenerazione in chiave sostenibile dei nostri territori. Come sapete adesso abbiamo davanti a noi la grandissima sfida del PNRR più delle metà delle risorse del PNRR, il cui obiettivo principale è un mondo più sostenibile interfaccia un settore delle costruzioni. Quindi questo mette proprio in evidenza come il settore delle costruzioni sia fondamentale in questo momento, quindi abbiamo una grandissima responsabilità, noi come costruttori davanti a noi, e fondamentale per riuscire in questo obiettivo è riuscire effettivamente a creare una forte collaborazione tra pubblico e privato. Non bisogna più ragionare come se pubblico e privato siano due parti contrapposte, ma devono lavorare insieme in un nuovo rapporto di fiducia e collaborazione. Questi sono veramente aspetti, aspetti fondamentali che io cerco di mettere a terra ogni giorno, impattano la mia impresa e lo faccio anche tramite la mia grande altra passione a cui lei faceva cenno prima, sempre trasmessa da mio padre, che è l’associazionismo. Sono infatti il presidente dei costruttori edili del mio territorio e tramite l’attività associativa, appunto, io cerco di mettermi a disposizione per un interesse collettivo, per trasmettere a tutti i miei associati questa nuova visione del fare impresa e questo nuovo concetto di importanza, di sostenibilità e di rigenerazione delle nostre città. Quindi questi sono temi, temi assolutamente centrali. Arrivo alla conclusione perché poi ci sono tanti relatori e non voglio, non voglio rubare altro tempo. In sintesi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riportare l’uomo al centro della nostra visione, al centro delle nostre strategie aziendali e sempre pensando a questo discorso ho pensato che il mio, diciamo la mia visione è popolata di tanti prefissi “ri-” perché sento e, vi giuro, che non è un buonismo ma è quello che penso davvero sia una necessità per tutti noi che l’unica strada per crescere sia quella di ritornare alle nuove generazioni ciò che abbiamo portato via in tutti questi anni. Dicevo è popolata di prefissi “ri-” perché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ri-generare le periferie con interventi di qualità, dobbiamo ri-naturalizzare il territorio con parchi e verde, dobbiamo ri-portare legalità, sicurezza sul lavoro, regolarità d el lavoro perché solo un lavoro dignitoso permette sviluppo, permette competitività tra le imprese, dobbiamo ri-dare un’occasione di lavoro ai carcerati, ai rifugiati, a chi è messo all’angolo – non è il momento di raccontarvelo, ma abbiamo fatto un bellissimo progetto in una scuola di formazione all’interno del Carcere di Opera, ma ci saranno tante, tante occasioni in futuro – dobbiamo ri-costruire un rapporto di fiducia tra pubblico e privato e così veramente possiamo trasformare i nostri territori. Per concludere, torniamo alla parabola dei talenti con cui ho iniziato: dobbiamo quindi far fruttare i doni che abbiamo ricevuto e per farlo dobbiamo alzare lo sguardo. Come dicevo prima noi costruttori in questa sfida abbiamo una grandissima responsabilità e siamo pronti per fare la nostra parte. Saluto tanto tutti, vi ascolterò con grandissima attenzione, sono dispiaciutissima di non essere lì. Lì ci sono tanti miei collaboratori, un mio strettissimo collaboratore- Luigi Parisi – che viene da sempre ci eravamo ripromessi, appunto, di partecipare assieme però sicuramente ci saranno tante altre occasioni. Grazie mille.
Scholz. Grazie mille. Penso un intervento che documenti che quella esortazione di Papa Francesco riguarda tutto non per ultimo per certi versi in primis il mondo dell’economia. Alberto Bonfanti, leggo subito il passaggio che abbiamo pensato insieme: “Ci sono periferie che si trovano vicino a noi al centro di una città o nella propria famiglia, c’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico, ma esistenziale e la capacità quotidiana di allargare la mia cerchia di arrivare a quelli che spontaneamente non sento parte del mio mondo di interessi, benché siano vicini a me.”
Penso che questo passaggio riguardi alcune caratteristiche fondamentali di Porto Franco.
Bonfanti. Grazie. Papa Francesco il 10 maggio 2014 alla giornata della scuola in piazza San Pietro parafrasando un proverbio africano disse “Per educare una persona occorre un villaggio”. Anche nel recente viaggio a Lisbona, in occasione della giornata mondiale dei giovani, incontrando i rappresentanti di alcuni centri di assistenza di carità, Papa Francesco ha affermato l’importanza di fare il bene insieme. Sono partito, voglio partire da queste citazioni in linea assolutamente col titolo del meeting e del nostro incontro, perché Porto Franco centro di aiuto allo studio gratuito per gli Studenti delle scuole medie inferiori e superiori è una sorta di piccolo villaggio anzi sono dei piccoli villaggi disseminati in Italia sono 49 le sedi al momento, villaggi disseminati alle periferie delle nostre città e vorrei, nei minuti che ho a disposizione, chiarire perché affermo che porto Franco è un villaggio, la cui legge è la gratuità e l’amicizia fra tutti i componenti che vivono: volontari, personale che lavora e ragazzi. Porto Franco a Milano nasce nella primavera del 2000 dalla passione educativa di un sacerdote milanese don Giorgio Pontiggia che ha provocato alcuni insegnanti, fra cui il sottoscritto, affermando: “Ma noi per l’amore a Cristo che viviamo non possiamo non desiderare di incontrare i ragazzi in modo libero. E per farlo non si può che partire dal loro bisogno più significativo, perché la persona non coincide con il bisogno ma emerge nel bisogno”. Solo affrontando insieme il suo bisogno si incontra veramente l’altro e non un’idea, anche buona, che abbiamo dell’altro, ma che abbiamo noi.
“Allora mi sono detto” (cito dalla grande occasione il libro che racconta l’origine di Porto Franco) “Allora mi sono detto, ma se dobbiamo aiutare i ragazzi qual è il punto in cui fanno più fatica, il bisogno che esprimono di più? La scuola, partiamo da lì, e incontrando la persona, non sappiamo cosa viene fuori, può venire fuori tutto, lentamente, una coscienza di sé, del perché sia al mondo” (fine della citazione). E la scuola, in tante altre occasioni ha ripetuto, e la scuola lo diceva da rettore provocando, è una convenzione sociale, ma non è una convenzione sociale la passione per la conoscenza, non è una convenzione sociale, anzi il fatto che i ragazzi devono fare i conti con il primo dato che la realtà esige loro, che è la scuola, non affrontando il quale le esigenze di protagonismo dei giovani inevitabilmente cerca altre strade non sempre corrispondenti al loro desiderio.
Ecco quindi porto Franco è pertanto un luogo dove i ragazzi sono aiutati One to One, gratuitamente, nelle materie scolastiche, da volontari, che hanno una certa competenza in quelle materie, e, cosa interessante, non sono solo professori. Abbiamo calcolato in questo ultimo anno scolastico nei 49 centri in Italia sono state svolte 60.000 ore di lezione gratuite, sono stati accompagnati più di 2500 studenti grazie all’azione di quasi 1000 volontari. Porto Franco è quindi un villaggio popolato da persone di ogni età, insegnanti in attività, professionisti in pensione, da giovani di ogni nazionalità, colore e religione.
E’ un villaggio, che nasce e si alimenta dalla gratuità dei volontari. E qual è l’origine di questa gratuità? E’ stato chiesto al cardinal Zuppi nell’incontro che ha fatto con tutti i volontari dei vari centri d’Italia il 21 giugno 2022, e riporto un brano della sua risposta, che è riportata nel libro “Uno un faro per la vita”, che riporta l’assemblea fatta col cardinal Zuppi, è quella di gennaio fatta col presidente della Fraternità, Davide Prosperi. (Cito:) “La gratuità ce la da sicuramente il Vangelo, perché quando lo ascoltiamo ci sgrassa un po’ di calcoli dalle considerazioni dei pregiudizi, o almeno ci prova, e poi anche l’amicizia fra voi fa crescere la gratuità. Voi non siete colleghi e questo è uno dei grandi segreti, la gratuita è che vi volete bene, e che questa è l’origine di tanta crescita di fraternità fra voi, perché la gratuità uno non se la da solo” (fine della citazione).
Ecco, la forza e il metodo di Porto Franco, l’amicizia fra coloro che vi operano, siano essi volontari o persone stabili, un’amicizia operativa, perché un’amicizia non è mai vera, se non opera, se non affronta la realtà. E questo contiene un grande insegnamento, l’educazione non è mai la genialità del singolo, ma sempre l’espressione di una comunione, di un’amicizia, e questa amicizia a Porto Franco accade a tutti i livelli, tra i volontari di ottant’anni e i ragazzi di 15, tra gli studenti universitari e i ragazzi delle scuole medie superiori che loro aiutano, e che aiutandoli i ragazzi universitari imparano ad amare, e aiutano i ragazzi ad appassionarsi alle materie, che per loro sono lontane 1000 miglia, o tra i ragazzi delle scuole medie superiori, che aiutano i più piccoli. Quest’anno sono arrivati anche dei ragazzi che hanno fatto il percorso di CTO, percorso per le competenze trasversali. Una di loro, alla fine delle ore obbligatorie, ha voluto fermarsi e dire che vuole venire ancora, perché, ha detto, sono grata di aver intrapreso questo percorso, perché posso dire di essere cresciuta come persona, di aver iniziato a vedere alcuni aspetti della vita in modo diverso. Questa amicizia nasce anche tra i ragazzi che lo frequentano, perché Porto Franco è ormai diventato un luogo di socialità, ci si ferma a studiare, a chiacchierare. Quest’anno, solo a Milano, abbiamo calcolato 6000 presenze nell’aula adibita allo studio personale e 800 pasti consumati e preparati dai ragazzi nella piccola cucina creata per permettere a loro di prepararsi questo pasto frugale prima di iniziare a studiare. Porto Franco è quindi un villaggio dove la diversità è accolta, rispettata e valorizzata, perché la gratuità tra riconoscere la comune natura umana, il comune destino e l’esperienza cristiana che la vivifica, genera accoglienza con chiunque. Come ha detto il Papa a Lisbona “Nella Chiesa non ci sono porte, tutti possono entrare”. E’ bello vedere i ragazzi musulmani partecipare alle feste di Natale e di Pasqua, vedere come viene raccontato nel libro di Perillo “Fuochi accesi”, che abbiamo presentato a Bologna col cardinale l’anno scorso, come la famiglia di un amico musulmano di Bologna, morto prematuramente, Razzi, abbia voluto invitare al funerale del figlio le donne cristiane, che lo hanno aiutato. Così come è stato bello vedere, che i ragazzi di Milano, a fine Ramadan, hanno voluto organizzare una cena per festeggiare e hanno invitato gli amici cristiani. Infine Porto Franco è un villaggio dove uno cresce e va nel mondo, va, ed è bello pensare ai tanti ragazzi in questi 22 anni, che hanno intrapreso una strada, sono diventati professionisti, va e non dimenticano quello che hanno ricevuto. Come non dimenticare, appunto, la nostra Sina che davanti al Papa, il 15 ottobre scorso, in occasione dell’incontro con il movimento di Comunione e Liberazione per i cent’anni della nascita di don Giussani, ha parlato del suo incontro di Porto Franco e di come da lì è iniziato, parole sue, “un percorso per conoscere Dio, per conoscere il Padre, per conoscere me”. Ma sono tanti quelli che testimoniano in vario modo la loro gratitudine per quello che hanno ricevuto. Vanno e magari ritornano. In questo ultimo periodo sono arrivati i figli dei ragazzi che abbiamo aiutato nei primi anni 2000, ed è bello vedere questo, come la nostra Nurgul che fa la mediatrice culturale alla questura di Milano, che ha portato i suoi figli. Forse è per tutto questo che il presidente Mattarella, riconoscendo l’esemplarità, la semplicità e la continuità di questa iniziativa, ha voluto premiare Porto Franco, assegnando immeritatamente a me, ma meritatamente all’esperienza che rappresento, l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana il 31 marzo scorso. Onorificenza che ci ha commosso, e che fa crescere in tutti noi una maggiore consapevolezza e responsabilità nel ricominciare il nostro lavoro da settembre, perché il mare del bisogno educativo è immenso, e la nostra esperienza è solo una piccola goccia, ma che fa crescere di gratitudine innanzitutto noi. Grazie.
Scholz. Grazie Alberto Bonfanti. Andiamo a parlare di sport. Leggo il brano che abbiamo scelto: “Per quanto riguarda gli educatori e formatori che nella scuola e nei diversi centri di aggregazioni infantili e giovanili hanno l’impegnativo compito di educare i bambini e i giovani, sono chiamati ad essere consapevoli che la loro responsabilità riguarda le dimensioni morali spirituali e sociali della persona, i valori della libertà, del rispetto reciproco e della solidarietà possono essere trasmessi fin dalla più tenera età. Per il fascino e l’attrattiva che lo sport esercita soprattutto sui giovani, è sicuramente una delle modalità più interessanti e anche più incisive per creare amicizia, per introdurre i giovani a una vita sociale sempre più matura”.
Bosio. Grazie, anzitutto ringrazio i dirigenti del meeting per questo invito, per essere qui oggi. Allenatori, dirigenti sportivi, arbitri e giudici di gara sono gli adulti che promuovono e organizzano lo sport all’interno del Centro Sportivo Italiano, che nasce nel 1944, siamo vecchi, addirittura più vecchio di me, insomma sono grandi. Cerchiamo di unire donne e uomini capaci di dedicare il loro tempo alla fondamentale opera educativa attraverso lo sport. Se dovessimo cercare una sintesi di tutto questo, diremmo che facciamo ogni cosa per il bene dei ragazzi, perché ai ragazzi vogliamo bene, vogliamo il loro bene. Al di fuori di questo punto fondamentale non credo che ci possa essere un’esperienza sportiva cristianamente ispirata. Dobbiamo contrastare la mentalità corrente, che fa pensare ai ragazzi e ai giovani che si avvicinano all’attività sportiva, che l’attività sportiva possa essere solo finalizzata al risultato, e all’affermazione di sé. Questo atteggiamento, che non è del CSI, non è del centro sportivo italiano, produce, e uso una bruttissima parola, produce scarti. Quelli che non hanno il talento per diventare campioni, che non hanno doti particolari per emergere nello sport, vengono scartati. E il Centro Sportivo Italiano ha fatto in modo che, con questi scartati, ha costruito le proprie fortune, nel senso che abbiamo fatto del motto di accogliere le persone con meno qualità, le abbiamo accolte tutte. E abbiamo giocato la partita che, dentro l’attività sportiva, ci possono stare tutti e ci stanno naturalmente con le qualità che hanno. Io credo che un ragazzo, una famiglia abbia il diritto di scegliere anche di fare una vita, che non può essere solo finalizzata a diventare qualcuno nello sport. Credo che non avremo formato tanti campioni, poi ci sarebbe molto da dire anche su questo, perché tanti poi sono arrivati ad essere campioni dopo, però non sono magari diventati campioni, ma sono diventati dei buoni cittadini, dei buoni ingegneri, dei buoni medici, a questo abbiamo sempre puntato. Credo che la fratellanza occupi, all’interno di questo progetto, una parte fondamentale del nostro progetto. Bisogna quindi coniugare i verbi fondamentali, accogliere, proteggere, promuovere ed integrare. Sull’integrazione voglio fare un passaggio, che arriva prima nella Fratelli Tutti, ma ne ha parlato anche un momento fa anche chi mi ha preceduto. Quando sono arrivati i primi immigrati, la prima cosa a cui abbiamo pensato è stato dare accoglienza ai ragazzi dentro l’attività sportiva. Non dico quello che dicevano all’esterno, magari, che ci definivano cattolici bigotti, ma anche al nostro interno, ci si chiedeva perché dobbiamo fare attività sportiva per quelli che non sono nostri, che la pensano diversamente. E abbiamo stabilito che per noi era fondamentale fare accoglienza, l’abbiamo fatto senza se e senza ma, e credo che abbia prodotto i risultati che vediamo oggi, poi è evidente che noi cattolici tante volte siamo bravi nel fare dei distingui, anche su quello, ma credo che il Vangelo non lo si può leggere a seconda delle convenienze, ognuno prende del Vangelo la parte che gli interessa, soltanto va letto tutto e se lo leggiamo tutto credo che l’accoglienza vada messa assolutamente al centro. Credo che il centro sportivo italiano questo lo abbia sempre fatto con amore. Abbiamo fatto, nei nostri ottant’anni di storia, siamo stati i primi a fare l’attività per i disabili, per i diversamente abili. Adesso la fanno tutti o la fanno in tanti, ma all’inizio quando facevamo l’attività per i disabili lo slogan era sempre lo stesso, attaccati alle tonache dei preti, i soliti cattolici bigotti. Adesso magari i disabili, noi l’abbiamo fatto e lo facciamo tutt’ora perché crediamo in quello che facciamo, e perché’ gli vogliamo vene. Adesso magari tante volte i disabili vengono usati per mettere in vetrina, e questo credo che sia un bruttissimo messaggio, credo che il messaggio che deve passare è un messaggio che è quello dell’accoglienza, e l’accoglienza che mettiamo al centro, che mettiamo al centro del nostro operare passa da tanti volontari, da tante persone che si danno da fare per il bene dei ragazzi.
Io devo dire grazie a tutte queste persone, perché chiaramente in giro per l’Italia ci sono centinaia e migliaia di persone che se ne occupano e spendo una parola anche sui genitori, perché spesso, il genitore credo che sia il mestiere più difficile del mondo, io non lo sono, ma credo che sia il mestiere più difficile del mondo, spesso e volentieri, sempre, viene messa in evidenza, quando su un campetto di periferia di calcio succede qualcosa che non dovrebbe succedere, magari fra genitori o fra dirigenti, la stampa si precipita sopra, descrivendo tutte le più brutte cose che si possono dire. Mentre dei genitori devo dire che, nell’esperienza vissuta sul campo, ho visto tante tante persone brave che fanno tanto bene per il loro e per i figli degli altri, e ce ne sono tante che se ne occupano, per il bene dei figli degli altri. E dobbiamo dirlo, perché altrimenti facciamo sempre passare solo ed esclusivamente quello che sono le cose brutte che si fanno, e io credo che invece si fanno tante, tante cose belle, che vanno messe in evidenza. Vedendo la Fratelli Tutti credo che Papa Francesco sia un innamorato dello sport, non solo perché tifoso di una squadra dell’Argentina. Quando ci hai incontrato, ha incontrato gli sportivi, usa spesso la parola amatori amatour per la verità usa, e qualcuno mi ha anche chiesto, fammi capire, per noi gli amatori sono i grandi, quelli più adulti che curiamo, ma non sono sicuramente al centro dei nostri pensieri. Ecco lui per amatori intende i nostri volontari che si prestano al bene dei ragazzi e questo credo che il centro sportivo italiano in questi anni lo abbia fatto, lo abbia fatto anche bene, grazie proprio anche alle persone che se ne sono occupate. Lo sport in oratorio è l’ultima cosa che dico. Noi siamo nati, siamo orgogliosi di essere nati dall’Azione Cattolica, che, ancora prima ancora che finisse la guerra, ha pensato, spronata da Pio XII, di creare un’associazione che promuovesse attività sportiva per i ragazzi. Non era ancora finita la seconda guerra mondiale. E quando abbiamo iniziato quell’esperienza credo che sia stata un’esperienza dentro le parrocchie. Oggi è un po’ più complicato farlo, non ci sono più i preti di una volta, dicono, non ci sono più i preti, il problema è quello, non ci sono più i preti, ma ci sono i laici, non ci sono più i preti ma ci sono i laici. E credo che preti e laici debbano fare quadrato insieme per far crescere un’attività, quella sportiva, che può essere uno strumento stupendo e spettacolare dal punto di vista educativo ed attrattivo per i nostri ragazzi. Grazie
Scholz. Grazie a Vittorio Bosio anche per la schiettezza.
Dario Odifreddi, la frase dell’enciclica è molto breve ma densa: “C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo tutti a vicenda a guardare avanti”. Che significato ha questa riflessione per un luogo come Piazza dei mestieri e per altre realtà di formazione professionale?
Odifreddi. Innanzitutto questa è una frase che, leggendo l’enciclica, ho trovato profondamente vera perché a 10 anni o a 90 anni tutti abbiamo bisogno di una comunità, abbiamo bisogno di amici con cui affrontare insieme la vita, abbiamo bisogno di amici con cui scoprire il senso della vita, Ma oltre essere una frase bella e vera, queste è anche una frase molto sfidante, perché sfida la libertà, perché davanti a una proposta di amicizia, il mio si e il mio no restano liberi. E io parto dal mio primus importante della vita a 12 anni, quando ho incontrato un frate, fra Bruno, che è diventato per me un padre per tutta la vita e, secondo, due anni dopo, quando ho incontrato l’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione a 14 anni.
E lì è nata un’amicizia, e si viveva una comunità, e tutto acquistava senso. Io avevo una situazione familiare complicata a casa, e la mia situazione rimaneva complicata, ma non era più soffocante, c’era un respiro della vita. Poi a un certo punto, e lo dico brevissimamente perché al meeting l’ho già raccontato, 10 anni dopo, a 24 anni, in un banale incidente in montagna, muore l’amico più caro mio, di Cristiana e di tanti altri, e li c’è la contraddizione totale, il dolore, la ribellione, la rabbia sembrava che la promessa dell’inizio venisse tradita che non potesse esserci. In quella vacanza, dopo che era successo, alcune ore dopo telefona Don Giussani e dice: “Terminate la vacanza”, ancora la ribellione, ma come possiamo terminare la vacanza con quel nostro amico morto lì? Bene, salto tutto quello che c’è di mezzo, l’ultima sera che era due giorni dopo, nella vacanza abbiamo fatto una festa in cui si rideva e in cui si piangeva e io non ho mai percepito più nella vita una presenza del mistero di Cristo come in quel momento. Quello che poteva essere la fine di tutta la nostra amicizia, di tutta la nostra esperienza è stato veramente l’inizio. Dopo quarant’anni con quegli amici siamo ancora insieme, noi, le nostre famiglie, i nostri figli e ormai essendo vecchietti anche i nostri nipoti. La Piazza dei Mestieri nasce da questa amicizia. Non sarebbe potuta nascere senza questa amicizia e nasce per uno struggimento, lo struggimento che sentivamo guardando tanti giovani, tanti ragazzi che si perdevano, che abbandonavano la scuola, che non trovavano lavoro, insomma tutte le cose che valevano quando è nata la Piazza dei mestieri nel 2004 e che valgono ancora oggi. E allora abbiamo messo su questo luogo educativo in cui adesso siamo a Torino, Milano e Catania. L’anno scorso abbiamo incontrato e accompagnato 5000 ragazzi. Questo luogo educativo dove si studia, ci sono i percorsi di qualifica professionale, di diploma professionale, ci sono i laboratori dove i nostri ragazzi imparano un mestiere, diventano cuochi, cioccolatieri, panettieri, diventano grafici, informatici, conciatori, eccetera e però in piazza non solo si studia, ma si lavora e questo è l’aspetto innovativo diciamo no di questo modello. Abbiamo voluto che per ogni attività educativa che c’era alla Piazza dei Mestieri ci fosse un’attività produttiva. Per questo abbiamo aperto un ristorante, un pub, una agenzia di comunicazione, una bottega che vende i prodotti fatti dai nostri ragazzi perché volevamo che questi ragazzi cominciassero a riappassionarsi al lavoro, imparassero ad amare il lavoro come una delle modalità più importanti per la realizzazione di sé e, ultimo aspetto, alla piazza ci si diverte anche si fa cultura abbiamo un cartellone di 70 eventi culturali all’anno, rassegna jazz, rassegna di teatro, un concorso di poesia e prosa perché anche lì i ragazzi possano provare ad esprimere, aiutati dai loro insegnanti, quello che hanno nel cuore con le parole della poesia e questi ragazzi sono impressionanti perché questi ragazzi – e se avete modo c’è una mostra al Meeting, permettetemi lo stacco pubblicitario, dice da solo non basto, fatto insieme ad amici di Porto Franco e Kairos e noi abbiamo voluto provare a dire: ma che cosa vediamo emergere da questi ragazzi, un urlo, un urlo drammatico, tanti ragazzi vengono da noi e ci dicono: io sono trasparente, nessuno mi vede oppure hanno abbandonato la scuola e dicono: a nessuno interessava chi ero, neanche il mio nome, sono il cognome per l’appello, i dolori o i desideri che io ho, e allora ogni giorno davanti a questi ragazzi 400 dipendenti della piazza, più professionisti, imprenditori eccetera, si alzano per raccogliere questa sfida, la sfida di andare davanti a loro, che è difficilissimo, la sfida di andare davanti a loro nudi, non andando a dirgli cosa devono fare, senza moralismi, senza paternalismi, con le regole, ma non come fine, ma abbracciandoli forte perché la cosa più impressionante che noi possiamo testimoniare e vediamo e di cui noi siamo grati è rivedere rifiorire su questi ragazzi la letizia e sentire loro dire che ricominciano a dire: Io valgo, ma io non valgo per quel che faccio, per quel che riesco a fare, io valgo perché ci sono e perché per qualcuno conto qualcosa, sono qualcosa per qualcuno. Chiudo, chiudo dicendo che, non c’è il tempo qua sicuramente, la piazza è una storia, è una storia di vent’anni, è una storia di storie, storie a volte drammatiche e a volte lievi, storie di cambiamento e storie di fallimento perché noi non possiamo risolvere il problema del mondo, noi possiamo provare gratuitamente ad accompagnare, ma la libertà di cui dicevo prima c’è sempre. Concludo Eminenza dicendo che abbiamo bisogno della paternità sua – come il 12 luglio ci ha già testimoniato a Bologna all’incontro con i responsabili nazionali della formazione professionale, una paternità che corregge suggerisce e sorregge, abbiamo bisogno anche dell’aiuto e della paternità della Conferenza Episcopale nel dialogo culturale, nel dialogo istituzionale, perché la prima cosa – prima della scelta delle policy – la prima cosa è che bisogna riportare al centro questo grido, se no tutte le cose che fanno e tutte le risorse che si impegnano sono inutili e finisco dicendole che il prossimo anno è il nostro ventennale, lo festeggeremmo a Torino e se i suoi impegni mondiali glielo concederanno sarà una grazia per noi averla nostro ospite.
Scholz. Eminenza, quattro testimonianze che documentano come è possibile costruire l’amicizia sociale, la fratellanza nei luoghi difficili per mille motivi, per il disagio sociale, per le mancanze di coesione sociale, per anche mancanze di un sostegno generale politico: un suo commento.
Zuppi. Intanto già c’ho l’agenda per l’anno prossimo. Dunque, io sono molto contento devo dire ovviamente anche di queste bellissime testimonianze, credo che appunto poi ognuno potrebbe portare tanto perché in amicizia non è .. così nella Fratelli tutti Papa Francesco direbbe l’intimismo, gli intimissimi egoistici, no? Cioè tutto per il nutrimento del proprio io, il problema è che sto bene io, questo è il discorso, amicizia operativa è io sto bene se faccio star bene, io sto bene se cambio le cose perché poi l’amicizia è per forza operativa proprio perché non è intimismo egoistico. La seconda cosa: c’è tanta gioia nelle cose che abbiamo ascoltato, cioè c’è tanta vita, tanta passione, allunga la vita perché insomma qualcuno mi sembra che qualcuno sta sul pezzo da molti anni e mi sembra che oltretutto non ha nessuna intenzione di .. mi sembra che abbia ancora parecchia birra, parecchia voglia, desiderio di fare tante altre cose e per questo sono veramente convinto che l’amicizia sociale, questa espressione che regola un po’ la Fratelli tutti, che libera da quel discorso dell’intimismo egoistico, ma c’ha tutti sacerdoti, eh? perché mica soltanto noi, ci sono tanti sacerdoti dell’intimismo egoistico, che spesso devo dire stanno molto più a sentire di quelli appunto diciamo così della Chiesa, a mio parere. Credo che la bellezza anche delle cose che abbiamo ascoltato, di questa amicizia sociale che ci apre alla vita, che cambia la storia, che fa incontrare tanti, che cambia la vita anche fosse soltanto di uno, di un ragazzo che trova se’ stesso, che trova la propria dignità, il proprio valore, e una delle cose più importanti della Fratelli tutti, il valore di ognuno, che richiede anche una grande passione, che richiede tanta paternità. Perché prima si domandava i preti cominciano a scarseggiare. Io mi auguro che non scarseggino i padri però. Questo è il nodo: se non ci sono i preti, quelli famosi per chiacchierare, diciamo così, dell’epoca, nemmeno, non più uno, ma che ci siano tanti che vivono questa amicizia aiutando con la paternità, con un’amicizia vera, come avete detto voi. Le altre cose, rapidamente, che mi sono venute in mente: uno, cominciare da Regina, beh, i beni son comuni. C’è una cosa che ha fatto arrabbiare qualcuno della Fratelli tutti, sulla proprietà privata. Invece, a me dispiace, ma è dall’inizio: quel talento è tuo, però quel talento se non lo usi per gli altri lo perdi e il discorso anche dei beni che servono, se servono agli altri, se servono per tutti, guardate, al contrario, quell’individualismo imperante con cui pensiamo di trovare tante infelicità individuali e non le troviamo, perdiamo anche i nostri beni. Perché, come giustamente diceva Regina, è spendendoli per gli altri, utilizzandoli per gli altri, che appunto, trovo quel bene comune che è anche il mio, per cui non è che ci rimetto, per certi versi trovo 100 volte tanto. L’altro discorso faccio proprio sottolineature rapidissime. Di Alberto: il discorso della periferia vicina. L’amicizia sociale ci accende il mondo intorno, altrimenti trovo tutto grigio, non ricevuto, al contrario la periferia non è soltanto geografica. Papa Francesco non ha mai detto, è anche geografica, ma è anche la periferia del vicino di casa, di quello che io incontro o che evito appunto perché guardo tutto senza amicizia. La parola chiave che Alberto ha utilizzato è quello della gratuità, e l’amicizia è gratuita. Quando ci presentiamo col conto vuol dire che ce ne è rimasta molto poca, oppure vuole dire che era interesse nel senso “lo faccio perché mi conviene” e credo che questo, guardate è una delle cose più nostre, perché è davvero che è dal Vangelo che nasce la gratuità che vuol dire tante cose, che non è soltanto non avere interesse, non avere riscontro, il farlo e basta, no? Quindi anche più forte della disillusione, più forte del fatto ma io voglio vedere il risultato, perché ci sarà il risultato, la gratuità significa anche questo no? E non un’idea nostra dell’altro, molte volte gli altri devono essere quello che pensiamo noi: no! L’amicizia la vivo con l’altro, anche antipatico come è, anche che faccio una grande fatica a trovare quello che ci unisce, punto, non l’amicizia dell’altro. Io oggi l’ho voluto citare, che era bellissimo, di Giussani: “ bisogna abolire l’estraneità”, l’ho detto e lo ripeto che questa abolizione è valida tutt’ora, adesso però facciamo soltanto alcuni…oppure la discipliniamo un po’. Abolire l’estraneità vuole dire che niente è estraneo, che tutto mi interessa e questo è bellissimo e appunto poi ne vediamo l’operatività in quei pezzi di mondo diversissimi, anche a volte faticosamente messi insieme anche dalle vostre esperienze che abbiamo appena finito di ascoltare e quindi l’educazione che non è soltanto quindi l’istruzione, che è una cosa un po’ ovvia, ma ricordiamolo sempre: io non ti devo soltanto fornire un po’ di nozioni, se non c’è la educazione che è aiutarti ad essere profondamente te stesso, il valore, il merito, questo sì che è il vero merito che dobbiamo dannarci finché non lo si trova. Dannarci nel senso ovviamente buono del termine, di non darci pace finché. …perché c’è in ognuno, ma c’è bisogno di qualcuno che te lo tiri fuori, che è appunto l’educatore. Le ultime cose poi, il discorso di Vittorio. Nessuno scartato, liberarci dalla prestazione, guardate, importantissimo: che poi significa, a mio parere, divertirsi di più e a mio parere anche diventare ancora migliore, perché ci sono nell’ansia di prestazione a tutti i livelli, a cominciare anche dalla mia categoria, pericolosissimi, perché poi, l’ho visto in una mostra che ho visto prima, una cosa bellissima, la bellezza non è la perfezione. Guardate è molto intelligente, e purtroppo ci abbiamo qualche volta, e per di più anche per motivi commerciali, di tanti immagini pornografiche, perché questa è veramente la pornografia, a parte quella tecnica che quella è proprio, …ecco…la pornografia di immagini, di stereotipi, di un immaginario fasullo, solo che poi crea delle sofferenze terribili per cui mi sembrava davvero molto importante questo discorso del liberare, per cui non è nessuno scartato, è molto giusto. E poi quella domanda: perché farlo per quelli che non sono nostri? Purtroppo qualcuno lo fa apertamente, forse in maniera un po’ sfacciata e ingenua, molti se la fanno e non lo dicono. Molti stanno solo coi nostri, peccato che nostro Signore ci ha inguaiato perché i nostri sono tutti, perché non c’è nessuno che non sia nostro. La nostra amicizia non ha frontiere. Chi parlava prima dell’essere? Dello struggimento? Tu! Ecco. Dobbiamo avere uno po’ di struggimento, ci libera anche da tante penose lamentele che facciamo su “oggi il sugo venuto male, mannaggia”, “oggi la fettina non è come quella di ieri”, il vittimismo proprio è una cosa.. dovremmo vergognarci, da benessere per cui finiamo soltanto per parlare di cose inutili molte volte. Lo struggimento ci riempie di passione, di attenzione, per i fratelli più piccoli di Gesù, ci libera da tanta inutilità nostra e ci riempie di significato, di senso. Loro quattro sono contentoni, questo è il problema! Non dicono: mannaggia ma chi me lo fa fare? Penso che hanno trovato il desiderio anche della loro vita. L’ultima cosa finisco se no oggi Bernard…, oggi è san Bernardo, lo dico perché se qualcuno se l’era dimenticato oggi è San Bernardo, secondo alcuni l’ha fatto apposta, in ogni caso gli facciamo volentieri gli auguri. L’ultima cosa appunto: l’accoglienza è perché, per il bene degli altri. Sì, penso che le scuole professionali, innanzitutto penso personalmente, sono davvero che sono proprio gli scarti che ritrovano il valore, la bellezza. Ascoltare alcune delle loro storie, dimostra quanto è una sfida enorme perché siano davvero delle scuole di formazione di serie A, non di serie B, tutt’altro. E quell’urlo, ecco e finisco con questo, perché Dario ha parlato tanto dell’urlo, dell’urlo che dà fastidio qualche volta, magari guarda che ignorante, oppure diciamo stigmatizziamo l’urlo, siccome il moralismo è molto in agguato, dappertutto, ci abbiamo il nostro, ma ci sono certi moralismi laici che sono molto preoccupanti, perché invece, cos’è che racconta Dario dell’amicizia, in cui io cerco di capire quell’urlo, senza paternalismo, ma con paternità. Siccome il paternalismo è molto facile, anzi ci fa anche sentire qualcuno, gli diciamo tutto, ma non lo aiutiamo, non rispondiamo appunto all’urlo che è dire: io valgo, aiutami a capire il mio valore, che è questo. Beh, è il miglior commento, può essere uno dei commenti al Vangelo di oggi: anche la cananea gridava, urlava con insistenza, qualche volta anche i ragazzi in qualche modo con tanta insistenza, se troviamo la risposta ecco si compie il loro il desiderio e in fondo anche il desiderio di Gesù, cioè che ognuno trovi se stesso. Grazie di questa amicizia operativa.
Scholz. Io penso che possiamo dire che queste amicizie di cui abbiamo sentito parlare sono in un certo senso profezie della pace, perché è difficile immaginare una pace senza persone che hanno fatto le esperienze di cui abbiamo adesso parlato. Per avviarmi alla domanda che poi le voglio porre citiamo anche qua un brano dell’enciclica che dice: benchè la Chiesa rispetti l’autonomia della politica, non relega la propria missione all’ambito del privato, al contrario non può, non deve neanche stare ai margini della costruzione di un mondo migliore, né trascurare di risvegliare le forze spirituali che possano fecondare tutta la vita sociale. La chiesa ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza ed educazione ma si adopera per la promozione dell’uomo e della fraternità universale. Io penso che questo sia anche lo spirito della missione che le è stata affidata da papa Francesco per avviare dialogo di pace in tutti i viaggi che lei ha fatto. La mia domanda è: con quale speranza, con quali preoccupazioni vive questa sua missione affidata dal santo Padre?
Zuppi. Dunque la piccolissima cosa, non è per non rispondere, c’è sempre un riflesso scolastico in ognuno di noi, almeno in me, per cui ognuno di noi allarga, …quello che abbiamo ascoltato anche prima dell’amicizia sociale è costruzione di pace, è veramente liberare da tanta rabbia, da tanto odio, da tanto individualismo ed è costruzione di pace, per questo credo che questo discorso dell’amicizia sociale che nella Fratelli tutti, che è una grande visione di pace, pensiamo siamo all’inizio, o meglio, raccoglie tanti sogni della generazione che ci ha preceduto e che ci ha consegnato dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, il desiderio, gli strumenti anche per un modo di pace, i valori di questo, no? Mi sembra che papa Francesco ce la rilanci con un grande coinvolgimento di tutti e anche con un senso che altrimenti non c’è futuro. Quindi la Laudato sì per la casa comune, perché altrimenti non c’è più l’uomo perché non ce la fa più a vivere, e questa casa che però non è una casa di estranei, di soci di diversi gruppi, etnie, ma Fratelli tutti. Ecco, riprenderei il termine dello struggimento: cioè papa Francesco ci chiede di non abituarci alla guerra. A me, penso, credo che a tanti, ha commosso la commozione di papa Francesco, l’8 dicembre a piazza di Spagna, l’Immacolata, tradizionalmente, quando con tutto lo struggimento di far proprio il dolore del popolo ucraino della sofferenza del popolo ucraino colpito dalla guerra, vi ricordate quando non riusciva più ad andare avanti: dobbiamo continuare ad avere quello stesso struggimento, perché ogni giorno che passa tante persone che muoiono, è un odio che diventa ancora più profondo, è un inquinamento che diventa ancora più insopportabile in tutto l’ambiente perché poi non è mai soltanto…è davvero una guerra mondiale a pezzi, si manifesta in maniera evidente il rischio che appaia anche proprio una guerra mondiale che coinvolge tanti. La missione nasce da questo. Non c’è il piano così, qualche volta, forse anche per un’attesa, qualche volta così anche con…, invece, vogliamo vedere, vediamo un po’ quanto sono bravi, povero papa Francesco: ci insegna tantissimo a struggerci per la pace, a non cercare tutti quanti i modi. Era questo: spingere e trovare quello che può essere utile, ascoltare, manifestare la vicinanza, vedere gli spazi che possono favorire una composizione. Una piccolissima cosa su questo: pace non significa tradimento, mi spiego, la pace richiede la giustizia e richiede la sicurezza, cioè non ci può essere una pace ingiusta. Anche perché sarebbe la premessa per una continuazione dei conflitti. Deve essere una pace giusta e non dimentichiamo ovviamente che c’è un aggressore e un aggredito e deve essere una pace sicura cioè che possa permettere alle persone di guardare con speranza al futuro, poi certamente la sicurezza richiede sempre il coinvolgimento di tutti. Mai dare per scontato davvero se vuoi la pace, prepara la pace e questo è il grande impegno che dobbiamo con consapevolezza e responsabilità cercare. C’è questa attenzione per la parte umanitaria, quindi, bambini ucraini che sono in Russia, provare a capire cosa si può fare e anche il ritorno di chi deve ritornare nelle proprie famiglie, nelle proprie case. Di sicuro questo…i frutti…La pace è una cosa, … purtroppo la guerra lacera con una profondità e rapidità, ma la guerra è sempre una preparazione, è sempre un terreno di cultura. È sempre una gestione, non dobbiamo mai dimenticare, sicuramente questo ci richiede e richiederà anche la capacità di mettere insieme tanti soggetti che possano spingere per trovare la pace e personalmente la tua domanda, Bernard, come vivo questo: lo vivo con, diciamo così, con una grande consapevolezza di quanta gente prega per la pace e devo dire che questo mi dà una, per certi versi una responsabilità ancora di più e ci dà a tutti noi, perché credo che c’è una responsabilità che ci coinvolge tutti quanti, ma anche il senso di una grande invocazione che ci spinge, ci deve spingere, ci spingerà anche nelle settimane prossime, nei mesi prossimi se serve a trovare la via della pace a rispondere a quel vero desiderio di tutti che è quello di liberarci della violenza e di fare tesoro di questa pandemia perché finalmente si possa non combattere la guerra e immaginare un mondo senza guerra. Non è una ingenuità: ma come, con quello che succede, anzi, con la tentazione anzi del riarmo, ma a maggior ragione, come nella pandemia del covid dobbiamo far tesoro di questo, dobbiamo cercare tutti gli strumenti che possano comporre i conflitti, perché il dialogo non è tradire le ragioni, non è accettare la pace ingiusta, ma trovare una pace giusta e sicura, ma non con le armi, ma con il dialogo. E questo penso che sia davvero indispensabile per questa tragica guerra in Ucraina e in tutti quanti tanti pezzi della guerra mondiale.
Scholz. Grazie, grazie Eminenza. Mi permetto solo di aggiungere che in questo Meeting ci saranno diversi incontri che parleranno dell’accoglienza dei rifugiati, che rifletteranno sulla fragilità e sulla possibilità di una rinascita e di una democrazia pacifica non solo in Europa ma anche in altri paesi e quindi cerchiamo di riflettere insieme anche sulle ragioni dalle quali può nascere l’inimicizia, ma anche soprattutto, da dove possono rinascere luoghi di pace e di pacificazione, perché le cause sono le prime questioni che riguardano l’inimicizia, la guerra e su questo incide ognuno di noi e a maggior ragione sono grato delle testimonianze che abbiamo sentito perché documentano che l’impegno di ognuno lascia una traccia per sempre nelle persone che incontro in un modo o nell’altro e abbiamo visto come questo incide in un modo davvero straordinario nella vita di molti giovani. Quindi ringrazio molto Regina De Albertis, Alberto Bonfanti, Vittorio Bosio e Dario Odifreddi, ringrazio sua Eminenza e le assicuriamo la nostra preghiera. Bene. Grazie a voi tutti per l’attenzione e buon Meeting.