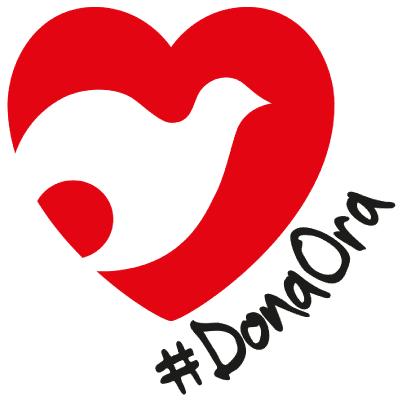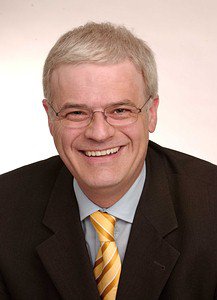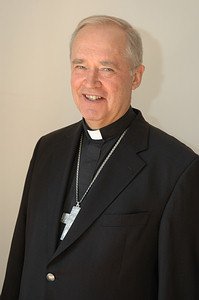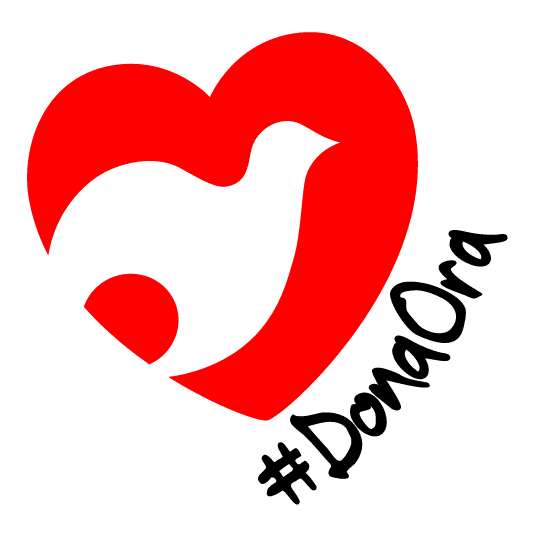Chi siamo
FONDAZIONI PER UN MONDO CHE CAMBIA
La fondazione per un mondo che cambia
Partecipano: Christoph Böhr, Esperto di Scienze Politiche e Direttore della Commissione Valori della Christlich Demokratische Union Deutschlands (Unione Cristiano Democratica tedesca); Rocco Buttiglione, Vice Presidente della Camera dei Deputati; S. Em. Card. Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Sergio Luciano, Giornalista.
SERGIO LUCIANO:
Buonasera a tutti e benvenuti. Cominciamo senz’altro questo nostro incontro, un titolo asciutto che contiene tanto: Le fondazioni per un mondo che cambia. Io credo che abbiamo l’opportunità di avere su questo tavolo delle persone che potranno darci un contributo molto denso. Senza giri di parole o presentazioni, comincerei senz’altro col chiedere ai nostri interlocutori un primo giro di interventi sul tema, sul ruolo delle fondazioni in questo momento sociale che ne ha bisogno, che ha bisogno di nuovi attori che inverino gli ideali nel sociale. Poi sicuramente ne scaturirà un giro successivo di interventi o di domande o di puntualizzazioni. Comincerei col dare la parola a sua Eminenza il Cardinale Paul Josef Cordes. Prego cardinale.
S. EM. CARD. PAUL JOSEF CORDES:
Grazie, a me piace l’applauso dopo la conferenza, non prima, perché non si sa mai che cosa si dice! Sono molto grato, dopo parecchi anni sono tornato al Meeting e sono impressionato di nuovo dalla vitalità di questa Chiesa in Italia e dal progresso non solo nell’edificio ma anche nella profondità, mi sembra. Vi sono molto grato per l’invito.
Per molti contemporanei, la Chiesa si identifica con l’aiuto alle persone che si trovano nel bisogno e nella miseria. Lo rivela anche una recente indagine svolta dall’istituto di scienze sociali della Chiesa evangelica tedesca (Hannover, Germania) nell’autunno 2006. Quello che percepivano le persone interpellate riguardo alla Chiesa erano le istituzioni che si prendono cura dei bisognosi, dei tossicodipendenti, dei disoccupati e degli ammalati. Uno di questi aconfessionali diceva: “… prendersi cura delle persone, darsi da fare per loro, chi è ancora disposto a farlo? La Chiesa lo fa proprio, si fa carico di tanti problemi, anche per quelli che in un certo qual modo sono già a terra”.
Nei giorni nostri l’amore del prossimo non è contestato dall’opinione pubblica. Non voglio giudicare se è veramente praticato. Ma la teoria è affermata dappertutto nel “primo mondo”. È quasi un elemento della nostra cultura. Nessun insegnamento del Nuovo Testamento si è diffuso così universalmente come la parabola del “buon samaritano”. Oggi il fare del bene è perfino un fattore per migliorare la propria fama (Buffet-Foundation; Bill Gates). Manifestazioni di beneficenza e cene di gala aiutano gli esponenti del mondo economico e gli artisti a farsi un buon nome.
Non vale solo per i paesi dell’ovest! Qualche anno fa, atterrato in uno degli aeroporti del Vietnam comunista, a Saigon, rimasi non poco sorpreso quando vidi un grande cartello recante la scritta “Charity”. Anche le religioni asiatiche si sono abituate a prendersi cura dei bisognosi. In passato ritenevo il Buddismo una religione che non lotta contro le afflizioni, ma che piuttosto rinvia tutti i sofferenti al nirvana, ignorando così dolore e miseria. Finché in seguito, dopo il terremoto a Taiwan (gennaio 2000), mi sono imbattuto in un campo di sfollati finanziato da una monaca buddista per un milione di dollari americani.
Gli storici delle religioni parlano infatti di “neobuddismo” come di una corrente religiosa oggi in voga, perché evidentemente alcune figura guida buddiste hanno appreso dal cristianesimo di dover curare il misero. Anche l’induismo, lasciandosi ispirare dal cristianesimo, ha sviluppato un’etica dell’aiuto al prossimo e, come “neoinduismo”, invita all’amore verso il prossimo (Cfr. H. Bürkle, Heilsuniversalismus, in IKZ 37 (2008) 243-253).
Dovendo la Chiesa portare l’amore di Dio agli uomini, non può che rallegrarsi dell’ampia risonanza del comandamento di Cristo ad amare il prossimo. Si sente animata da altre religioni, ma certamente non sostituita!
Così prosegue potentemente per quella via. Spesso mi vengono fatte domande circa il contributo materiale della Chiesa nel mondo riguardo alla lotta contro la povertà. È sconfinato. È impossibile voler dare delle cifre esatte. Neppure per le istituzioni ufficiali della Chiesa e le organizzazioni ci sono dati attendibili – per non parlare delle iniziative private.
Non per caso, nella cerchia delle organizzazioni di aiuto, la Chiesa è quella che gode della fama migliore a motivo dei costi amministrativi minimi e della sua professionalità. Ed è bene che rimanga così, perché è con la sua opera buona che rimane in piedi o cade la credibilità della sua missione. Così utilizzo come Presidente di Cor unum l’occasione per ringraziare tutti rappresentanti delle agenzie di aiuto per la loro attività, specialmente la Compagnia delle Opere.
D’altro canto dobbiamo anche vegliare a fare sentire come Chiesa la nostra voce nel coro polifonico della gente volenterosa, cioè salvaguardare la nostra identità. In mezzo alle voci chiassose degli altri, in effetti, non può semplicemente sacrificare la propria melodia. Forse la nostra specificità non si vede, nell’azione iniziata e nell’opera compiuta. E’ il nostro spirito che vuole essere diverso da quello della Croce Rossa, dell’UNICEF. Lasciatemi dunque indicare alcune ragioni per la differenza della caritas dalla filantropia, dell’aiuto cristiano dall’umanesimo secolare. La prima Enciclica di Papa Benedetto Deus caritas est mette in ampia luce questo scopo.
Forse interessa l’iter di redazione di tale documento, in cui sono stato coinvolto personalmente.
▫ Cor Unum: Dicastero della Carità del Papa
▫ Sotto Giovanni Paolo II: proposta di un testo sull’attività caritativa della Chiesa cattolica
▫ Malattia del Papa
▫ Nessuna reazione da parte della Segreteria di Stato
▫ Card. Ratzinger. Sottometto nuovamente il documento. Peggioramento dello stato di salute del Papa. La sua drammatica morte nell’aprile 2005.
▫ Elezione di Papa Benedetto – subito dopo – “Che fine ha fatto l’Enciclica?” – “Nel limite del possibile, il tema sarà la carità!”
Il Papa, tuttavia, nella sua redazione del testo, ha capovolto lo schema della mia bozza. Comincia con l’affermazione fondamentale: “Dio è amore”. Così facendo egli afferma la priorità assoluta di “Colui che ci ha amato per primo”.
L’amore di Dio ci viene incontro in modo immeritato, essendosi reso manifesto nella storia della salvezza molto prima di noi. “Dio è l’amore”; c’è lui all’inizio.
Oltre un inno affascinante all’amore divino e umano, il Papa cerca di correggere un grave malinteso nella Chiesa, che oscura la sua natura. È dovuto allo spirito dei tempi. La concezione moderna della vita vi porta quasi necessariamente. Da parte dei teologi viene chiamato “secolarizzazione”, che significa che l’uomo di oggi è tentato di scartare progressivamente gli elementi della fede dalla vita quotidiana.
Certo, ogni atto di carità porta sempre in sé un significato profondo. Anche la qualità tecnica dell’opera caritativa non può venir meno quando vengono messe in risalto fede ed ecclesialità. Il Papa non cessa di sottolineare nella Sua Enciclica che “per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre innanzitutto la competenza professionale” (n.31a). Ma tra gli insider questi requisiti sono oggi certo indiscussi. Non c’è bisogno che vengano difesi.
Il vero pericolo, anzi una minaccia distruttiva, per l’opera della Chiesa sorge invece dalla perdita delle radici nella fede.
Per questo il Papa delinea le categorie di base per la missione diaconale della Chiesa. Dà una base solida al suo pensiero ed alle sue esortazioni. La prima parte, redatta in modo affascinante, mira a dare a tutti quelli che si dedicano all’opera caritativa della Chiesa il giusto orizzonte per le loro attività. Insiste sulla questione di Dio, mai da considerare già risolta e superflua, proprio in quest’epoca secolarizzata. Detto teologicamente: Si deve legare la visione ecclesiocentrica ad una visione cristocentrica; legare lo sguardo sugli indigenti allo sguardo sul Salvatore.
Purtroppo non è possibile soffermarmi su questa Enciclica. Posso soltanto raccomandare a coloro che vogliono comprendere meglio il pensiero del Papa di leggere nuovamente tale insegnamento. Si tratta di una “magna carta” di cosa vuol dire essere cristiano e un brillante chiarimento della parola “amore” che oggi viene così spesso sciupata.
Mette al centro del suo pensiero Gesù e il suo doppio comandamento: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente… Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22, 37-39).
Esprimendosi in questo modo, il Signore poteva contare sull’alta stima che l’ambiente giudaico aveva per i due contenuti di questo duplice precetto. È stato Gesù Cristo – come affermano gli specialisti – a collegare ambedue le richieste facendo delle due una sola e a rendere quel comandamento il principio unitario per la condotta del fedele. Amore di Dio e amore del prossimo sono perfettamente paritari, l’uno si collega all’altro. Questo legame indissolubile è l’appello più attuale per le opere di carità della Chiesa.
Come si può pretendere di portare la salvezza agli uomini e donne sofferenti senza imparare da Gesù che l’uomo ha bisogno di una salvezza che va aldilà dei bisogni materiali dell’uomo?
Nel capitolo secondo del Vangelo di Marco viene descritta la guarigione miracolosa di un paralitico ad opera di Gesù. L’uomo, per mano di alcuni conoscenti, viene calato davanti a Gesù sopra un lettuccio attraverso l’apertura del tetto della casa di Pietro (cf. Mc 2, 1-12). Gesù pronuncia la parola risanatrice: “Ti sono rimessi i tuoi peccati”. Così dicendo, Egli mette in luce il fatto che l’esigenza primaria dell’uomo, più e prima di quella materiale, è la guarigione spirituale, poiché proprio il peccato è la causa ultima di tutto il male dell’uomo. Infatti, la radice più profonda della miseria e della sofferenza del malato è la stessa del malessere di ogni uomo: la distanza da Dio e il bisogno di essere perdonati ed amati. La conseguente disputa con gli scribi fa emergere qual è la logica di Gesù: il dono della guarigione è sempre per Lui segno e strumento di un dono ben più grande, che ha a che fare con la salvezza integrale dell’uomo, in tutte le sue dimensioni. Ecco perché anche il cristiano che voglia oggi conformarsi al comportamento di Cristo, non può considerare il bene dell’altro negando un orizzonte di fede e limitandosi all’aiuto puramente mondano.
Nel quarto Vangelo l’agire salvifico di Gesù è messo da subito in relazione con la fede. Per questo non si parla più di “miracoli”, ma di “segni” (semeia). Essi hanno la funzione di sostenere e confermare il messaggio di salvezza annunciato da Gesù e spiegano la sua missione messianica: Di fronte al paralitico di Betzaetà, alla moltitudine affamata nel deserto, del cieco nato, alla tomba di Lazzaro – p.e. – Gesù non vuole eliminare soltanto la sofferenza o i difetti fisici delle persone che incontra. I suoi gesti sono segni che annunciano la salvezza, che viene donata grazie alla fede in Lui: chi assiste ad essi è chiamato a credere, a consegnare se stesso a Lui e a seguirlo.
Questo significato dei “segni” che Gesù opera, non può non generare in noi un’enorme provocazione per la fede. Deve illuminare e plasmare la mente di coloro che, nel nostro tempo, si dedicano quotidianamente alle attività della Chiesa nel soccorso ai bisogni materiali e spirituali dell’uomo.
Signore e Signori, circa cinque anni fa, in occasione di un Congresso in Vaticano, Papa Benedetto ha consegnato al grande pubblico la sua prima Enciclica. Nel presentarla Egli fece una meditazione teologica, con parole di cui solo Lui è capace. Permettetemi di concludere con una citazione del Suo Discorso:
«L’escursione cosmica, in cui Dante nella sua “Divina Commedia” vuole coinvolgere il lettore, finisce davanti alla Luce perenne che è Dio stesso, davanti a quella Luce che al contempo è “l’amor che move il sole e l’altre stelle” (Par. XXXIII, v. 145). Luce e amore sono una sola cosa. Sono la primordiale potenza creatrice che muove l’universo. Se queste parole del Paradiso di Dante lasciano trasparire il pensiero di Aristotele, che vedeva nell’eros la potenza che muove il mondo, lo sguardo di Dante tuttavia scorge una cosa totalmente nuova ed inimmaginabile per il filosofo greco.
Non soltanto che la Luce eterna si presenta in tre cerchi ai quali egli si rivolge con quei densi versi che conosciamo: “O luce eterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi” (Par. XXXIII, vv. 124-126). In realtà, ancora più sconvolgente di questa rivelazione di Dio come cerchio trinitario di conoscenza e amore è la percezione di un volto umano – il volto di Gesù Cristo – che a Dante appare nel cerchio centrale della Luce. Dio, Luce infinita il cui mistero incommensurabile il filosofo greco aveva intuito, questo Dio ha un volto umano e – possiamo aggiungere – un cuore umano. [In questa visione di Dante si mostra, da una parte, la continuità tra la fede cristiana in Dio e la ricerca sviluppata dalla ragione e dal mondo delle religioni; al contempo, però, appare anche la novità che supera ogni ricerca umana – la novità che solo Dio stesso poteva rivelarci: la novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto umano, anzi ad assumere carne e sangue, l’intero essere umano.] L’eros di Dio non è soltanto una forza cosmica primordiale; è amore che ha creato l’uomo e si china verso di lui, come si è chinato il buon Samaritano verso l’uomo ferito e derubato, giacente al margine della strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico».
SERGIO LUCIANO:
eccome se c’è stato l’applauso dopo. Do senz’altro la parola a Christoph Böhr, Esperto di Scienze Politiche e Direttore della Commissione Valori della Christlich Demokratische Union Deutschlands.
CHRISTOPH BÖHR:
Grazie a lei. Volevo fare qualche osservazione. Non solo il mondo nel quale viviamo, ma stanno cambiando molto anche le società nelle quali viviamo. In merito a questi cambiamenti succede anche che le nostre società non sono più disposte ad ascoltare quanto dettano le autorità. Una società che non riconosce l’autorità come può funzionare? Penso però anche che le nostre società nei prossimi anni continueranno ad andare di più, sempre di più in questa direzione. Già oggi si tratta di società nelle quali ognuno può dire ciò che vuole, e tra l’altro si sentono dire anche parecchie sciocchezze. E si può pensare molto facilmente che siano delle società che cadono nel relativismo e seguono il relativismo. Comunque io non ci credo, questo tanto per chiarire, e sono anche convinto che non ci sia un gran motivo per essere pessimisti dopo tutto. Il nostro primo compito, secondo me, è quello di comprendere come sono composte queste società al loro interno e ci si rende subito conto che in questa società nella quale noi tutti viviamo – parlo della tedesca, dell’italiana, è indifferente – bene in queste società viene ascoltato solamente colui che parla a voce alta. È chiaro che un incontro come Rimini Meeting viene ovviamente percepito dall’opinione pubblica, viene ascoltato; magari delle altre volte si incontrano delle persone che non vengono ascoltate dall’opinione pubblica. Quindi dicevo, primo, bisogna parlare ad alta voce, forte; in secondo luogo bisogna parlare in modo chiaro. Bisogna sapere ciò che si vuole e soprattutto bisogna avere una convinzione in questa società se si vuole che l’opinione pubblica accolga e comprenda ciò che viene detto. Ad esempio per noi cristiani spero che ci saranno tante opportunità per cambiare, per una svolta, molte occasioni per far sentire ad alta voce la nostra convinzione, le nostre idee, anziché tirarci indietro con timore, esattamente quello che ho visto qui oggi. La politica ovviamente si lascia trascinare in questa nostra società dall’opinione pubblica e la società trova che sia giusto così, è chiaro che vuole determinare la via, il come andare avanti ed è chiaro che c’è anche un senso per le persone che vogliono vivere questa loro convinzione. Si possono criticare tante cose a queste nostre società moderne, però in esse c’è un nuovo senso di autenticità, genuinità, e questo per noi vuol dire che dobbiamo veramente credere a ciò che diciamo. La dottrina o l’insegnamento al convincimento della nostra società non è semplicemente una dimostrazione della sua varietà e del suo decadimento, ma al contempo ci offre grosse, grosse opportunità. E adesso passo alla mia seconda osservazione. Se è vero che le società vogliono autodeterminarsi e scegliere la strada in cui andare anziché percorrere quella strada che viene loro indicata da certe autorità, allora la questione diventa oggi ancora significativa e parlo della questione che riguarda in quale società noi in futuro vorremmo vivere. E questo è un quesito che non vale solo per i grandi gruppi nell’interno della nostra società, le chiese, le associazioni, i partiti, bensì è una questione, una domanda che si pone anche a ognuno di noi individualmente. Quindi riflettere sul futuro e saper riflettere su in quale società vorremmo vivere in futuro; questo secondo me sarà sempre di più la questione principale, importante. In realtà lo è sempre stata importante questa questione. Adesso la differenza rispetto a prima però qual è? È che questa domanda adesso si pone ad ognuno di noi singoli. Se ricordate come avveniva la comunicazione venti o trent’anni fa, i giornali parlavano dei pareri, delle organizzazioni, di opinioni, parlavano di associazioni, di partiti, di parlamenti eccetera, oggi lo fanno in misura molto minore; oggi si va in internet e vi rendete conto che sui temi più importanti, nel giro di poche ore, migliaia di persone e anche più stanno partecipando ad un particolare dibattito, e qualunque opinione venga esternata lì in internet fa parte di questo processo della strutturazione di un opinione nella nostra società. È chiaro che dipende anche da altre opinioni e parte da opinioni che già c’erano e si ripercuote su opinioni che verranno. E qual è il nostro compito in questo processo? Secondo me almeno il nostro compito è di lottare per una società che sia al servizio della persona, o per dirlo anche in altre parole, che segua un’immagine di persona, della persona che si possa descrivere al meglio con l’immagine della persona umana di tipo cristiano. Non però ovviamente un possesso esclusivo di Cristo. Io penso che anche nelle società laiche, secolari si possa, su questo trovare l’appoggio della maggioranza. Si tratta di un’immagine di persona che pone al centro la dignità dell’uomo e che in qualunque questione pone sempre al centro la tutela della dignità dell’uomo. E chiarisco con un unico esempio, un esempio che forse vi stupirà, perché non parlo della dimensione spirituale della nostra società, bensì della dimensione materiale, sulla quale penso che proprio su questo punto di cui sto per parlare dovremmo urgentemente trovare una risposta. Mi sento tra l’altro incoraggiato dall’affrontare questa questione grazie a una mostra, a una esposizione che ho visto qui proprio oggi, una mostra sulla genesi e la storia della crisi finanziaria che contiene anche delle proposte per uscire da questa crisi. L’analisi che viene seguita in questa mostra si può riassumere in una semplice frase: questa crisi finanziaria è la conseguenza di un’antropologia sbagliata, e peraltro condivido pienamente questa opinione anche mia. Quindi faccio adesso un’osservazione sulle conseguenze della crisi finanziaria per quanto riguarda noi come cristiani. Dicevo che l’autodeterminazione dell’uomo è una cosa che va tutelata, la dignità dell’uomo, come la comprendiamo noi in questa immagine umana che abbiamo, a questa autodeterminazione appartiene anche l’autodeterminazione materiale e questo significa per me, lo dico in una breve frase, che ogni persona deve lavorare con le proprie mani, attraverso le proprie mani per autodeterminare la propria vita. Siamo però molto lontani da questa realtà purtroppo, sia in Europa che in altri luoghi del mondo. Molte persone nella nostra società a questo proposito non riescono a condurre una vita autodeterminata. Quindi per quanto riguarda le mie richieste, io vorrei che ci fosse una nuova economia politica; sono tedesco, vengo dalla Germania come sapete e da giovane avevo imparato le teoria dell’economia sociale di mercato. Il fondatore di questa teoria, Ludwig Erhard, ne ha riassunto il senso in tre parole: benessere per tutti, e intendeva alla lettera questa parola, benessere, star bene e non come immagine o come metafora, proprio letteralmente il benessere in senso letterale e attenzione, parlava un economista, non parlava un poeta o un filosofo. Questo significa che ci dobbiamo congedare, che dobbiamo distaccarci da un dogma puramente marxista che sosteneva che il lavoro avrebbe alienato le persone e dobbiamo passare a una dottrina del lavoro simile a quella di Karol Wojtyla, da tutti ricordato come pontefice, il quale aveva scritto che l’uomo si compie nel suo lavoro, che l’uomo si deve ritrovare nel proprio lavoro e che l’uomo diventa più grande nel suo lavoro. In una sua Enciclica c’è una frase bellissima: “grazie al suo lavoro l’uomo diventa ancora più uomo”. Trovo che questa potrebbe essere la massima, lo slogan di una nuova politica economica che creerebbe i presupposti per l’uomo per condurre una vita autodeterminata anche dal punto di vista materiale. E questa possibilità ce l’abbiamo grazie alle condizioni di cui parlavo all’inizio. Quindi staccarci da un pensiero, da una impostazione dove valgono i redditi da capitale, dove questi aumentano, sempre di più il profitto, e invece vale sempre meno quello che viene generato col lavoro. Adesso passo al mio ultimo punto, quindi come strutturare la nostra società. Questo compito serve a contribuire a un nuovo equilibrio, e la crisi recente ci ha insegnato, ha attirato l’attenzione sul fatto che la nostra vita in società, la nostra economia non sono più in equilibrio. E’ su questo punto che noi veniamo chiamati in causa come cristiani, secondo me e vi ringrazio.
ROCCO BUTTIGLIONE:
Io voglio prima di tutto salutare il popolo del Meeting. Qui si sente, qui si sente che è vivo lo spirito di don Giussani, che è anche lo spirito della mia giovinezza, e lo spirito della giovinezza perenne della Chiesa. Venire al Meeting allora significa tornare giovani, o meglio ancora restare giovani. Grazie. Quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi è il cuore. Badate che non è una frase romantica, almeno come lo spiegava don Giussani, è tutt’altro che romantico. L’uomo desidera naturalmente cose grandi. Il mondo classico, il mondo greco ha condannato questa pretesa dell’uomo; ha visto nel desiderio di cose grandi la redice di ogni male. Se c’è qualcuno di voi che insegna greco lo può confermare. Come si chiama questo desiderio del cuore? Hybris. La hybris è ciò che ti porta a smarginare, ciò che ti porta a fare il male del tuo vicino, perché io voglio cose grandi, per esempio voglio la tua donna perché la mia non mi basta; voglio il tuo denaro, voglio il potere. C’è nel cuore che desidera cose grandi un elemento demoniaco. L’uomo non si rassegna a vivere in un mondo finito. Un mondo di cose soltanto finite è un mondo che l’uomo non riesce ad accettare come fatto per sé e allora la trasgressione. Cosa cercano i nostri giovani? La trasgressione. Perché? Perché non si rassegnano al mondo fatto di cose finite che noi proponiamo loro. Il loro cuore è più grande e il primo modo in cui si mostra la grandezza del cuore è opponendosi, opponendosi ai genitori, opponendosi alla società, opponendosi al mondo, opponendosi a Dio, opponendosi a tutto, perché il cuore ha una natura che lo porta a desiderare cose grandi. Infatti voi vedete che nella storia le cose grandi spesso sono associate con grandi catastrofi. I grandi conquistatori, Cesare, Alessandro, uomini che hanno fatto cose grandi distruggendone di molto più grandi, portando con sé una valanga di distruzioni e di lutti. Cosa riscatta il cuore? Ah, ben inteso, questa cosa che diceva don Giussani, quelli di voi che si occupano di filosofia la possono trovare scritta in un grande filosofo tedesco; abbiamo qui due illustri ospiti tedeschi quindi citiamo un grande filosofo tedesco Giorgio Guglielmo Federico Hegel, il capitolo della Fenomenologia dello Spirito che porta il titolo: “la libertà assoluta e il terrore”. L’uomo che cerca la libertà assoluta deve imporre con il terrore la propria misura a tutti gli altri, perché altrimenti la sua libertà non sarebbe assoluta. La libertà assoluta è la libertà di fare quello che voglio io, quindi di sottomettere tutti gli altri al mio volere. Cosa riscatta il cuore? Cosa salva l’uomo dalla condizione tragica? La tragedia greca è quella che mette in scena proprio questo fatto, che il cuore desidera ma l’uomo che segue il desiderio del cuore va in rovina. Salva il desiderio del cuore l’incontro con una realtà che è la risposta adeguata a quel desiderio. Il cuore che non trova soddisfazione in nessuna cosa finita trova soddisfazione in un uomo, Gesù Cristo che è la presenza di Dio nella mia storia, nella storia dell’uomo, nella vita dell’umanità. È lì che il desiderio del cuore trova una risposta che lo riempie e che gli è adeguata, ed è una risposta che c’è adesso ma non c’è ancora; c’è come presenza vera, ma non c’è nella chiarezza del compimento definitivo; è una presenza che è contemporaneamente un’attesa e una speranza. Io ricordo che don Giussani ci faceva leggere, quando noi eravamo ragazzi, un libretto, che spero si legga ancora, che si intitolava Miguel Manara. Era la storia di don Giovanni. Pare che don Giovanni abbia un archetipo storico reale, che era un tal Miguel Manara, grande seduttore, che è morto alla fine monaco certosino e in odore di santità; è in corso la causa di beatificazione. E qual è la storia di Miguel? Che alla fine incontra una donna che è la prima che gli dice di no, cioè è la prima che gli dice di sì davvero, perché è la prima che è in grado di incontrare il fondo della sua anima. Si chiama Geronima, cambia vita, la sposa e lei muore. E quando lei muore è la disperazione. Lui bussa alla porta del convento perché pensa che la vita sia finita e trova un padre guardiano che gli spiega che la vita non è finita, la vita comincia adesso, perché la penitenza non è il rinunciare alla vita; la penitenza è imparare il cammino dell’amore che è un cammino lento e sicuro, un cammino che deve arrivare lontano. Chi deve arrivare lontano non si mette a correre, sa che deve mantenere un passo che sia compatibile con il fiato che ha nei polmoni. E allora il desiderio di cose grandi, il desiderio della grandezza, che ha trovato quello che lo riempie, diventa desiderio di fare cose grandi nel mondo, ma realisticamente, rispettando la libertà dell’altro; non con il metodo della violenza ma con il metodo della carità. Io credo che il Meeting di quest’anno ci ripropone questo tema fondamentale, quello che ha detto monsignor Cordes sulla Caritas in veritate: il metodo della carità, che solo quella Presenza rende possibile, altrimenti non è possibile perché il cuore non lo accetta. Un cuore che non ha incontrato ciò che lo riempie non è poi capace di essere clemente e misericordioso con la realtà; il marito non è capace di essere misericordioso con la moglie e la moglie col marito, il padre con i figli e i figli con il padre, i governanti con i governati e viceversa. C’è un altro dramma, questo non lo leggeva don Giussani, lo leggeva Karol Wojtyla; si chiama la Non Divina Commedia di Zygmunt Krasinski. E in questo dramma c’è il conte Heinrich che ama la vergine, che è la presenza piena, pura del femminile e per questo odia la moglie. E allora la vergine cambia volto e mostra il volto del diavolo, perché l’incontro vero è quello che rende misericordiosi con i piccoli, con i poveri, che riconcilia con la realtà umana. Guardate, questo desiderio diventa allora storia, e storia individuale e storia di una famiglia ma è anche la storia di un popolo. Nella storia del popolo italiano, nella storia del popolo europeo, questo è diventato storia per esempio con un grande movimento cattolico, che ha attraversato al storia del paese e ha cambiato la faccia dell’Italia, come in Germania ha cambiato la faccia della Germania, come ha cambiato la faccia dell’Europa. Un movimento che allora ha creato opere di carità, ma anche opere culturali, ma anche opere economiche, ma anche banche, che ha cambiato la vita degli uomini. Dopo la prima guerra mondiale, anzi no, diciamo a un certo punto, questo movimento che cambiava la vita dell’uomo perché non era ideologico, astratto, non imponeva alla realtà la misura di un desiderio privo di misericordia, ma si chinava con misericordia sulla realtà, così come è, senza disprezzo, proprio perché aveva il cuore pieno, questo movimento arriva ad un limite, incontra il problema della politica. Che facciamo con la politica? Perché una realtà che investe tutta la vita non può non investire anche la politica. Soprattutto in una società democratica la politica è una dimensione fondamentale della vita. Noi siamo responsabili di quello che si fa, di quello che i nostri governanti fanno in nostro nome, essi portano la nostra responsabilità. E anche se noi non ci occupiamo di politica, la politica si occuperà di noi e ci metterà sulle spalle responsabilità che non avremmo voluto portare, che non avremmo voluto avere. Don Luigi Sturzo allora disse: io faccio un partito; lo faccio non per mandato dei vescovi, non col vescovo che va avanti portando l’ostensorio e il popolo cristiano che o segue; no, lo faccio per mandato dei miei elettori, di quelli che si riconoscono in questo progetto; ma lo faccio per dare un’espressione politica organica a un popolo cristiano. Sturzo in Italia arrivò tardi; lo avesse fatto quindici anni prima probabilmente non avremmo avuto la prima guerra mondiale e l’Italia oggi sarebbe un paese totalmente diverso. Ma più o meno nello stesso periodo cose del genere succedevano in Germania, in Francia, in Belgio, in Olanda, in altri paesi. Nasce il movimento democratico cristiano a livello europeo, e come tutti i movimenti questo movimento, che ha il suo massimo di forza dopo la seconda guerra mondiale, tende a diventare istituzione, progressivamente si fossilizza. A un certo punto passa l’idea: viviamo in una società secolarizzata e allora siccome la società è secolarizzata anche noi ci dobbiamo secolarizzare; se vogliamo avere tanti voti dobbiamo secolarizzarci, dobbiamo diventare liberali. Allora erano gli anni ’80, gli anni in cui sembrava che ad ogni domanda la risposta fosse: più mercato; ad ogni cosa la risposta era: più mercato. Io penso che quella risposta fosse sbagliata. Qualche anno fa, un paio di anni fa, sono stato in Germania, in Baviera, ho fatto una relazione che ha avuto una certa eco. Per dire, guardate, a partire dagli anni ’80, dalla metà degli anni ’80, sta cambiando qualcosa in Europa. Noi tutti viviamo con l’idea che viviamo in un’epoca della secolarizzazione. L’Europa si secolarizza, si secolarizza, si secolarizza, si secolarizza sempre di più e alla fine il cristianesimo scomparirà. Non è così. A partire dalla metà degli anni ’80 inizia in Europa una fase nuova, una fase di nuova evangelizzazione, cresce il numero di quelli che credono in Dio. L’avete mai immaginato? I giornali non lo dicono, però è così. Le statistiche dicono che il numero di quelli che credono in Dio aumenta molto, non poco, molto. Cresce il numero di quelli che vanno a messa la domenica, non molto, poco; e questo è un problema perché emerge una nuova categoria che prima non c’era. Oggi più o meno un terzo degli italiani vanno a messa tutte le domeniche; il 40% grossomodo non vanno a messa tutte le domeniche, vanno a messa ogni tanto, però si considerano credenti, però non vanno a messa. Un 16% si dichiara cattolico non praticante; un 16% dichiara di non avere un’appartenenza religiosa oppure di avere un’altra appartenenza religiosa. C’è un popolo cristiano, questo popolo cristiano è attivo, fa il Meeting; non fa solo il Meeting, ha fatto Family Day, vi ricordate il Family Day, una cosa meravigliosa, un popolo in piazza con una forza che ha la capacità di sconvolgere la vita della società. Fa il volontariato. Chi fa il volontariato in Italia? E come sussisterebbe il paese senza questi milioni di persone che fanno il lavoro volontario, e non sono mica tutti censiti; quelli censiti sono solo una parte di quelli che ci sono? C’è un popolo, questo popolo però non ha una rappresentanza politica. Parlo per l’Italia, ma parlo per l’Europa in generale, perché negli altri paese europei i fenomeni sono simili, in Italia più accentuati che altrove, dobbiamo riconoscerlo, più accentuati almeno che nella maggior parte degli altri paesi europei. E noi vediamo che cresce una distanza tra il movimento democratico cristiano e questo popolo nuovo. Io sto lavorando con alcuni amici a costruire un ponte, e il perno di questo ponte sono le grandi fondazioni. Secondo la Costituzione tedesca, non secondo la Costituzione italiana, i partiti hanno anche una funzione di educare alla democrazia e lo fanno non direttamente, ma tramite grandi fondazioni le quali hanno un punto di riferimento ideale. In Germania, la Fondazione Adenauer come punto di riferimento ha la dottrina sociale cristiana, anzi l’immagine cristiana dell’uomo. Io credo che bisogna lavorare per colmare questo iato, perché noi in Italia, nel nostro provincialismo, pensiamo che l’Italia sia molto peggio del resto dell’Europa. Non è così, forse siamo un po’ peggio, forse, ma non molto peggio. In tutta Europa c’è una crisi drammatica della democrazia, perché non c’è più un’alimentazione che venga dalla società di gente che crede in qualcosa e che sia quindi in grado di guidare la società non secondo la logica del proprio interesse particolare. Chi è che fa politica oggi non per i soldi e per il potere? E chi è che educa a far politica non per i soldi e non per il potere? Chi è che porta in politica una generazione, anche di vecchietti, non necessariamente di giovani, un popolo nuovo che ha un’idea di bene comune? E allora l’idea di bene comune in politica non si afferma perché è marcio il reclutamento. Dice Machiavelli, che di politica ne capiva, che per avere un buon esercito bisogna che questo esercito sia fatto da gente che milita perché ama la propria patria e la serva. Gli eserciti di mercenari non vanno bene, e oggi la politica la fanno eserciti di mercenari. C’è un grande lavoro da fare perché il desiderio del cuore, che c’è in tutti, ritrovi la propria misura. Ma è un lavoro che deve essere fatto comprendendo se stessi come parte di un popolo. Dove si è perso il vecchio movimento democratico cristiano? Si è perso perché si è chiuso su se stesso e ha dimenticato che o parlava per un popolo, ed era parte di un popolo, o si sarebbe necessariamente isterilito; magari avrebbe tenuto il potere ma si sarebbe isterilito come capacità di esprimere il desiderio del cuore. Questo chiede, lo diceva prima Christoph Böhr, anche una nuova economia. È sbagliata l’idea che la salute economica la misurano i soldi. Non si fa economia per i soldi, per il profitto. Si fa economia per vivere, perché l’uomo viva; certo, per vivere servono anche i soldi, questo non c’è dubbio; ma non è la finalità ultima. E cosa accade? Che quando si pensa che fare i soldi sia tutto, allora l’economia si disfa e tutti quanti rimaniamo sotto le macerie. Cosa è stata questa crisi, da dove nasce? Dalla pretesa di fare i soldi con i soldi. E no, i soldi, le banche servono per investire sul lavoro, per pagare i salari, per creare occupazione, per produrre qualcosa, per venderlo e poi lì c’è il profitto, che è una cosa giusta e buona quando è il risultato del lavoro. Si è voluto il profitto senza lavoro e alla fine si è rimasti senza lavoro e senza profitto. Allora, c’è da costruire, partendo da dove? Partendo da un desiderio grande del cuore, un desiderio grande del cuore che abbia la misura della storia, del tempo, della fatica, che non abbia la pretesa violenta di catturare tutto in una volta. Una storia che comunque va avanti. Dice T.S. Eliot: “il regno di Dio non è di questo mondo. Sì, ma è la misura che deve orientare i vostri passi per costruire il bene anche in questo mondo”, per costruire, diceva Giovanni Paolo II proprio qui a Rimini quando è venuto, forme nuove e più umane di vita per l’uomo. Grazie.
SERGIO LUCIANO:
Grazie professor Buttiglione. Vorremo sentire l’anima nella politica più spesso e non la sentiamo orami quasi più qui in Italia. E passo la parola per un intervento che, visto anche l’orologio, sarà verosimilmente anche un po’ conclusivo, a Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Prego.
GIORGIO VITTADINI:
Prendo spunto dalle ultime parole che diceva Rocco e dalla mostra che abbiamo fatto Dentro la crisi, oltre la crisi. Abbiamo fatto questa mostra che vedete nel meeting, in cui cerchiamo di descrivere quello che è successo esattamente partendo da due presupposti, uno negativo, l’altro positivo. Negativo. Non è vero che è una crisi solo tecnica, non è vero che la crisi della nostra economia è semplicemente un problema di meccanismi, come del resto gli editorialisti hanno cominciato già a scrivere; quelli che hanno teorizzato questo sistema adesso dicono che è solo colpa della politica; ci diceva Passera l’altro giorno: guardate che hanno ricominciato a fare la stessa cosa, come se non fosse successo niente. Noi mettiamo in luce, cercando di documentare lì, che c’è un problema antropologico. Io direi, riprendendo anche quello che dicevano prima i nostri interlocutori, che siamo alla fine dell’epoca moderna, un’epoca in cui l’economia e la politica nascevano da una concezione dell’uomo seicentesca. Sostanzialmente l’idea della negatività. L’uomo è egoismo, lo sappiamo benissimo, lo abbiamo letto, lo abbiamo studiato, sul piano politico Hobbes, homo hominis lupus, l’egoismo dell’uomo, quindi ci vuole uno stato che controlli, ai tempi di allora come Leviatano, l’ordine; andando avanti nei secoli, se leggete certi saggi del sociologo Donati lo vedete molto bene, oggi nel campo del welfare e dell’economia. Siccome l’uomo è cattivo noi dobbiamo controllarlo e quindi tutto ciò che è risposta ai bisogni dell’uomo in termini di educazione, in termini di salute, in termini di assistenza, deve farlo la politica, deve farlo lo stato, perché se lo fa il privato, anche il privato sociale di cui parlava Rocco, questo è cattivo. Abbiamo avuto e sarebbero da leggere certi documenti dell’unità d’Italia come non si fa, nel periodo di Crispi, come la teorizzazione di questo: l’assistenza è solo statale, la Chiesa la fa per sé, bisogna rubargli tutti i beni, l’assistenza non possono farla le realtà sociali, il movimento sociale cattolico, il movimento operaio, perché fanno il male. Figlie di quella concezione – l’uomo è egoismo – le organizzazioni che nascono sono organizzazioni corporative, l’appartenenza è un male. Lo risentiamo in certe forze politiche anche oggi, di destra, di sinistra; qualunque cosa si intrometta tra l’io e lo stato è male, perché lo stato impedisce l’egoismo. Quindi il sistema del welfare, il sistema politico che deve controllare le pulsioni negative dell’uomo, egoistiche. Ma, ed è interessante perché ci sono certi commentatori anche di sinistra che sono così, se il welfare deve essere statale, magicamente invece l’economia deve essere sfrenata, libera, senza mezzi. Perché? Perché lo stesso uomo egoista che deve essere controllato all’interno dell’assistenza, se lasciato libero di muoversi porta il bene attraverso una mano invisibile. L’insieme dei meccanismi egoisti di ognuno porta magicamente, attraverso il mercato, al benessere collettivo. E’ una certa lettura di Smith, che ripete: non è la benevolenza del birraio che porta il bene; i meccanismi di mercato sono tali per cui la concorrenza va intesa come spietato far fuori l’altro, come darwinismo. Lo disse qui il cardinal Schönborn tre anni fa: chissà perché il darwinismo, che ha dei limiti anche in termini scientifici, all’interno di un’unica lettura ideologica dell’evoluzione, diventa lettura dello sviluppo economico. Io costruisco una concorrenza dove devo far fuori l’altro, devo distruggere l’altro, perché inevitabilmente è solo l’egoismo che porta al bene comune. Ora, questa lettura, che è una lettura filosofica, porta a una concezione che si ripete anche nell’università, anche dopo la crisi. Cos’è la razionalità dell’uomo? La razionalità dell’uomo è il raggiungimento dell’ottimo individuale a qualunque costo, perché quest’ottimo individuale sarà il bene per tutta la società. Questa è la razionalità, è irrazionale l’uomo che non offre tutte queste cose.
Questa cosa è al principio di una certa lettura liberista dello sviluppo economico, e dico che è interessante vedere questi editorialisti, che volevano nel 2005 farci diventare tutti come il sistema finanziario, che sono liberisti nell’economia e statalisti nel welfare e nell’educazione. Ti dicono: massimo sviluppo dal punto di vista del mercato come egoismo selvaggio e senza regole, però il welfare deve essere statale, l’educazione deve essere statale, proprio perché all’inizio c’è la stessa origine egoistica. Allora, noi abbiamo avuto la realtà che ha clamorosamente smentito questo postulato, su entrambi i punti: è crollato il welfare state; ha avuto dei meriti, ma la pretesa che uno stato, da solo, riesca a rispondere ai bisogni della collettività, è progressivamente esaurito con l’aumento della popolazione, l’aumento della qualità dei servizi richiesti e la diminuzione del flusso delle risorse pubbliche. Per cui, se non nasce niente all’orizzonte, è paradossale che questa visione del welfare state ci lasci scoperti e vada verso una visione americana, non europea con l’idea: Si salvi chi può, io non garantisco a tutti, a tutta la collettività, la possibilità di una assistenza, di una sanità, di una educazione.
Ma anche lì, l’aspetto duale, l’aspetto economico, ha avuto due gravi crisi, una è quella del ’29, da cui è nato il keinesyanesimo, l’intervento dello stato in economia, e l’altra è quella moderna, l’ideologia secondo cui non si dovesse toccare nulla. Ricordatevi anche le grandi privatizzazioni in Italia, fatte su questa teorizzazione, che non è che hanno portato più mercato e più sviluppo, hanno portato più monopolio e più intrallazzo! Hanno buttato via e hanno svenduto: pensate che il Credito Italiano è stato venduto a 1.600 miliardi, vuol dire, per una banca di questo tipo che ha dato vita a Unicredit, niente! Essa è stata regalata a qualche famiglia privata, il bene che la gente e le tasse e lo sviluppo avevan costruito. Ora, questa idea è clamorosamente fallita per la seconda volta, di fronte alla crisi economica, ma noi diciamo, non c’è tempo da approfondire la parte negativa, guardate che non è un caso, è figlio di una concezione, è veramente razionale l’uomo che pensa a se stesso e poi ha bisogno di un Leviatano per questo?
E qui viene la parte positiva, quella sviluppata da mons. Cordes, parlando dell’Enciclica. C’è un’idea di uomo che – io penso anche alle encicliche a cui Rocco a collaborato, di Giovanni Paolo II, già precedenti a questa, la Centesimus annus, – è l’uomo relazionale, l’uomo che è, appunto, parte quinta di questa enciclica, imitazione della Trinità; la Trinità essa stessa è relazione, l’uomo che è immagine di Dio è un’immagine di uomo, guardate, di questo Dio, di questo Dio Trinità, non di qualunque Dio, è relazione, è inizialmente relazione, cioè desiderio; il desiderio è la dinamicità della relazione, è la costruzione di un bene, io costruisco, io mi realizzo col desiderio, siccome sono desiderio d’infinito e l’infinito non ce l’ho, nel rapporto, nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri, io amo per questo, io costruisco per questo; l’uomo originariamente è questo soggetto diverso, soggetto di relazione, costruzione, non ha all’origine l’egoismo.
Cosa fa un uomo di questo tipo quando si pone al centro della vita economica e politica? Costruisce un altro sistema, perché questo uomo ha questo impeto positivo, che spiega molto di più, che non la semplice lettura dell’ottimo individuale-egoistico, lo sviluppo. Qual è l’origine del valore, torniamo a rivedere Smith, qual è l’origine del valore, del valore di scambio? E’ un valore d’uso, è l’uso della realtà, è lo sguardo sulla realtà in funzione di un altro uomo, è l’utilità di qualcosa, che io guardo per questa visione di bellezza. Dice Giussani, lo riportiamo lì, nella mostra: Il desiderio è la scintilla che accende il motore. Poi fa una serie di esempi; è una scintilla, è una costruzione, una voglia di prendere la materia e renderla migliore, dall’inizio. Lo sviluppo moderno, lo sviluppo capitalistico, è nella sua essenza, non nelle sue degenerazioni, protestante, diceva Max Weber, ma è stato smentito clamorosamente. Se andate a leggere i libri di Ronnie Stark, il sociologo americano, voi vedete che lui riporta l’origine di questa creazione di valore, anche moderna, allo spirito medioevale. E’ vero, ci siamo dimenticati il mercante medioevale, la costruzione del valore, la costruzione delle banche, la costruzione di uno sviluppo che è ben prima della Riforma protestante, ma lì innesta anche i limiti: lo sfruttamento dell’uomo fino alla fine, per portare uno sviluppo.
Allora noi abbiamo questa lettura interessante dell’origine del valore, che spiega piccole e medie e grandi imprese, dovunque nel mondo, come nascono, perché un imprenditore nasce. Io faccio sempre un esempio: spiegatemi in questa fase perché un imprenditore dovrebbe, se l’unica logica è l’ottimo individuale, continuare a lavorare invece di vendere tutto e vivere di una rendita, quando non sia fregato dal mercato finanziario, perché deve avere la voglia di costruire, di lavorare, di mettere insieme risorse, di andare ogni mattina, di trovarsi un mercato…, perché? Ma perché la razionalità economica è più larga, e questa è la razionalità della persona, dell’impresa, la razionalità del mettersi insieme, dell’associazionismo, anche nel mondo dell’impresa, come dimostra, come ricordava Rocco, come largamente dice l’Enciclica: il mettersi insieme è un fattore positivo di sviluppo. In tutto il mondo esistono, ma ben da qualche secolo, le Camere di commercio, il mondo associativo, non come mondo corporativo, ma come mondo di sviluppo, di pensiero; il distretto che ha fatto il secondo boom economico italiano è qualcosa di irrazionale, sotto il profilo di quella lettura dell’economia, perché cento imprese che fanno lo stesso affare devono farsi fuori, non sono un fattore di sviluppo per una regione! Mettersi insieme ma fino al mondo finanziario… Solo un accenno: come si vede nella mostra, uno dei punti che ha fatto da detonatore della crisi è stato la crisi di fiducia; la fiducia è venuta meno, ma la fiducia non è un valore che nasce dalla razionalità intesa come il buonismo, la fiducia, se leggete un libro di Giussani, Si può vivere così, viene alla fine di un percorso che nasce dalla fede, dalla speranza, dalla libertà: io mi fido di te, perché confido in te, spero in te, perché io ti considero capace di rispondere a me, dal punto di vista ideale, del fatto che non mi freghi come fornitore, come cliente. Se viene meno questo aspetto, crolla addirittura il sistema finanziario!
Allora, si vuole andare avanti, ma capite che qui, secondo me, siamo all’inizio di un nuovo punto di svolta della storia, un nuovo punto di svolta della storia, perché si tratta di un nuovo punto di svolta antropologica, dove ritorna clamorosamente d’attualità la visione cristiana dell’uomo, della società, la dottrina sociale, che solo vent’anni fa, in certe università cattoliche, si considerava obsoleta. Anche i laici, anche molti laici, oggi vedono in questa visione qualcosa che può leggersi anche in molti paesi del terzo mondo, perché i paesi del terzo mondo non vogliono lo sviluppo di tipo imperialista, non vogliono multinazionali. Sarebbe interessante andare a leggere il sistema cinese, che ha l’armonia come punto che deve, come dire, reggere un sistema. E quindi penso che quello che veniva detto prima dello spazio di mediazione sulla politica, il lavoro sulla politica e le fondazioni abbia dietro anche una grande riflessione epocale, che questo tipo di punto della storia ci pone. Noi siamo all’inizio di un big bang di cui non ci siamo accorti, che molti faranno finta di non vedere, ma un big bang che dice la fine della filosofia moderna sull’uomo. E richiede un ritorno a un uomo, l’uomo di cui hanno parlato questi papi, l’uomo di cui ha parlato don Giussani, l’uomo di cui han parlato molti filosofi e teologi contemporanei, che è finalmente a tutto tondo. Questo uomo dovrà costruire, se vuole, uno sviluppo equilibrato, che non distrugga l’ambiente, ecc. ecc.. Tutte le cose che nell’Enciclica si dicono, tengono conto di questa visione antropologica. Questa è la modernità e il resto è il passato.
SERGIO LUCIANO:
Grazie a tutti. Con questo intervento chiudiamo qui e credo ci sia per tutti noi tantissimo da meditare. Grazie di cuore, anche personalmente, ai nostri
(Trascrizione non rivista dai relatori)