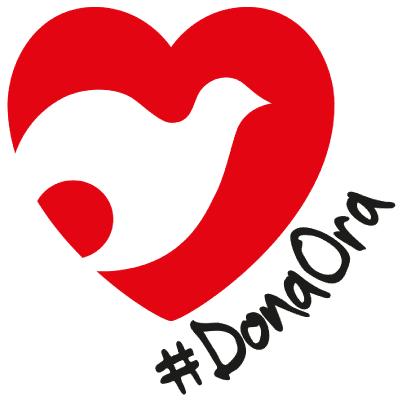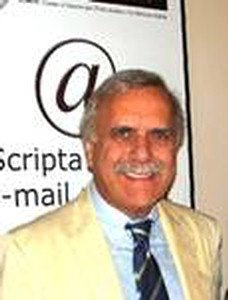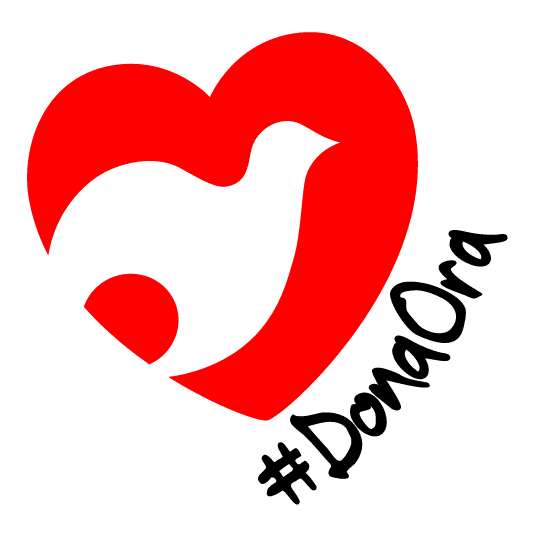Chi siamo
FONDAZIONI PER UN MONDO CHE CAMBIA
Partecipano: Tommaso Agasisti, Ricercatore nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale all’Università Politecnico di Milano; Carlo Lauro, Docente di Statistica all’Università Federico II di Napoli e Responsabile Area Ricerche Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Dario Chiesa, Responsabile Dipartimento Relazioni Internazionali della Fondazione per la Sussidiarietà.
CARLO LAURO:
E’ un vero piacere essere qui al Meeting per la quarta volta, a presiedere il primo di una serie di incontri tra le Fondazioni, dal tema “il mondo che cambia, il ruolo dell’educazione e del welfare”. Questo primo incontro ha in particolare come obiettivo la presentazione della fondazione per la sussidiarietà, le sue attività e il suo ruolo nell’educazione. Questo è il punto che accomunerà una serie di incontri che si succederanno nei giorni successivi: siete tutti invitati a partecipare perché sarà interessante. Questo era lo scopo di Dario Chiesa, che ha ideato questo Meeting per permettere alle varie Fondazioni di confrontarsi. E sarà anche interessante quello che alla fine di questi incontri cercheremo di portare avanti come conclusione, per legare ancora di più tra loro una serie di Fondazioni che già cooperano in questa direzione.
Vi presento Dario Chiesa, la persona che ha progettato e fortemente voluto questa serie di incontri, che ci spiegherà le finalità, disegnando quel fil rouge che lega non solo Fondazioni italiane ma anche Fondazioni importanti a livello internazionale. Successivamente darò la parola a Tommaso Agasisti, che illustrerà le attività della Fondazione, con particolare attenzione ai temi dell’educazione e del welfare. Il mio è un ruolo di moderatore a questo incontro, cui mi auguro possiate intervenire e partecipare: una delle cose che la Fondazione per la Sussidiarietà professa è quella sorta di rivoluzione dal basso che prevede la partecipazione di tutti noi. Quindi, mi auguro che questo dibattito si possa anche giovare dell’intervento del pubblico. Vi ringrazio per l’attenzione e do la parola a Dario Chiesa della Fondazione per la Sussidiarietà, che ci illustrerà la traccia di questa serie di incontri.
DARIO CHIESA:
La lingua di lavoro doveva essere l’inglese, ma siamo solo italiani e quindi abbiamo deciso di giocare in casa: parleremo italiano. Abbiamo chiamato questo ciclo di incontri workshop, laboratori, perché non vogliono essere seminari, lezioni o conferenze. Sono laboratori nati dalla constatazione che le Fondazioni sono sempre più importanti come produttori di cultura, qualunque sia il campo specifico di cui si occupano, e come luogo di incontro tra i costruttori e chi usufruisce della cultura. Il Meeting ci sembrava un luogo particolarmente adatto per questo incontro, proprio per la enorme quantità e qualità di interventi che ospita, tra cui quelli di parecchie Fondazioni. Ci è sembrato giusto avere un momento in cui le Fondazioni in quanto istituzioni vengono rappresentate, e abbiamo iniziato con le Fondazioni con cui siamo in rapporto di lavoro, di conoscenza. Ciò ha dato origine a questa serie di laboratori, dove ogni Fondazione presenterà la sua struttura, il suo lavoro, i suoi metodi, i fini che si prefigge, dove ciascuno gestirà la propria presentazione secondo ciò che ritiene. Il dibattito servirà anche perché, nelle altre sequenze di incontri, vi saranno più di una Fondazione: parlare insieme servirà a stimolare i rapporti tra Fondazioni. Questo è uno degli elementi, la possibilità di avere queste Fondazioni, due delle quali sono americane, quattro inglesi, due italiane più noi: martedì ci sarà la Konrad-Adenauer- Stiftung, tedesca, insieme al Card. Cordes.
Sono incontri che riteniamo abbastanza importati e che partono proprio dalla convinzione che le Fondazioni non siano più i santuari di un’élite più o meno accademica, che elabora cultura ideale ed astratta, ma possano veramente diventare motore della società che si dice civile, in un modo che cambia. Che cambia, è sotto gli occhi di tutti: occorre avere punti più o meno fermi, il che non vuol dire fossili, dinamici, che tendono ad avere una visione più strategica di ciò che accade. Abbiamo identificato un paio di aere, ancora una volta giocando un po’ in casa, perché sono due aree in cui la Fondazione per la Sussidiarietà e il principio di sussidiarietà trovano una particolare ampiezza di applicazioni: il welfare e l’educazione. Ma al di là di questo interesse, che tra l’altro è comune a tutte le Fondazioni che sono state invitate, ci sembrano due punti veramente radicali ed essenziali in questo mondo che cambia: il welfare, non più considerato come pura assistenza ma come un modo di concepire lo Stato e l’educazione, perché l’educazione è il motore fondamentale di qualsiasi convivenza civile, di qualsiasi società a partire dalla famiglia che molto spesso, quando si parla di educazione, viene considerata solo come qualcuno che deve pagare le rate della scuola per i figli, e non come il principale luogo di educazione.
Ecco, questa è la panoramica degli incontri. Stasera c’è la Fondazione per la Sussidiarietà di Milano, diretta dal Prof. Giorgio Vittadini. Domani sera avremo due Fondazioni, una inglese, la Tony Blair Face Foundation, l’associazione fondata dall’ex Premier Tony Blair, e la Fondazione Italianieuropei di Roma. Martedì ci sarà questo grande incontro con il Senatore Buttiglione e Giorgio Vittadini, con Paul Josef Cordes e con Pottering, ex Presidente dell’Assemblea Europea per la Konrad Adenauer Stiftung. Mercoledì ci saranno due Fondazioni americane: il CATO Institute e il German Marshall Fund of the United States. Giovedì vi saranno due Fondazioni inglesi: Cosmopolis e London Citizens. Venerdì ci sarà una fondazione inglese che è ResPublica e una italiana, Mezzogiorno Europa di Napoli. Questo è il panorama, iniziamo puntuali alle 19, breve introduzione, le relazioni e poi lo spazio per un dibattito che mi auguro ci sarà. Ho finito, passerei la parola.
CARLO LAURO:
Tommaso Agasisti presenterà la Fondazione e le sue attività nella direzione dell’educazione e del welfare per fronteggiare il mondo che cambia. Prego.
TOMMASO AGASISTI:
Grazie. Avendo il compito di fare il primo intervento di questo ciclo di incontri, ho cercato di organizzare la mia relazione, che sarà breve, vista l’ora, intorno a tre punti. Il primo: perché abbiamo voluto chiamare questo ciclo di incontri “Un mondo che cambia”? Cosa vuol dire “un mondo che cambia” e come, in questo mondo che cambia, si situano due tematiche a cui la nostra Fondazione è molto attenta? Sono l’istruzione e il welfare. Poi cercherò di descrivere quale sia il punto di vista della nostra Fondazione su questi due macrotemi, e di declinare invece più operativamente le attività che la Fondazione svolge in merito a queste due tematiche. Siccome Dario si è scusato con gli inglesi perché parleremo italiano, io nel frattempo mi scuso con gli italiani perché ho preparato le slides in inglese, comunque speso che le parole sopperiranno alla lingua scritta.
Quando ho cominciato a preparare il mio intervento a questo incontro, davanti alla provocazione “il mondo che cambia”, mi sono venuti in mente tanti problemi di cui sentiamo parlare ogni giorno dai telegiornali e da chi fa opinione. Ho cercato di elencarli molto rapidamente: il problema dell’invecchiamento della popolazione, la crisi finanziaria di questi anni, la riduzione dei fondi pubblici, la crescente diseguaglianza tra aree del nostro Paese e più in generale del mondo, la globalizzazione, i flussi migratori, i problemi generati dalle società multiculturali. E mi sono detto: se dovessimo descrivere il mondo che cambia con tutti questi problemi, avremmo di fronte a noi un quadro certamente non roseo. Allo stesso tempo, però, ragionando su questi grandi cambiamenti, mi sono accorto che questo è il modo con cui il mondo che cambia viene presentato dal mainstream, cioè dal pensiero dominante.
Di fronte a questi problemi, emergono sempre due constatazioni. La prima è che si tende ad elencarli senza mai proporre una soluzione. Cioè, questi problemi sembrano ineluttabili, il mondo è fatto così, ha questi problemi e ce li terremo per sempre. La seconda caratteristica del descrivere il mondo che cambia con questi problemi è che poi, quando si propongono non tanto delle soluzioni ma dei possibili interventi, ci si focalizza sempre sulle politiche da attuare, sulle istituzioni da creare e così via. Entrambi questi modi hanno un difetto, a nostro parere, tralasciano le persone. Tutti questi problemi hanno una cosa in comune, sono problemi delle persone. Ma nel proporre soluzioni, nel riflettere su questi problemi, si perde di vista completamente la persona con il suo bisogno. Ho voluto citare due focus che mi hanno particolarmente colpito, studiando i problemi del mondo che cambia.
Il primo è una considerazione che si trova all’interno del Rapporto abbastanza famoso redatto da Stiglitz, Sen e Fitoussi su incarico del Presidente Sarkozy, che si basa sull’idea che il benessere della persona non è solamente legato alla condizione economica ma anche alla qualità della vita delle persone. In questo Rapporto, loro sostengono che il problema oggi, con riferimento ai servizi pubblici o ai servizi destinati alla popolazione, non sia tanto la quantità dei servizi ma la loro qualità. Il focus deve essere non su quanto possiamo offrire alle persone per vivere la loro vita, ma che qualità della vita abbiano le persone. Questa attenzione alla qualità, in un rapporto scritto da freddi economisti, mi ha molto colpito. Il secondo aspetto è il ruolo di quello che in Italia si chiama Terzo Settore, o settore non profit, che tende a crescere nel mondo che cambia. Mi ha colpito questo articolo che il professor Salamon ha pubblicato recentemente in un’importantissima rivista, che si occupa di questi temi: facendo una mappa delle attività che svolgono le organizzazioni del Terzo Settore, ha fatto vedere come queste organizzazioni svolgano un insieme crescente di attività. Mentre prima erano relegate sostanzialmente ai margini della vita economica e sociale, oggi queste organizzazioni del Terzo Settore si trovano ad affrontare un numero crescente di situazioni problematiche, non solo legate all’assistenza degli ultimi, che è il ruolo che si vorrebbe affidare al Terzo Settore, ma nel campo dell’istruzione, dell’assistenza, e così via.
Credo che il punto di vista nuovo della nostra Fondazione, rispetto a questo mondo che cambia, si possa legare a questi due punti. Il primo è un’attenzione alla persona, ai bisogni che questa esprime. Il problema non è risolvere la fame nel mondo, il problema è l’esigenza di felicità che hanno quelle persone, che valore abbiamo le prospettive nella vita. Sono stato molto colpito, oggi, quando sono arrivato qua e la prima cosa che ho fatto è stato partecipare all’incontro in cui Rose spiegava l’attività che sta facendo in Uganda. Mi ha colpito questa cosa che lei dice ai ragazzi che incontra: “Voi avete un valore, tu hai un valore”. Ecco, forse non sarà la soluzione ai grandi problemi del mondo, ma di sicuro è un’attenzione alla singola persona che non ha nessuno. E allora, la nostra Fondazione è interessata a queste cose, a questo modo diverso di guardare alla vita di ciascuno.
E il secondo aspetto è il ruolo che le organizzazioni del Terzo Settore possono avere in questo modo nuovo di affrontare i grandi problemi. La visione della Fondazione per la Sussidiarietà è questa: l’applicazione del principio di sussidiarietà alla vita economica e sociale del nostro Paese e l’attenzione alle persone. Io mi sono andato a rileggere, per preparare questo incontro, la fonte sorgiva del principio di sussidiarietà, o almeno del modo con cui la nostra Fondazione guarda al principio di sussidiarietà, che è il modo con cui lo descrive la Dottrina Sociale della Chiesa. L’ho letto tante volte, ma rileggendolo in vista di questo incontro mi ha colpito per la sua chiarezza, perché descrive esattamente quale sia la provocazione aperta che la nostra Fondazione ha nello svolgere le sue attività, nel proporre soluzioni per i problemi. C’è questo passaggio, in cui la Dottrina Sociale della Chiesa dice: “E’ impossibile promuovere la dignità di una persona senza mostrare attenzione alla famiglia, ai gruppi, alle associazioni, alle realtà del territorio, in breve a tutto quell’aggregato di vita economica, sociale, culturale, sportiva, di ricreazione, professionale e politica che sono l’insieme delle attività a cui le persone dedicano la propria vita”. E mi ha colpito per la sua chiarezza, perché dice che non c’è possibilità di voler bene a una persona, di aiutarla nel suo cammino di vita, quindi di aiutarla, senza prestare attenzione alla rete di relazioni che questa persona ha. Mi ha colpito per la sua chiarezza, per la sua diversità rispetto a un modo oggi diventato prevalente di considerare il principio di sussidiarietà come delega tra livelli di Governo, come il fatto che se i servizi sono organizzati dai Comuni è meglio che se sono organizzati dalle Regioni piuttosto che dallo Stato. E’ un aspetto importante del principio di sussidiarietà, ma non coglie quell’aspetto su cui invece la Dottrina Sociale della Chiesa è così chiara.
Credo che se dovessimo dire quale sia stato, in questi ultimi anni di attività, l’aspetto più interessante, per me, del collaborare con la Fondazione per la Sussidiarietà, direi questo: leggere l’applicazione del principio di sussidiarietà alla vita economica e sociale in questa chiave, che non è un problema di delega di attività ma è un problema di valorizzare ciascuna persona, ciascun gruppo di persone, ciascuna associazione, per quello che ha da dire. La modalità di questo seminario è emblematica di questa idea: ciascuna Fondazione ha da dire qualcosa su come possiamo affrontare e cercare di risolvere un problema. E allora, il modo migliore non è cercare una soluzione che vada bene per tutti, ma è valorizzare la soluzione che ciascuno porta.
Breve declinazione su quello che mi ha colpito nella nostra attività su welfare e istruzione. Sul welfare la cosa che ha particolarmente colpito me, che ho una famiglia giovane – siamo io, mia moglie, le figlie – é questo aspetto: il principio di reciprocità applicato nella realtà dice una cosa semplice ma rivoluzionaria allo stesso tempo. La cosa semplice è che ciascuna famiglia merita di avere la possibilità di fare le proprie scelte in relazione all’assistenza di cui ha bisogno. Viviamo in uno Stato, in un Paese dove il concetto di welfare è stato applicato in una delle sue massime espressioni, dove l’assistenza, il bisogno della mia famiglia non lo decido io ma un’autorità. Perché il bisogno della mia famiglia è uguale al bisogno della famiglia che vive di fianco alla mia porta, è uguale al bisogno della famiglia che vive dall’altra parte del paese, e così via. Invece non è così, perché ciascuno ha un bisogno diverso: e allora, l’applicazione concreta del principio di sussidiarietà dice una cosa semplice ma rivoluzionaria, che ciascuno merita di fare le proprie scelte in relazione al proprio bisogno.
In concreto, significa che quando una famiglia ha bisogno di assistenza, i soggetti deputati a fornire questa assistenza devono essere tanti, diversi, diversificati, in modo che ciascuno possa scegliere quello che corrisponde al proprio bisogno. Mi capita a volte di discutere di queste cose con alcuni colleghi che vivono in contesti anglosassoni, in cui quello che dico sembra una banalità sconcertante. Invece, così non è nel nostro Paese, perché nel nostro Paese l’unico bisogno che la mia famiglia può esprimere è di ricevere un sussidio uguale per tutti, fatto salve poi le differenze in relazione al reddito, ma quello è il bisogno che la mia famiglia ha. Invece non è così, perché qualcuno ha bisogno della baby sitter per badare ai figli, qualcuno ha bisogno di qualche soldo in più per fare la spesa, qualcuno ha bisogno di altro. Il ruolo del settore pubblico, in questa idea, non è quello di fornire i servizi ma di accreditare diversi soggetti che abbiano facoltà di proporre una propria soluzione di servizi. Quello che a noi viene in mente è un mondo dove i soggetti che offrono servizi alle famiglie e alle persone siano tanti e diversi tra loro, non uno uguale per tutti.
Se dovessimo declinare questo aspetto sull’istruzione, vale la stessa idea. Noi viviamo in un Paese dove la scuola è una, uguale per tutti, la scuola di Stato, che significa non solo che esiste un unico tipo di scuola, ma che esiste un unico tipo di scuola che deve insegnare le stesse cose nello stesso modo a tutti gli studenti. E invece, tutti gli studenti sono diversi e chi guida una scuola ha un’idea diversa di quello che dovrebbe essere insegnato e preferisce puntare su un aspetto piuttosto che su un altro. L’applicazione del principio di sussidiarietà dice che il primo soggetto deputato all’educazione dei figli è la famiglia, ed è la famiglia che deve scegliere l’educazione migliore per i figli. Quando io ho detto queste cose in un Master in cui insegnavo, e i cui allievi erano insegnanti e presidi di scuole statali, in tante parti d’Italia, ho rischiato l’incolumità fisica, perché sembra una bestemmia. E invece l’applicazione del principio di sussidiarietà è facile, sotto questo profilo, perché dice una cosa semplice, ma è una verità tutt’altro che accettata. Noi viviamo in un Paese dove la scuola non statale è considerata una scuola guardata con sospetto.
Cosa fa la Fondazione per la Sussidiarietà per promuovere questa idea del principio di sussidiarietà, e quindi questa idea di società e di economia? Quattro cose, fondamentalmente, in verità tantissime, ma ho cercato di sintetizzarle a beneficio di tutti. Attività core, che adesso descriverò, attività di formazione, pubblicazioni, e un certo dibattito con il mondo politico. Attività core sono le attività tra cui ho citato per prima il sussidiario.net, la piattaforma online, il quotidiano con cui la Fondazione diffonde la propria vision: è diventato un sito ormai cult, ha due milioni di visitatori. La Fondazione coordina e svolge alcune attività di ricerca, molte delle quali su questi settori. Il Rapporto annuale sulla Sussidiarietà è una pubblicazione annuale curata dalla Fondazione su un tema specifico ogni anno. Il primo è stato sull’istruzione, l’ultimo è stato sulla Pubblica Amministrazione: l’idea è cercare di andare a fondo, ogni anno, su un tema e capire come il principio di sussidiarietà, nella sua declinazione concreta, che ho cercato di delineare rispetto al welfare, si attua in un particolare contesto.
Poi c’è l’attività di formazione. La Fondazione collabora con alcune Università per alcuni corsi di Master: qui ne ho citati un paio che hanno a che fare con i temi che abbiamo trattato, uno sul Management delle Istituzioni Educative, e uno sul Management delle Organizzazioni non profit. Se questa idea della società deve essere portata avanti, ci vuole qualcuno che nelle scuole, nelle organizzazioni non profit, porti avanti una certa visione. Poi, ci sono le pubblicazioni, che ho diviso in quattro: la prima è Atlantide, un trimestrale che si focalizza su un particolare tema, l’ultimo è stato sulla Riforma dell’Università, sempre per stare nel campo dell’istruzione. Poi, una serie di libri, una collana di libri che si chiama Punto di fuga, edita da Guerini, e un’altra collana, sempre edita da Guerini, che si occupa del link tra istruzione e lavoro. Ci sono i Quaderni della Sussidiarietà, pubblicazioni su temi specifici, a volte anche come esito degli incontri, dei segnali che la Fondazione promuove in giro per l’Italia. E infine, il contributo al dibattito politico: la Fondazione collabora con l’Intergruppo per la Sussidiarietà, anzi, ne è stata promotrice, a suo tempo, e oggi cura la segreteria tecnica di questo Intergruppo, e coordina il network delle associazioni dalle quali è nata questa idea. Vi ringrazio per l’attenzione.
CARLO LAURO:
Credo che abbiamo un po’ di tempo, mi piacerebbe avere le vostre reazioni su quanto è stato esposto da Tommaso con estrema chiarezza, soprattutto il punto di vista espresso dalla Fondazione sui temi del welfare e dell’educazione. Sarebbe interessante confrontarsi con i partecipanti a questo incontro e sentire che cosa vi ha colpito. Quindi, prima di dare la parola a Dario, desidero sapere se qualcuno vuole intervenire. Prego.
DARIO CHIESA:
Se non ci sono interventi, vorrei fare una sottolineatura a un passaggio di Tommaso Agasisti sul concetto di sussidiarietà, perché da un po’ di anni la sussidiarietà è diventata di moda, è nella Costituzione, nei documenti fondativi dell’Unione Europea. Ma c’è un piccolo particolare, fondamentale rispetto a ciò che la Dottrina Sociale della Chiesa intende come sussidiarietà, ed è quanto Tommaso ha sottolineato. Nella Dottrina Sociale della Chiesa, tenendo presente che il principio determinante è l’unicità della persona nelle sue relazioni, la delega parte dai cittadini, o comunque dalle persone verso lo Stato, il quale dovrebbe intervenire solo per sopperire sul singolo affaire, per portare aiuto dove le persone stesse, i gruppi, non riescono a fare. Capite che è una concezione completamente diversa, la delega verso il basso, perché chiaramente il Comune è più vicino che non lo Stato. Ma se la mentalità è sempre quella di un centro che fa discendere i propri servizi, anche portandoli a livello più piccolo di quanto non sia lo Stato centrale, la sussidiarietà rischia di essere solamente una questione di delega amministrativa.
DOMANDA:
Non voglio entrare in modo polemico su argomenti così importanti, ma ritengo di focalizzare, con un esempio e un’affermazione, quello che il prof. Chiesa prima ha espresso. L’esempio: scuole per l’infanzia nel settore non statale. E’ l’esempio più lampante di una sussidiarietà vista esattamente al contrario. Cioè, lo Stato delega la gestione della scuola dell’infanzia perché non è in grado di sostenere e dare risposte alle esigenze dei cittadini in questo campo. Man mano che riesce, toglie un pezzo di questo tipo di settore a chi ha agito anche bene nel passato e se lo riprende. E’ la dimostrazione di una applicazione opposta a quello che dovrebbe essere il principio di sussidiarietà. Seconda affermazione, il problema della gestione delle risorse. Gestire risorse per l’utilità del cittadino vuole dire avere potere: è chiaro che, in un mondo che cambia, partire dai bisogni del cittadino facendo dare a lui la risposta – e, solo nel caso in cui non riesca, facendo intervenire l’Ente locale, fino ad arrivare al centro dello Stato -, sarebbe una rivoluzione totale. Però poi sappiamo benissimo che qui si gioca tutto l’aspetto di gestione delle risorse, senza cui le bellissime impostazioni della Dottrina della Chiesa a cui lui ha fatto riferimento avrebbero grosse difficoltà ad essere applicate.
DOMANDA:
Sono responsabile di alcune Fondazioni nel welfare. La mia domanda è molto semplice: come si fa a rompere il rapporto di delega del cittadino verso lo Stato? Perché la rottura di questo rapporto indica una grossa responsabilità. Come si fa a far venire voglia al cittadino di avere maggiore responsabilità?
DOMANDA:
Una delle questioni più importanti per tutti coloro che lavorano nel settore della società civile è che, quando si scopre una metodologia innovativa, il modo per farla progredire è diffonderla a livello non solo locale.
DOMANDA:
Ho avuto modo recentemente di incontrare la Fondazione della Sussidiarietà in un lavoro che stiamo facendo con un gruppo di docenti all’Università. All’interno della Facoltà di Ingegneria, ci stiamo interrogando sulla formazione dell’ingegnere e sul fatto che il punto di estrema debolezza sia quello di un individualismo persino nella formazione professionale. Sapete tutti che la Calabria è affetta dal problema del disastro geologico. Bene, persino questo problema rischia di essere affrontato in maniera ideologica, senza che sia inserito in un contesto più vasto. L’individuo che va ad operare sul territorio, senza quella ricchezza che era totalmente espressa all’interno della Dottrina Sociale della Chiesa, necessariamente riduce a livello ideologico il suo punto di vista ed è incapace di valorizzare ciò che, all’interno del territorio, può essere valorizzato come risorsa. Tanti colleghi hanno cominciato ad appassionarsi umanamente a questo punto di vista. E partendo dal basso, stiamo tentando di porre un esempio per invertire la tendenza, immaginando un’azione formativa che sia capace di abbracciare con interezza di sguardo tutte le problematiche presenti sul territorio.
DARIO CHIESA:
Vorrei aggiungere qualcosa, anche per dare una risposta ai primi interrogativi e allo scetticismo che è stato sollevato nella prospettiva dell’uso della sussidiarietà nella educazione. La Fondazione per la Sussidiarietà non solo si preoccupa di promuovere la sussidiarietà, di studiarne i fondamenti ma, soprattutto con una serie di ricerche sul campo – siamo ormai al quarto Rapporto annuale -, tenta di misurare l’effetto della sussidiarietà. Sono stati ricordati gli elementi del cammino percorso dalla sussidiarietà, dalla Dottrina Sociale della Chiesa, all’Enciclica di Pio XI Quadragesimo Anno, al Trattato di Maastricht, al Titolo V° della nostra Costituzione riformata: ma poco si citano quelle belle pagine che ha scritto per noi, nella recente Enciclica Caritas in Veritate, Benedetto XVI. La recente Enciclica, in particolare, introduce una notevole innovazione per quanto riguarda l’interpretazione del principio di sussidiarietà. Essa infatti supera la concezione antagonistica tra individuo e Stato che di tale principio diede Pio XI nell’Enciclica Quadragesimo Anno. Benedetto XVI sottolinea una prospettiva personale e relazionale: da un lato, vi è un nesso strettissimo tra la sussidiarietà, la libertà e la dignità della persona, dall’altro, l’importanza della relazionalità come elemento essenziale dell’umano per perseguire l’emancipazione del bene comune. Sostanzialmente, nell’ottica di Benedetto XVI, diventa importante l’aspetto relazionale come modalità per superare queste difficoltà nell’adottare quella che potremmo considerare, con Benedetto XVI, la sussidiarietà.
Molte volte noi chiediamo, nelle nostre ricerche, quanti conoscano la sussidiarietà. A titolo di esercizio, posso chiedere: quanti di voi sono in grado di darmi una definizione di sussidiarietà, alzando la mano? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei: su circa quaranta persone, il 12% conosce la sussidiarietà in questa sala, meno di quanto la conosca la popolazione italiana. Nella popolazione italiana, riscontriamo un dato per cui la sussidiarietà è nota al 20% dei cittadini. La sussidiarietà invece è ben nota negli organi che amministrano lo Stato, dove si arriva a percentuali del 90%. Il 65% delle Amministrazioni da me intervistate nell’ultimo Rapporto, dichiara di applicare la sussidiarietà. Questo è il tipo di contributo che noi cerchiamo di dare, dimostrando quali siano stati i vantaggi e facendoci raccontare esperienze concrete, non semplicemente citando delle statistiche: “Conosci o non conosci la sussidiarietà?”.
Tra i vantaggi più citati, c’è la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Il secondo è una maggiore efficienza, il terzo è un maggiore numero di facilitazioni e una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini. Ancora, una maggiore economicità, ma anche semplificazione amministrativa. Questi i vantaggi dal punto di vista delle Amministrazioni, ma dal punto di vista del cittadino? Nell’intervista c’è un piccolo colloquio con cui si introduce, diciamo che cos’è la sussidiarietà con alcuni esempi, il cittadino percepisce una maggiore responsabilità, una maggiore libertà, soprattutto una maggiore partecipazione alla realizzazione del bene comune. Come è stata realizzata la sussidiarietà? Vi sto dicendo queste cose per suggerire a coloro che hanno manifestato pessimismo che, tutto sommato, siamo sulla buona strada. La Fondazione investe molto, non solo nella diffusione del principio, ma anche in informazione. Lo ha fatto a Napoli in un bellissimo Master sulla governance pubblica, lo fa sistematicamente con una scuola per la sussidiarietà, cui partecipano gli amministratori pubblici. In particolare, devo segnalarvi che l’ultima indagine che abbiamo effettuato era relativa al ruolo della sussidiarietà nella prospettiva del welfare. Chi partecipa maggiormente? In primo luogo, almeno per quanto riguarda l’esperienza italiana, partecipano nel 73% dei casi il Governatorato, nel 72% organismi di cooperazione, nel 45% associazioni e Fondazioni: qui diventa importante il ruolo della Fondazione, magari per essere più attivi. Devo dire che ancora piccola è la partecipazione dei singoli cittadini e delle famiglie, che arriva appena al 25%, con un 19% degli enti for profit.
Quali sono le modalità più frequenti che vediamo utilizzate? Tra le forme più diffuse troviamo la sussidiarietà per progetti, una pura esternalizzazione che affida completamente la responsabilità al volontariato, a enti privati for profit, e non profit, ma anche la redistribuzione di risorse senza apporto istituzionale. La Fondazione raccoglie queste esperienze: quest’anno presenteremo in un apposito documento una sorta di banca dati delle esperienze sussidiarie nel welfare. Dove è stato più efficace un intervento? È proprio nelle diverse dimensioni del welfare. La maggiore efficacia è stata dimostrata negli interventi a favore degli anziani, dell’infanzia, dei disabili, dello studio, del diritto allo studio e della famiglia, dove un approccio sussidiario ha dato risultati meno rilevanti. C’è ancora molto da lavorare sulle politiche per la casa, per l’immigrazione e anche per la formazione. Il nostro lavoro non deve consistere soltanto nel promuovere un’idea, ma anche nel valutarne l’efficacia. Questi risultati ci lasciano ben sperare su una prospettiva in cui la sussidiarietà è modello di sviluppo.
Io non amo parlare del principio di sussidiarietà, perché il principio mi rimanda immediatamente agli aspetti giuridici della sussidiarietà verticale, della sussidiarietà orizzontale, e il discorso diventa un po’ arido. In una definizione, noi dobbiamo dire: a che cosa serve la sussidiarietà? La sussidiarietà può essere un modello di sviluppo basato sull’iniziativa del singolo e dei corpi sociali intermedi. Rispetto a quello che perseguono, diventa importante il ruolo dei cittadini in termini di partecipazione. Non dobbiamo aspettarci ancora una volta che lo Stato ci permetta di fare qualche cosa, dobbiamo giocare un ruolo attivo, abbiamo delegato troppo, a questo Stato. L’idea è che ci sia – per concludere – “più società e meno Stato” Grazie.
TOMMASO AGASISTI:
Solo due slogan, vista l’ora, sui temi che ci sono stati posti dalle domande. La prima è stata la domanda del nostro collega inglese, che sostanzialmente chiedeva come le buone esperienze realizzate a livello locale o da singole organizzazioni possano poi diffondersi e che tipo di relazione si deve sviluppare tra chi gestisce la cosa pubblica, quindi l’amministrazione locale, e le organizzazioni, per far si che le buone pratiche si possano estendere. Lui diceva una cosa molto interessante: “Ho una visione molto pragmatica, le cose che fanno meglio le organizzazioni, le facciano le organizzazioni; quello che le organizzazioni non sono capaci di fare, lo faccia il settore pubblico”. Io sono totalmente per questa linea, ma dico di più. Credo che il problema sostanziale intorno a questo tema sia la disponibilità del settore pubblico a guardare, a vedere quello che nasce tra le persone e nelle organizzazioni. Io sono curioso di sapere quanto gli Assessori alle politiche di welfare dei Comuni, delle Regioni, delle Province vadano in giro a vedere la realtà e quello che accade. Un mio carissimo amico fa di mestiere il Direttore della CdO non profit, e mi racconta di quando va in giro per l’Italia a vedere le opere: se io fossi Assessore di una Regione o di un Comune che si occupa di welfare, farei prima di tutto questo, andrei in giro a vedere cosa c’è. E invece questa è una cosa che non fa nessuno, perché non gliene frega nulla, purtroppo.
L’altra questione che mi ha molto colpito tra le domande è: “Come si fa a rompere la delega che i cittadini danno allo Stato?”. E’ vero, per una ragione di tipo culturale, noi viviamo in un Paese dove siamo abituati così: quando c’è un bisogno, qualcuno offre una soluzione. Però credo ci sia un punto che sta emergendo, se devo guardare alla mia generazione: queste risposte non vanno più bene. Se penso a me, alla mia famiglia e al tipo di risposte che il settore pubblico offre alle necessità della mia famiglia, il nodo che si è rotto è che queste risposte non vanno più bene: questo è veramente uno di quegli aspetti del mondo che cambia. Se fino a ieri un certo tipo di intervento leniva un problema, oggi accade sempre meno. Quando la mia famiglia ha dovuto scegliere in che asilo iscrivere mia figlia, le soluzioni offerte non andavano bene e quindi ne abbiamo cercata un’altra. Credo sia ineluttabile questo cambiamento, però è vero che il contesto culturale in cui siamo nati non aiuta questo slancio personale.
DARIO CHIESA:
Rubo due minuti per un possibile equivoco su ciò che si intende per sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà e la prassi della sussidiarietà non pongono in contrapposizione la gente comune buona e lo Stato cattivo: la Dottrina Sociale della Chiesa è estremamente pratica e pragmatica. Al primo punto, pone la persona, e sappiamo che le persone sono fatte di bene e di male, impastate di bene e di male. La sussidiarietà è un tipo di atteggiamento nei confronti della società che parte dal reale, quindi dal fatto che la società è fatta da persone, persone in relazione, non da monadi, non da categorie, non da definizioni esterne, ma da persone di carne e sangue. E ci si rende conto che il principio di sussidiarietà, che si parte dal basso, e l’alto interviene solo su richiesta o per portare aiuto, ha in sé un pericolo: che diventi egoismo, perché anche le persone possono essere egoiste, anche i gruppi possono essere egoisti. Ne abbiamo ampi esempi: in una società che non è caratterizzata dalla sussidiarietà, ciascuno si fa gli affari suoi. Quindi si introduce un terzo principio, da non dimenticare, che è quello della solidarietà, proprio per evitare che il principio della sussidiarietà – nonostante le intenzioni, proprio perché la persona è fatta com’è – porti in realtà ad una serie di gruppi contrastanti tra loro, che inseguono interessi particolari. Il principio di solidarietà non consiste solamente nell’aiutarsi tra persone, è un concetto di tipo giuridico: in termini giuridici, è la responsabilità in solido, siamo tutti responsabili di questa operazione. E allora la persona, attraverso la sussidiarietà, diventa responsabile del bene comune e del bene della collettività. Capite che è una visione completamente diversa rispetto a uno Stato in cui c’è un organo centrale che decide cosa va bene per uno, cosa va bene per l’altro, cosa bisogna fare. E’ una rivoluzione, difficile, perché parte da ciascuno di noi. Io continuo a chiamarlo principio, perché si parte dai principi ma poi l’attuazione é nelle mani di tutti noi. Grazie.
CARLO LAURO:
Volevo ringraziare i relatori ma anche la vostra partecipazione attiva a questo incontro. Se ne parlerà ancora nelle prossime giornate, a partire da domani, alla stessa ora. Vi invito anche a tornare per seguire tutti gli incontri, per sapere come va a finire, insomma. Perché oggi è stato molto interessante ascoltare i diversi punti di vista, soprattutto la sussidiarietà così come è stata da ultimo sottolineata, cercando di dare una risposta ai problemi di questo mondo che cambia, in particolare ai problemi del welfare e dell’educazione. Mi auguro che risposte significative possano giungere anche da altri punti di vista, espressi dalle Fondazioni che sono state invitate a questa serie di incontri. Grazie ancora e a domani.
(Trascrizione non rivista dai relatori)