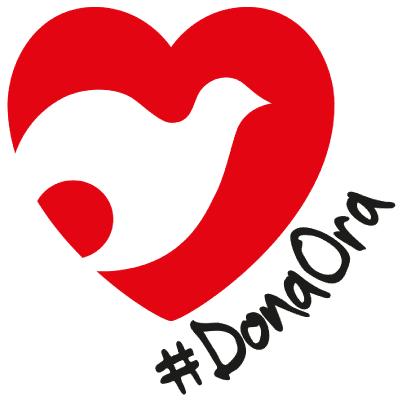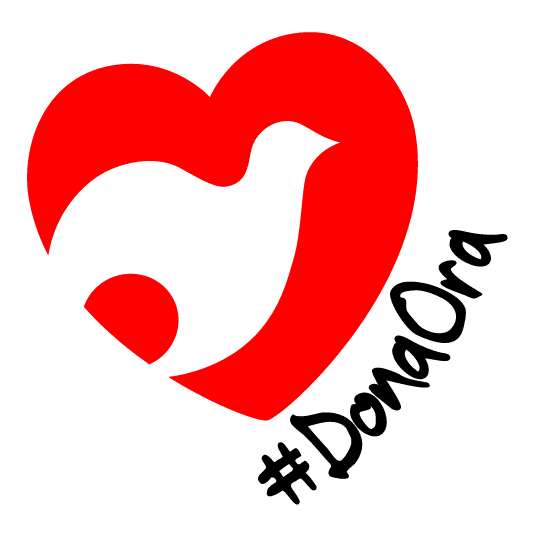Chi siamo
FINE PENA E FORME ALTERNATIVE DELLA PENA
Partecipano: Gherardo Colombo, già Magistrato; Elvio Fassone, già Magistrato e autore di “Fine pena: ora” (Sellerio Editore). Introduce Paolo Tosoni, Avvocato.
Fine pena e forme alternative della pena
PAOLO TOSONI:
Un benvenuto a tutti da parte del Meeting, da parte mia personale e un ringraziamento veramente sincero ai nostri ospiti che si sono resi disponibili di venire qui a parlare di un argomento che non è sempre facile affrontare. Come vedete doveva esserci il Ministro della Giustizia, ha avuto un impedimento improvviso, ci ha avvisati, però ha voluto mandarci un messaggio che vorrei leggere subito, introducendo questo incontro, perché mi aiuta a entrare nell’argomento di cui oggi parliamo.
Messaggio del Ministro della Giustizia Andrea Orlando:
“Vorrei salutare e ringraziare il Meeting per il cortese invito. Ci tengo ad esprimere tutto il mio rammarico per non essere lì con voi per via di un impedimento istituzionale dell’ultima ora e mi permetto di inviarvi qualche riflessione. Le straordinarie parole di Goethe che ispirano il Meeting di quest’anno sul senso dell’eredità chiamano fortemente in causa il nostro rapporto con la politica e con la società. Ereditare, nel senso profondo suggerito da Goethe, significa attuare le relazioni, renderle vive e concrete, sapere che qualcuno è venuto prima di te e che qualcun altro verrà dopo di te e corrispondere al proprio ruolo con responsabilità. Pensiamo al rapporto con i diritti costituzionali: ogni generazione si trova a confermarli con i fatti, a mostrare concretamente la loro attuazione e il loro avanzamento. Il senso dell’eredità si lega fortemente al tema della discussione su fine pena e forme alternative della pena; su questo il libro di Elvio Fassone ci interroga con forza.
Quale eredità è possibile pensare davanti alla soglia del fine pena mai? Fassone mostra che è possibile costruire relazioni, è possibile farsi prossimo di un detenuto, anche a partire dalla grande distanza iniziale. La scrittura nel libro e nella vita è una modalità di farsi prossimi che crea un legame che dà senso al tempo.
Il tempo può avere senso solo se facciamo di tutto per inserire l‘elemento sociale nella no-stra idea della pena. In questi anni abbiamo intrapreso un percorso importante per una concezione della pena che punti alla risocializzazione in una vera logica riparativa. Dagli stati generali dell’esecuzione penale alla riforma del processo penale il confronto, lo scambio e l’elaborazione legislativa su questo tema è stato al centro della nostra attenzio-ne, insieme ad un importante investimento. Questo è uno degli ambiti in cui la parola sus-sidiarietà acquista maggior concretezza nella collaborazione tra le varie amministrazioni dello Stato, nel rapporto tra pubblico e privato, nella valorizzazione delle esperienze asso-ciative religiose, nel riconoscimento dell’innovazione sociale; per questo ad esempio ab-biamo supportato esperienze innovative come la sperimentazione presso l’Istituto Lorusso Cotugno di Torino della applicazione di strumenti per l’inserimento sociale lavorativo delle persone detenute. Il libro di Fassone racconta la forza di una relazione, che cambia il detenuto e cambia il magistrato e chiama in causa fortemente il lettore e le istituzioni. Ci trasmette l’esigenza di cambiare prospettiva, di invertire lo sguardo sul carcere, l’esigenza di riempire il tempo del carcere con percorsi sociali, rendendolo un tempo di riconnessione. Possiamo riappropriarci del senso della relazione solo con un cammino di umanizzazione che tutta la nostra società deve intraprendere, è la strada che Papa Francesco ha indicato nel suo incontro in carcere nel gesto della “lavanda dei piedi” e nelle sue parole ai detenuti.
Andrea Orlando”
Perché vi ho detto che questo messaggio mi aiuta ad introdurre l’incontro di oggi? Perché questo incontro il cui titolo è “Fine pena e misure alternative della pena” è in parte mutuato dal titolo di questo libro del dottor Elvio Fassone, che è qui con noi, che è Fine pena: ora?.
È un libro che ci ha dato lo spunto per questo incontro, che io personalmente ritengo bel-lissimo e utilissimo a giuristi e a non giuristi, perché ci ha fatto comprendere, come sia ne-cessario riflettere sulla giustizia, sulla pena, sull’esecuzione della pena, sui rapporti tra gli operatori della giustizia e i protagonisti anche negativi della giustizia, che sono coloro che hanno commesso reati. Riflettere soprattutto, e questo sarà uno degli argomenti importanti di oggi su un istituto come l’ergastolo, che è un istituto per il quale il detenuto viene incarcerato a vita. Il libro, e voglio introdurre così il dottor Fassone, dà due spunti, che mi permetto di sottolineare, molto significativi: il primo di metodo – io non entro nel contenuto perché chiedo poi al dottor Fassone di illustrarci questa esperienza che lui ha vissuto, che è l’esperienza pluriventennale di un rapporto epistolare, che continua tutt’ora, con un detenuto che lui vent’anni fa aveva condannato all’ergastolo – di metodo, dicevo, perché questo rapporto lo fa riflettere sul senso della pena, sul senso dell’ergastolo che lui stesso ha dato, gli fa incontrare l’umanità di quest’uomo, gli fa vivere una relazione con lui, che gli permette di conoscere la vita di un carcerato, nelle pieghe anche interiori di quest’uomo che si confida con lui, che è diventato il suo più grande amico, forse l’unico vero amico che gli è rimasto. E qual è il metodo? Il metodo è che bisogna conoscere, guardare, entrare in rapporto. Alla fine del libro, trae anche delle considerazioni di natura giuridica e propone delle alternative al problema dell’ergastolo, in particolare riguardo all’ergastolo ostativo.
Cos’è l’ergastolo ostativo, e cosa lo differenzia dall’ergastolo non ostativo?
L’ergastolo ostativo è previsto per alcune tipologie di reati: mafia, terrorismo, reati sessuali ecc. per cui tutti gli aspetti premiali, i permessi premio, che normalmente vengono conces-si nell’ambito di un percorso carcerario, non possono essere concessi, se non con dei percorsi lunghissimi, complessi, di cui il dottor Fassone ci parlerà. Ad esempio, un tema importante è la liberazione condizionale, che è la possibilità di vanificare l’ergastolo: dopo ventisei anni di pena espiata, si può chiedere la liberazione condizionale se si è fatto un percorso ineccepibile di buona condotta all’interno del carcere e ottenere una liberazione condizionale, ossia per cinque anni si è sottoposti a una misura di sicurezza e dopo cinque anni, se non si commettono più reati (quindi complessivamente trentun anni), si può diventare liberi. Questo per l’ergastolo ordinario.
Per l’ergastolo ostativo questo percorso è quasi precluso, se non a un prezzo particolare che è quello della collaborazione, che però è un fatto su cui riflettere perché significa ob-bligare ad accusare altri, quando nel nostro ordinamento, questo è un fatto che deve essere lasciato all’assoluta libertà della persona.
Ecco allora il metodo: conoscere concretamente, entrare in rapporto per riflettere e avere delle proposte di modifica, di rivisitazione del sistema, non pensate in astratto, ma proprio suggerite dall’esperienza.
Troverete nel libro, per chi vuole leggerlo, una particolare cautela da parte del dottor Fas-sone laddove, nella parte finale, ragionando sull’ergastolo e sostenendo il fatto di non es-sere convinto che questo sia un reale fatto di giustizia, dice: “Forse io sono un po’ troppo influenzato emotivamente da questo rapporto” ebbene io mi permetto di ribadire che vice-versa questo metodo è da ritenersi l’unico vero metodo efficace per arrivare anche ad ela-borare delle soluzioni rispetto al sistema carcerario. Il secondo suggerimento, e poi gli do la parola, lo traggo da una frase contenuta proprio alla fine del libro, è una frase di Silvia Giacomoni che dice: “Il carcere è pena per gesti che non andavano compiuti, ma la perso-na non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia; cristianamente la pos-siamo tradurre così: l’uomo non è definito dal peccato che ha commesso”. Ebbene la sfida che affrontiamo oggi in questo incontro è proprio questa: se siamo convinti, laicamente o cristianamente, che l’uomo possa cambiare, che anche colui che ha commesso gesti gravissimi crudeli possa cambiare e grazie a Dio noi abbiamo tanti esempi di questo, anche di nostri amici, dobbiamo avere l’intelligenza, la lungimiranza, il coraggio di creare premesse giuridiche, riforme normative, organizzative del sistema dell’esecuzione della pena in grado di favorire ciò che è nell’interesse di tutti: è nell’interesse della società, degli operatori della giustizia, nell’interesse ovviamente dei condannati e, lo dico con profondo rispetto, è nell’interesse anche delle vittime, restituire alla società delle persone che hanno compreso il proprio errore, che vogliono recuperare il bene procurato, che vogliono recuperare il tempo perduto per essere migliori e costruire una società migliore. Persone che nella libertà, che è il bene più prezioso che abbiamo, siano nel tempo veramente cambiate e mi permetto anche in questo caso di riallacciarmi ad un piccolo episodio raccontato nel libro che si chiama “I bambini no”, in cui il protagonista Salvatore invia una foto di quattro bimbi in una lettera al dottor Fassone. Gli invia una foto di quattro bambini, un grumo intenso di infanzia accatastata, vicini di età come se fossero stati sfornati a raffica: esibiscono il ciuffo ribaldo, la posa guerrigliera, lo sguardo di chi ha già chiaro in mente che nella vita l’importante è farsi rispettare. Salvatore spiega che sono i suoi nipotini: il papà è in carcere, la mamma si arrabatta come può e non riesce a farsi ascoltare. La faccio breve: lui, Salvatore, detenuto, scrive “non rispettano nessuno, dovrei esserci io vicino a loro, a me mi ascolterebbero per forza o con le buone o con le cattive, ma io sono qui chiuso e so già che loro finiranno sulla cattiva strada. Dovrei esserci io a casa con loro, gli direi di studiare, di imparare a fare un lavoro, altrimenti finiscono là, dove sono finito io”.
Persone che oltre a comprendere il proprio errore, vogliono recuperare il tempo perduto e possono diventare costruttori di civiltà nuova. Questo è veramente quello a cui noi tutti dobbiamo cooperare perché sia possibile che ciò avvenga. Adesso chiedo al dottor Fas-soni di raccontarci un po’ questa bellissima storia, perché questa storia è ciò che spiega, forse più di ogni altra cosa, quelli che sono i limiti e anche le distorsioni del nostro sistema.
Chi è il dottor Fassone? Il dottor Fassone è stato un magistrato, a Torino, presidente di Corte di Cassazione, è stato anche nel Consiglio superiore della magistratura e senatore nella tredicesima e quattordicesima legislatura (quindi dal ’96 e al 2006). La parola al dot-tor Fassone.
ELVIO FASSONE:
Un grazie, non di circostanza, per l’invito, per la lusinghiera presentazione dell’avvocato Tosoni e per la considerazione e l’accoglienza che ha avuto questo piccolo lavoro. Un’accoglienza che mi ha sorpreso, perché in effetti il libro non racconta una storia, non è una storia o se storia è, è una storia esilissima e tuttavia ha avuto una risposta per cui evidentemente ha toccato delle corde e io provo a dire quali sono le corde che deve aver toccato ricavandolo dai dialoghi, dalle tante presentazioni a cui ho avuto l’opportunità di partecipare e dalle risposte che hanno dato le persone che l’hanno letto.
La prima considerazione è la lunghezza di questa corrispondenza: ventisei anni, quando il libro è stato scritto, quasi ventinove oggi, perché la corrispondenza continua, sono davvero un tempo gigantesco. Se pensiamo che la corrispondenza tanto celebrata tra Abelardo ed Eloisa è durata due o tre anni, quella altrettanto ricordata tra Marina Cvetaeva e Boris Pasternak, l’autore del Dottor Zivago, è durata quattordici anni, negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, questa è durata più del doppio: ventisei anni, oggi ventinove. Sono più di un terzo della vita media e questa durata sbalordisce e ci richiama al fatto che altrettanto è durata e sta durando la detenzione di uno dei più protagonisti e questo è importante.
La seconda considerazione, fattami dai lettori, è la qualità dei due soggetti: non soltanto si tratta di un giudice e un detenuto, ma qui si tratta di un detenuto condannato all’ergastolo e del giudice che gli ha erogato quella pena e che lo ha accompagnato per tutta la pena medesima finora in corso, perché Salvatore è tutt’ora vivo e tutt’ora detenuto dopo 34 anni di detenzione. Il terzo elemento di attrazione, di interesse, di coinvolgimento è stata una storia all’inizio positiva, perché all’inizio c’è stata una specie di conversione. Non voglio richiamare l’Innominato, il paragone è troppo alto per essere avvicinato a questa storia, ma è comunque un capo della criminalità che in forza di un gesto decide di cambiare il suo modo di guardare l’esistenza. Questa storia, però, che comincia bene ed evolve positivamente per tutta la sua prima parte, poi si inceppa, si inceppa per una serie di circostanze negative, che non è neanche possibile addebitare alla cattiva volontà dell’uno o dell’altro: è l’inerte rotolare delle cose lasciate a sé, non seguite con un supplemento d’anima, con un supplemento di attenzione, con un supplemento di volontà per superare quelli incagliamenti. Salvatore che per dieci anni, quindici anni, venti anni, ha cercato di tener fede alla promessa fattami all’inizio, ad un certo punto non ce la fa più, prima commette una piccola infrazione e poi di fronte ad un ulteriore inciampo del suo percorso si toglie la vita. Si impicca ed è quello che mi ha indotto a scrivere il libro. Si impicca, ma devo aggiungere che la solerzia di un agente di custodia lo salva, lo distacca e lui mi scriverà la settimana dopo dandomi sommarie notizie come faceva con cadenza più o meno mensile: “Ad un certo punto caro presidente – scrive – le devo dire una cosa: la scorsa settimana ne ho combinata una delle mie, mi sono impiccato. Mi scusi, non lo farò più!”. Ecco, sono state queste quattro parole (“Mi scusi, non lo farò più”) di una persona che chiede scusa di aver cercato di uccidersi, ad avermi fatto toccare veramente con mano l’abisso di angoscia nel quale deve essere sprofondato quel soggetto che allora era giovane (quando fu irrogata la condanna aveva 26-27 anni), oggi è sui 58 anni. Oggi non è neanche più un adulto, è quasi un anziano. E fu allora che presi la decisione di scrivere questa storia, perché appunto, di fronte a questo abisso di disperazione, a questa volontà che si era manifestata, non era stata raccolta e quindi a un certo punto, aveva capitolato, ritenni di dover fare qualcosa. Ma cosa potevo fare come modesto cittadino in pensione? Potevo raccontare quella storia, perché raccontare una sofferenza è, in piccolissima parte, incominciare almeno a risarcirla un poco. E allora la raccontai in pochissimo tempo, in una specie di trance, credo di averlo scritto in due-tre settimane, ogni giorno, tirando fuori dallo scatolone due o tre lettere e cercando le parti significative, mettendole nel libro. E venne fuori di nuovo un ripercorrimento di questi ventisei anni, di quelle speranze, di che cosa aveva significato un gesto. Questo è la cosa veramente sorprendente: il gesto fu compiuto da me, ma lo dico con molta semplicità, suggerito da mia moglie, (perché la sensibilità delle donne è preziosa per superare la rigidità maschile). Tornato a casa dopo la sentenza, dopo lo stress veramente sovrumano che fu rappresentato dall’epilogo di questo processo gigantesco, ricordiamo che era un processo con 242 imputati, la cui Camera di Consiglio durò poco meno di un mese, in una situazione del tutto equipollente alla reclusione, perché eravamo in effetti ospitati senza possibilità di uscire nella foresteria del carcere. Bene, in questa situazione di stress, mi tornò alla mente il secondo di due fotogrammi, che mi permetto di riprendere se il moderatore mi autorizza, perché sono significativi. Ho già detto e lo ribadisco con forza, che Salvatore era il capo di questa associazione criminosa, non solo imputato di quindici omicidi, ma veramente il punto di riferimento di tutto il male di quell’ambiente e quindi, all’inizio il suo atteggiamento processuale fu estremamente ostile, ostruzionistico, bellicoso. Cionondimeno, si infilò un altro binario in conseguenza di un primo episodio che merita di essere ricordato per la morale, lasciatemi dire, che se ne può ricavare: Salvatore in una delle prime settimane, venne a chiedermi un permesso per andare a trovare la madre gravemente malata. E il giudice applicando doverosamente l’ordinamento penitenziario, avrebbe potuto concedergli il permesso, ma data la caratura criminale del soggetto, con le garanzie necessarie e cioè sotto scorta. Quando io gli dissi, “io le do il permesso, ma devo per necessità darglielo sotto scorta, sotto vigilanza”, lui mi chiese: “Lei ce l’ha una madre?”. “Sì ce l’ho e combinazione è malata anche la mia”. “Eb-bene, lei non può e non deve mandarmi davanti a mia madre morente con due carabinieri al fianco”. E il giudice fece uno sforzo di uscire dal ruolo che gli avrebbe imposto una certa cosa, rischiando qualcosa anche sul piano personale e l’imputato fece una cosa ancora più grave e significativa – essendo senza scorta poteva fuggire e avendo davanti a sé lo spauracchio dell’ergastolo, sarebbe stato comprensibile che lo facesse – uscì dal suo ruolo di trasgressore e ritornò regolarmente e me lo vidi passare davanti al suo rientro, e sul labiale gli lessi le parole “sono tornato”. Questo primo episodio fu uno dei tanti ammaestramenti che questa vicenda ha dato e cioè la necessità ogni tanto di uscire dal ruolo, rischiando. Ma il secondo episodio, quello che diede veramente causa immediata alla concezione del gesto che poi innescò tutta la corrispondenza, fu proprio alla vigilia della sentenza, quando Salvatore venne a trovarmi e a un certo punto mi disse: “Presidente, lei ce l’ha un figlio?”, io risposi: “Si, ne ho tre, il maggiore ha più o meno la sua età”. Lui mi rispose: “Lo so”, “E allora perché me lo chiede?” “Glielo chiedo perché le volevo dire una cosa: che se suo figlio nasceva dove sono nato io, forse a quest’ora era lui nella gabbia e se io nascevo dove è nato suo figlio, forse a quest’ora facevo l’avvocato ed ero pure bravo!”. Capite il messaggio che volle trasmettermi nel suo linguaggio necessariamente rustico? È un linguaggio che noi traduciamo con l’immagine di lotteria della vita: nella lotteria della vita ciascuno di noi estrae un biglietto e Salvatore aveva estratto il biglietto sbagliato. Ma oltre a quello lessi una specie di messaggio ulteriore, quello di una offerta di figliolanza spirituale, forse l’immagine è un po’ romantica, scavalchiamola, ma continuavo a essere in uno stato di profonda insoddisfazione che indusse appunto mia moglie a saltare le tante mediazioni della convenienza, dell’opportunità e della paura: “Scrivigli, scrivigli questi tuoi sentimenti” e io gli scrissi non i sentimenti che ora ho detto, ma qualcosa di molto semplice che si poteva sintetizzare in una immagine: “Quella che hai davanti è comunque la tua vita, cerca di spenderla bene anche se è molto difficile, cerca di spenderla bene, ti potranno togliere la libertà per un tempo anche lungo ma non potranno toglierti due cose se non lo vorrai: la dignità e la speranza”. Incredibilmente, mentre io mi attendevo che lui o non mi rispondesse o mi rispondesse in tono ruvido, mi rispose: “È molto bello quello che lei mi ha detto e farò quello che lei mi dice”. Da allora è iniziato questo percorso ed è iniziato in una chiave entusiasmante, Salvatore fu preso da una sorta di bulimia redentiva in quei modi semplici che il carcere consente: iscriversi a un corso; perfezionare le scuole (lui aveva solo la terza elementare perché come mi disse una volta: “Mi cacciavano da tutte le scuole”). Frequentava tutti i corsi, si dava da fare, insisteva nel dire ai vari Direttori di carcere per i quali peregrinava: “Guarda che io sono cambiato, io non sono più lo stesso, non sarò un santo ma sono cambiato”. E così era davvero, e allora questo è forse l’ultimo insegnamento che la storia, questa microstoria può offrire a chi la vuole leggere: nessun uomo è mai tutto nel gesto che compie. Alla lettera che gli mandai, io unii un libro, perché mi pareva utile dargli qualcosa di più di poche parole di circostanza e il libro che mi venne spontaneo allegare era un libro non comprato apposta ma della mia libreria ed era Siddharta, perché Siddharta contiene un’espressione affine a quella che è stata letta poc’anzi: “Nessun uomo è mai tutto Saṃsāra né mai tutto Nirvana, nessun uomo è mai totalmente santo o totalmente cattivo”. Guidato da questa, lui recuperò quella stima di sé, che è pur necessaria per impegnarsi nelle battaglie e per dieci anni, quindici anni, venti anni lottò con tutte le sue forze, arricchito o comunque, secondo quello che lui mi disse, sostenuto dall’accompagnamento. Questo è l’ultimo aspetto che posso forse utilmente sottolineare: anche se c’è la necessità di una risposta severa quando è necessario, anche in questo caso, occorre tenere presente il significato del tempo nella espiazione di una pena detentiva. Spero avremo possibilità di tornare su questo tema del tempo carcerario, che è un tempo diverso dal nostro, e il tempo è l’artefice del mutamento e quindi nel carcere occorre che il detenuto non sia solo, non sia abbandonato dal mondo esterno. Questo offre l’opportunità per un grazie a tutta quella popolazione che a titolo di volontariato o anche a titolo professionale, penso agli educatori, è nel carcere per ricordare che il detenuto, se lo vuole, non è solo. Questo integra uno degli ammonimenti più belli che mi è accaduto di leggere. È una fase di Gibran, l’autore, il poeta libanese, scritta nel Profeta, nel 1923, quindi quasi un secolo fa ma estremamente valida anche oggi: “Voi camminate insieme come in processione, voi siete la via e i viandanti, e quando qualcuno di voi cade, cade a favore di chi sta dietro di lui, un ammonimento della pietra che è all’origine dell’inciampo e cade anche per chi sta davanti a lui che, sebbene abbia piedi più veloci e sicuri, non ha tuttavia rimosso questa pietra”. Questo accompagnamento è doveroso, questa presa di coscienza della solidarietà della comunità offesa e dell’offensore è forse la chiave per una risposta possibile al problema, irresolubile altrimenti, del male e della pena.
PAOLO TOSONI:
Questo libro per me è stato proprio commovente. Si diceva stamattina, nell’incontro della giustizia riparativa, che la giustizia è relazione. Pensate che cambiamento di prospettiva, sembra una cosa di un altro pianeta che uno, che per le circostanze della vita e anche per la sua libertà si è trovato in una situazione di conflitto radicale con lo stato, con la vita, quindici omicidi, capo mafia, per quanto giovane, si affidi e faccia ripetute promesse di cambiamento a colui che lo ha condannato, a colui che gli ha dato l’ergastolo: è un rove-sciamento, la giustizia capovolta. Devo veramente ringraziare il dottor Fassone per aver come ceduto, fatto prevalere la propria umanità, la propria inquietudine rispetto all’umanità di quella persona. Non dimentichiamo che si è trovato davanti ad un ruolo delicato, perché non è per nulla scontato che il presidente della Corte di Cassazione che ha condannato, inizi un rapporto di questa natura col detenuto. Questo ci fa capire che c’è veramente una prospettiva di riparazione, di vincere il male, pur con le dovute cautele, con la legittimità di una civiltà giuridica che ha creato nel tempo il mito del processo, della giustizia, dell’attenzione anche alle vittime della giustizia. C’è però veramente una prospettiva diversa. In questa prospettiva, il problema dell’ergastolo sicuramente stride, è contraddittorio. Uno stato forte, illuminato, deve dare una seconda possibilità alla persona che dimostra di essere cambiata, di aver compreso il proprio errore e di volerlo riparare e questo significa concretamente anche una normativa che lo permetta. Anche se viviamo in un’epoca in cui, soprattutto i mass media, ma non solo, ci buttano addosso molti slogan che incitano alla vendetta, alla paura, come comprensibile reazione alle tante situazioni di devianza che ci circondano, questo non può vincere invece sulla speranza che si possano trovare forme diverse di affrontare la situazione, per recuperare uomini che sono fatti di male e di bene e che sono al fondo tutti uguali. Mi ricordo in una mostra delle carceri che avevamo proposto tanti anni fa, la scoperta di un detenuto, che si chiamava Joshua, il quale diceva: “Il cuore dell’uomo è veramente uguale, il cuore è uguale in ogni uomo”. E questo è il punto di partenza. Do la parola adesso al dottor Gherardo Colombo. Il dottor Gherardo Colombo è stato magistrato, noi ci siamo conosciuti ai tempi di Tangentopoli in qualche interrogatorio, e posso assicurarvi che io ero contento di fare gli interrogatori col dottor Colombo, perché era quello con cui si riusciva a gestire meglio l’interrogatorio e in quei momenti non era semplice; poi è stato anche in Cassazione e ha infine deciso di uscire dalla magistratura per dedicarsi a un tipo di attività diversa, ma che ha come scopo quello di tentare di risolvere i problemi della giustizia e della legalità. Ce lo racconterà di persona. Grazie.
GHERARDO COLOMBO:
Vediamo se riesco a stare nei tempi, perché non è facile, ci sono tante cose da dire. La prima è che sono molto contento di esser qui e sono molto contento di esser qui a parlare di questi argomenti e di questi temi, per cui vi ringrazio molto dell’invito. La seconda è che avete potuto constatare tutti qual è lo spessore di Elvio Fassone. Io Elvio lo conosco da quarant’anni credo, insomma ne è passato di tempo. Sono entrato in magistratura nel 1974, credo che ci siamo conosciuti più o meno subito perché Elvio era un punto di riferi-mento, era una maestro, io ho imparato tante cose da lui e ce n’erano anche degli altri per fortuna. Elvio è sempre stato speciale, una grandissima capacità di guardare fuori ma di guardarsi anche dentro e questa è una testimonianza, io sono molto scosso devo dire, perché è una testimonianza di un valore a mio parere notevolissimo, non succede a tutti i giudici di avere questa esigenza, se mi permetti Elvio, di dare il la ad un percorso di giusti-zia riparativa, perché, secondo me, quello che hai fatto tu è stato proprio un percorso di giustizia riparativa. Lo diceva anche lui che è stato stressato, provato, da questo processo così lungo, da questo svolgimento di una funzione che ha comportato che infliggesse vari ergastoli. Non tutti i giudici sono uguali, c’è chi sente il peso, perché è un peso forte, di costringere altri a rimanere in carcere in questi casi per tutta la vita, così come c’è il peso della consapevolezza di costringere quelli che stanno intorno, che non hanno fatto niente, c’è la fidanzata Rosy per esempio, a subire una privazione che è senza colpa, senza responsabilità. E allora non stava bene, e lo dice, quando il processo è finito, perché aveva bisogno di essere capito da chi ha subito la condanna, è lì il percorso è cominciato e ha prodotto gli effetti che, secondo me, un percorso del genere prima o dopo è destinato a produrre sempre, quello di riuscire a comprendere che di fronte a te c’è un’altra persona. Ci sono le ultime parole, quelle che ci fanno capire, io spero, che la persona non sta mai soltanto nel gesto che compie, perché la sua vita è una specie di film e noi tendiamo a guardare soltanto la fotografia. Io credo che noi dobbiamo porci il problema di che cosa sia la giustizia, perché siamo legati a una serie di stereotipi incredibili e infiniti, secondo i quali, bene o male, in qualche misura continuiamo a collegare la giustizia alla vendetta. E non ci accorgiamo neanche che sia così: che il processo penale così come è fatto in qualche misura tuteli la vittima, è forse una reminiscenza dell’università, ma poi non corrisponde mica tanto alla realtà che viviamo tutti i giorni. Allora, che cos’è la giustizia? Perché se noi pensiamo che “giustizia” sia la considerazione dell’altro, allora dobbiamo veramente rovesciare la concezione che abbiamo dentro che ci marca così profondamente, non geneticamente ma culturalmente, talmente tanto da non riuscire ad uscire da una prospettiva che si contraddice per arrivare a qualche cosa di diverso. Questa mattina Marta Cartabia, introducendo, ha usato un termine, “dignità”, che è il termine che ha segnato la seconda metà del secolo scorso. Appena prima che la seconda metà del secolo scorso iniziasse, si è arrivati a una concezione diversa dello stare insieme. Fino ad allora insieme si stava avendo come punto di riferimento essenziale, come “valore”, la discriminazione per una serie di motivi che hanno avuto il loro culmine, io credo, in tre eventi: la Seconda guerra mondiale, la Shoah e l’uso della bomba atomica. Si è finalmente arrivati a pensare «forse, così non possiamo andare avanti: se continuiamo a discriminarci reciprocamente ci annulliamo, ci distruggiamo, non abbiamo un futuro». Credo che sia stata quella la molla che ha spinto prima il Costituente, poi l’Assemblea delle Nazioni Unite e poi ancora il Consiglio d’Europa a incentrare il nostro stare insieme sul riconoscimento della dignità altrui. Guardate che si tratta proprio di un capovolgimento. E allora proviamo a pensare: se la giustizia tradizionale, quella che abbiamo ereditato dai periodi precedenti, aveva come fondamento, come giustificazione la discriminazione, nel momento in cui noi rifiutiamo, ripudiamo la discriminazione e assumiamo come punto di partenza le pari opportunità, cioè il riconoscimento della dignità uguale di tutte le persone, forse dobbiamo anche porci qualche problema a proposito del fatto se sia possibile continuare ad avere l’idea e a praticare il tipo di giustizia precedente. Voi forse lo sapete o forse no, ma il nostro Codice Penale risale al 1930, quando la discriminazione era imperante: possiamo ancora pensare che il nostro Codice Penale sia coerente con il rovesciamento che è intervenuto dal 1946 fino a pochi anni dopo? Rovesciamento consistito nel ripudiare la discriminazione e nell’adottare la dignità universale. Io credo che dobbiamo porci un problema sotto questo profilo. Continua ad essere adeguata a questo nuovo riferimento una giustizia che ha come risposta usuale la punizione? Consistente, peraltro, nella negazione della dignità delle persone? Secondo me sta anche in questo, il tuo turbamento così grande, la ricerca di una legittimazione, l’essere nella condizione di dover cercare. Elvio ha cercato il suo condannato per avere una riconciliazione. Stava male: se non avesse scritto quella lettera, seguendo il consiglio della sua saggia consorte, avrebbe sofferto; lui, che in una specie di rovesciamento) delle posizioni – si riteneva forse “colpevole” di aver tolto la libertà a quella persona -, stava male. E chi poteva “assolverlo”? Soltanto lui. Ecco, questo è il senso della giustizia riparativa. Io credo che possa anche convivere con la giustizia tradizionale purché, però, la giustizia tradizionale subisca, o meglio, sia arricchita da così tante e profonde modifiche da non apparire più quella che è. Io credo che noi siamo strani. Vediamo se riesco a farmi inten-dere. Noi molto frequentemente pratichiamo sistemi di giustizia riparativa nell’ambito della nostra vita quotidiana nei confronti delle persone che ci circondano: non è che se un figlio ci fa un torto, allora noi lo ripudiamo, no? Delle volte c’è qualcuno che lo punisce, tante volte c’è qualcuno che cerca invece di recuperarlo – meglio che recuperare il figlio, recuperare il rapporto -. Il recupero del rapporto consiste in una procedura di riparazione, di giustizia riparativa. Lo facciamo anche in altre situazioni: metti che uno ti tagli la strada mentre stai camminando tranquillamente e ti viene (perché a me viene sicuramente) da fargli sapere che non gradisci per niente il suo comportamento e ti viene da farglielo sapere magari con una certa violenza, verbale perlomeno; basta che quello si giri e ti chieda scusa, che tutto questo immediatamente si acquieta – magari continui ad essere un pochino arrabbiato, ma quella reazione così forte, che prima ti spingeva, è completamente sparita. Il sistema della giustizia riparativa lo conosciamo perché lo pratichiamo chissà quante volte, nei confronti del partner: non è che tutte le volte in cui uno esce di casa e torna c’è la moglie che dice «hai comprato il pane?», «no che non l’ho comprato, non mi hai detto di comprare il pane», «come non ti ho detto di comprare il pane? Guarda che te l’ho detto dieci volte», «no che non me l’hai detto!», eccetera. Non è che si finisce sempre a coltellate – qualche volta sì, ma per fortuna è raro (è comunque sempre troppo frequente). Perché? Perché si riesce a recuperare quella relazione che persino dalla disputa sull’acquisto del pane può essere irreparabilmente messa in discussione. Allora, questo deve insegnarci qualche cosa anche per altri settori. Perché per chi ha commesso un reato – tra l’altro per tutti, indifferentemente, chi ha rubato una macchina, chi ha tentato di rubarla, chi ha ucciso una persona, e via dicendo – si deve usare questo, o avere in mente, questo cliché secondo il quale chi ha fatto del male deve subire del male? Sembra che ci siamo fermati ad Hammurabi, poi qualche cosina è cambiata, ma soltanto i dettagli: «Occhio per occhio, dente per dente», che, diceva Mahatma Gandhi, rende il mondo cieco. Perché dobbiamo vedere come legittima una risposta di questo tipo quando una persona commette un atto che contrasta con il Codice Penale? Io non voglio considerare qui altri aspetti, perché anche i reati cambiano: qualcosa che oggi consiste in un crimine, domani invece no. È successo. Fino a quando la Corte costituzionale non è intervenuta, l’adulterio femminile era reato, oggi non è più reato, da un bel po’ per fortuna. Perché dobbiamo avere questa visione in quel campo? Forse c’è una matrice profonda, che deriva da una cultura quasi esasperante, per cui anche altrove noi vediamo la vendetta come un principio comportamentale. Ma forse c’è anche dell’altro, chi lo sa: magari il carcere è liberatorio, nel senso che ci consente di sentirci sicuri, sicuri della nostra innocenza. Se vediamo che chi è cattivo sta di là, vuol dire che noi che stiamo di qua siamo buoni – è molto rassicurante tutto questo, caspita se è rassicurante -. Facciamo un po’ fatica a pensare anche soltanto di fare a meno del carcere, perché delle volte è anche difficile distinguere il bene dal male, allora abbiamo bisogno di elementi esterni per cercare di rassicurarci ancora una volta. Pensate come sarebbe diverso se, seguendo peraltro la falsariga della nostra Costituzione (che è stata scritta ormai sono quasi settant’anni, tra quattro o cinque mesi compie i settant’anni di entrata in vigore), fosse vero quello che la Costituzione ha scritto, quello che chi ha scritto la Costituzione ha stabilito per tutti – partendo ancora una volta da quella affermazione «tutte le persone (c’è scritto “cittadini”, ma vuol dire “persone”) hanno dignità (“sono importanti” volgarizziamo, e sono importanti allo stesso modo)». Bene, seguendo quello, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Allora, non può esistere carcere, secondo la Costituzione italiana, che non garantisca (perché al-trimenti si tradisce il senso di umanità) lo spazio vitale, l’igiene, la salute, l’istruzione, il la-voro, l’affettività, e poi si potrebbe ancora andare avanti: «È punita qualsiasi forma di vio-lenza fisica o psicologica nei confronti di chiunque la cui libertà sia comunque limitata». Non si chiama più “carcere”. Se il carcere fosse quello previsto dalla Costituzione, allora sì potrebbe andare d’accordo con la giustizia riparativa, perché si tratterebbe del momento in cui chi, in mancanza di una misura del genere, potrebbe rendersi pericoloso nei confronti degli altri. Sarebbe una cosa completamente diversa. Intanto, però, guardate che la Costituzione parla di carcere in un’occasione soltanto: l’art. 13, la carcerazione preventiva. Per il resto quando parla di pena non fa riferimento al carcere, quindi si sono potute sviluppare delle forme di sanzioni alternative al carcere come: l’affidamento in prova ai servizi sociali, la messa alla prova, la detenzione domiciliare, i lavori di pubblica utilità e così via. Proviamo a pensare a un complesso di risposte alla devianza, alla trasgressività in cui il carcere sia effettivamente, come poi di fatto chiede la Costituzione, la ratio estrema, l’ultima misura, quando tutte le altre – il Codice di Procedura penale, peraltro, lo richiede – sono inadeguate a tutelare la collettività. Allora sì, forse, riusciremmo a far coincidere quel che è risultato dal mutamento del punto di riferimento con quel che serve per fare in modo che questo nuovo punto di riferimento sia rispettato. Lì lo spazio per la giustizia riparativa, secondo me, è immenso.
PAOLO TOSONI:
Concedetemi la battuta, non sembra di aver sentito parlare un pubblico ministero di Mani pulite. Invece, la cosa molto interessante – e il metodo di cui accennavo prima è anche in questo caso lo stesso – è proprio in forza dell’esperienza che il dottor Gherardo Colombo ha vissuto in quella e in altre situazioni, che ne ha colto anche gli aspetti fallimentari, inefficaci, che lo ha fatto riflettere su ciò che effettivamente può permettere ad una persona, dentro un cammino dignitoso, di riprendere in mano la propria vita, pur dopo aver commesso degli errori. L’immagine del carcere (che lui non vorrebbe neanche più chiamare “carcere”) che ci ha trasmesso, anche in forma molto semplice, è un’immagine di cui, in alcune situazioni un po’ sperimentali – soprattutto laddove c’è una forte presenza di volontari che tentano di rendere e umanizzare il carcere – abbiamo anche qualche esempio. In quegli esempi (purtroppo pochi) che ci sono in Italia, effettivamente notiamo alcune cose straordinarie, come è stato richiamato anche questa mattina: una recidiva che si abbatte. Perché è ovvio che il carcere non può che essere una scuola di criminalità, se una volta entrato sei trattato come una bestia o poco meno e non ti è data nessuna possibilità di immaginare qualcosa di diverso dal reiterare il crimine, non ti è data nessuna possibilità di imparare un mestiere… Mi è venuta questa riflessione banalissima. Sono andato via qualche giorno e mi avevano proposto di stare in camera con altri: un tempo non avevo problemi, ma alla mia (grazie a Dio non ancora veneranda) età, la cosa un po’ ti infastidisce («Chi è? Russa? Non russa?»). Immaginatevi che questa gente è costretta a convivere in una situazione veramente di ristrettezze e di condizioni igieniche difficilissime (con cinque, sei, sette persone nella stessa cella, che non ti sei certamente scelto). Diventano condizioni quasi disumane, dove certamente la persona peggiora, non è aiutata a cambiare, a migliorare. Cosa succede: esci, non sai un mestiere, ti sei abbruttito, ti sei incattivito e reiteri. E qui ecco il problema dell’alto livello di reiterazione, che anche in Italia raggiunge soglie dell’80%. Laddove i detenuti vengono sostenuti, accompagnati, aiutati, non vengono giudicati per quello che hanno fatto, ma per quello che valgono come persone, per la loro dignità, il problema della reiterazione si abbatte addirittura a percentuali che arrivano al 10%. È una rivoluzione. Come si fa a non capire che non è conveniente per la nostra società? Anche dal punto di vista economico, perché un detenuto costa: il crimine è un costo elevatissimo per la società, anche solo economicamente. Volevo chiedere al dottor Fassone (per fare un breve giro ancora sulle nostre riflessioni): perché è così difficile socialmente, politicamente, secondo te, parlare come abbiamo fatto stasera qui tra di noi di ergastolo, riflettere sull’ergastolo, sull’ergastolo ostativo o sul rendere il carcere veramente più dignitoso sostenendo il volontariato? Tutti lo dicono a parole (sulla prima parte, ergastolo sì o no, «no»; sul volontariato, «sì, sì»), ma poi dopo concretamente si incontrano enormi difficoltà. Perché è così difficile? Tu hai fatto anche il politico, cosa pensi? Qualcosa lo dici anche nel tuo libro. Aiutaci a capire.
ELVIO FASSONE:
Perché è così difficile? Aprite il giornale: i fatti di Barcellona, l’autore di quattordici omicidi, un anno fa la Promenade di Nizza ottanta e passa, i femminicidi, le corruzioni gigantesche, gli incendi di quest’estate. Siamo davvero disposti a dire che l’uomo non sta tutto in quel gesto? Certo, dobbiamo essere disposti, ma non subito. Quando dicevo “sarà bene tornare sul problema del tempo penitenziario”, intendevo dire proprio questo: c’è un tempo del delitto e un tempo dell’espiazione. Il tempo del delitto non colpisce soltanto la vittima, anzi, mi preme dire subito, perché è una risposta parziale alla tua domanda, che i delitti con vittima individuale sono un’esigua minoranza. La maggior parte dei delitti sono senza vittima identificabile o, se c’è, è eventuale, penso allo spaccio della droga, penso ai delitti ambientali, penso alla corruzione, sono innumerevoli i delitti senza vittima. Mentre in tutti i delitti, almeno quelli di una certa gravità, c’è quello che non io ma Dostoevskij, chiama “lo scisma”. Il delitto grave produce una frattura fra l’autore e la comunità. Se ci riflettiamo, Raskolnikov è il soprannome che appiccica Dostoevskij al nome Rodion e vuol dire “scismatico”. Con il delitto, l’autore si mette fuori dalla comunità, produce uno scisma che bisognerà ricucire, ma intanto arreca un trauma profondo alla comunità. Ecco perché al delitto bisogna dare una risposta, poi sono d’accordo che non deve essere necessariamente il carcere, ma una risposta va data, se non altro per confermare la collettività nella sua fiducia nei valori che il crimine ha offeso. Ecco perché c’è un tempo del delitto e io considero veramente sgradevole, per fortuna è in via di diminuzione il fenomeno, quell’episodio del cronista che va davanti al congiunto del morto chiedergli: “Lei è disposto a perdonare?” Come si può pretenderlo adesso? Adesso c’è il profondo trauma che il delitto ha arrecato in tutti. A questo delitto la storia del genere umano ha risposto in un primo tempo con la reazione vendicativa e questo davvero va superato, ed è stato superato idealmente quando la reazione è stata affidata a un soggetto terzo, meglio ancora se questo soggetto terzo è davvero un soggetto che rappresenta la comunità, sia pure a livelli ideali. Poi c’è il tempo dell’espiazione. E nell’espiazione devono maturare tutti, non solo il condannato ma anche la comunità. Il condannato, perché il tempo ci lavora inevitabilmente, ci lavora sia a livello biologico, ogni giorno una parte delle nostre cellule si rinnova, ma soprattutto ci lavora a livello mentale. Se noi guardiamo come eravamo cinque anni fa e tanto più dieci anni fa, vent’anni fa, eravamo profondamente diversi ed è del tutto giustificato che sia possibilmente diverso anche il reo, l’autore del crimine. Ecco perché queste due istanze, quella della comunità di essere confermata nei suoi valori offesi dal delitto e quella del recupero dell’umanità che c’è nel condannato possono e devono integrarsi. Una delle forme è stata egregiamente illustrata questa mattina e ancora oggi da Gherardo e non soltanto nelle parole che ha detto poco fa ma nel suo bel libro sul perdono responsabile. Una delle forme di ricucitura dello scisma è la mediazione e conseguentemente il perdono. Non dimentichiamo l’etimologia di perdono: un dono intensivo, il massimo dei doni. Quando io dono un oggetto, dono qualcosa di esterno a me, ma quando dono il perdono, cioè il massimo del dono, mette a tacere quel risentimento che è inevitabile, perché noi siamo figli del cervello rettilario che abbiamo nella parte profonda della testa, noi siamo intrisi di violenza, perché nel periodo cambriano, quando dalle unicellulari siamo passati ai corpi, agli organismi pluricellulari, è nato il bisogno di mangiare e di non essere mangiati e gli istinti che abbiamo elaborato allora, sebbene siano passati cinquecento milioni di anni, sono ancora nel profondo di noi stessi. Ma noi abbiamo anche maturato l’idea della evoluzione nostra e quindi dobbiamo seguire il percorso del reo, sapendo quello che è stato ricordato, che appunto nessun uomo è mai tutto nel gesto che compie e nessun uomo è mai necessariamente uguale a se stesso. Allora questa giustizia riparativa, come possiamo dilatarla in modo da arrivare a coprire anche quella elevata percentuale di situazioni penalmente rilevanti che non consentono un incontro tra offensore e vittima e che statisticamente sono molto am-pie? Io credo che dobbiamo passare attraverso il mito di Caino letto modernamente. So di parlare a un uditorio che è attento a questi temi e a queste fonti che ci guidano. Caino è un mito ed è il mito di una giustizia diversa che ha in sé il concetto di giustizia riparativa, perché se noi analizziamo appunto in chiave moderna questo mito del Genesi IV, vediamo che ci sono, possiamo dire, alcuni fotogrammi successivi. Il primo fotogramma è la contestazione dell’addebito, diremmo noi giuristi, “che hai tu fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me”. Contestazione dell’addebito in termini di severità, è Jahvè che è severo, guarda che hai fatto una cosa gravissima. Secondo fotogramma è l’ammissione della colpa. Noi oggi sentiamo che tutti gli imputati sono sereni perché negano la responsabilità e sono fiduciosi nella magistratura. Caino la pensa diversamente, “davvero grande è la mia colpa, adesso qualcuno, chiunque che mi vedrà mi potrà uccidere, io me ne andrò ramingo e chiunque mi vedrà mi potrà uccidere”. Questa è la giustizia dell’uomo ma subentra il terzo fotogramma che è la giustizia di Jahvè: “Non sarà così. Tu te ne andrai ramingo ma io metterò un segno su di te e chiunque ti vedrà non ti ucciderà e se ti ucciderà sarà punito sette volte tanto”. Quindi la giustizia di Jahvè è superiore a quella umana, lo ricordiamo sempre. Ma poi c’è un quarto fotogramma normalmente trascurato: “E allora Caino se ne andò ramingo nella terra di Nod, che è di fronte all’Eden, conobbe sua moglie la quale partorì Enoch e Caino divenne costruttore di città”. Caino divenne costruttore di città. Il massimo del crimine con il massimo dell’impegno, chiamiamolo sociale. Ed ecco allora una possibile, e secondo il mio modesto parere, necessaria via d’uscita per arrivare a quella tesi che Gherardo sostiene con particolare calore, cioè ridurre di molto il carcere. Attualmente la giustizia riparativa esiste ma esiste in ambiti limitatissimi. Per intanto vogliamo ancorarla, se mi consenti ancora pochi secondi, a un’immagine forte, perdonatemi l’uso del latinorum ma molte volte questa lingua è più pregnante, più incisiva della nostra. I giuristi dicevano che si punisce malum passionis propter malum actionis. Hai fatto del male, subisci del male. Questa simmetria ripristina quell’equilibrio che con il delitto hai speso. I giuristi di oggi, o meglio la sensibilità auspicata da Gherardo questa mattina e tutto sommato anche da me, sostituisce questo brocardo con l’altro: bonum actionis propter malum actionis. Hai fatto del male, adesso fai del bene. Il perno della prima antitesi è malum, l’hai fatto, lo subisci. Il perno della seconda antitesi è l’actio: hai fatto del male, adesso fai del bene. Ecco dove possiamo e auspicabilmente dobbiamo indirizzare la politica penale, perché appunto la politica nel senso elevato della parola è la comprensione di un fenomeno nella sua complessità. Noi tutti vorremmo che offeso e offensore si trovassero e si stringessero la mano, ma tante volte questo non è possibile e allora ecco che se noi spingiamo più convintamente sul pedale della giustizia riparativa in cui l’interlocutore non è un offeso individuo che non c’è ma è la comunità che c’è sempre come soggetto offeso, come altra parte dello scisma, riusciamo a ricomporlo. Oggi come oggi l’ordinamento conosce troppo poco la giustizia riparativa nelle prestazioni a beneficio non di un individuo ma a beneficio della collettività intera, la conosce soltanto nella giustizia del giudice di pace che è una giustizia piccolina, vale pochissimo. La conosce nella materia degli stupefacenti e la conosce nella legge sul razzismo. Se non vado errato ci sono solo quelle, comunque sono ra-rissime e assai poco applicate. Lo sforzo della politica credo debba essere indirizzato pro-prio ad aumentare questo, il che non è una cosa facile, me ne rendo conto perché, avendo avuto una qualche parte attiva nella stesura, nell’articolazione della giustizia del giudice di pace, che è del 2000, il Decreto Legislativo 286 del 2000, sono passati diciassette anni e non ha avuto quasi attuazione se non molto sporadica. È infatti molto complessa, perché bisogna far dialogare e dialogare proficuamente e concretamente il Ministero, l’Amministrazione penitenziaria, la Magistratura di sorveglianza, l’Ente locale che deve finanziare, l’Ente locale che deve presentare un programma di interventi di pubblica utilità che non si limitino a mettere in ordine la biblioteca, perché mandare uno stupratore a mettere in ordine la biblioteca del sindaco mi sembrerebbe una cosa lievemente rischiosa e offensiva per la vittima. Questi interventi devono essere articolati attraverso momenti di formazione, perché non tutti i detenuti sono in grado di fare tutto, anzi la maggior parte non lo è perché occorre un finanziamento che sarebbe comunque inferiore al costo della manutenzione in carcere. Io l’ho sperimentato in alcune piccole situazioni quando la comunità, a fronte di un banale taglio dell’erba dei giardinetti della stazione, diceva “ecco, se fosse così io sarei davvero d’accordo”. Questo diciamo che è il capitolo che ci attende al di là delle mozioni pur necessarie che sono state calate con abbondanza nell’ascolto di oggi.
PAOLO TOSONI:
Do la parola ancora per cinque minuti al dottor Gherardo Colombo. Mi permetterò di rac-cogliere poi alcuni spunti alla fine per concludere. Solo questo: si è parlato di espiazione, di tempo, di perdono. Gherardo, mi puoi dire quello che vuoi, però mi piacerebbe anche capire nella tua esperienza, anche passata, perché questo in realtà nel sistema che tu ov-viamente contrasti almeno dal punto di vista del giudizio, non è stato possibile? Questa situazione ti ha addirittura fatto dimettere dalla Magistratura.
GHERARDO COLOMBO:
Spero di essere rapidissimo. Credo di non essere stato sufficientemente chiaro quando ho parlato di discriminazione, nel passaggio dalla discriminazione all’apprezzamento della dignità pari di tutti. Discriminazione vuol dire strumentalizzazione della persona. La persona è strumento e quindi se ti comoda è schiavo, la donna è sottomessa, chi ha una religione diversa viene mandato via, ok? Questo per precisare soltanto. Seconda precisazione importante: guardate che il percorso di giustizia riparativa è un percorso che personalmente costa e costa anche di più della sofferenza indubbia che si subisce rimanendo in carcere. Costa, costa come emozione, costa come messa in discussione di se stessi, costa come sforzo e fatica che si fa per andare incontro all’altro. Ammettere la propria colpa, la propria responsabilità, non è una cosa semplice. E vengo alla sollecitazione. Io ho fatto un percorso, prima l’avvocato Tosoni ha fatto questa battuta dicendo “non sembra proprio il pubblico ministero di Mani pulite”. Non è che allora andassi in giro con il coltello tra i denti, però io ho passato nel penale trentatré anni, ho cominciato da giudice, ho fatto tre anni il giudice di dibattimento. Ho cominciato ad avere delle difficoltà, ho chiesto quindi di passare all’ufficio istruzione che non esiste più, quando, essendo allora molto in voga il sequestro di persona, condannare ogni due giorni su tre a venti, ventidue anni di reclusione mi diventava pesante. Faccio il giudice istruttore per un periodo consistente, durante il quale scopriamo insieme a Giuliano Turone la P2: grandi speranze di riuscire a fare emergere il crimine non da strada, non della povera gente, non i crimini passionali ma quelli veramente seri, con la convinzione che, per quanto non mi sia mai piaciuta la prigione, comunque fosse un sistema educativo, aiutasse ad educare. La P2 va a finire come va a finire, gli atti vengono portati a Roma dalla Cassazione, non si scopre il sistema della corruzione che, se fossero rimasti a Milano gli atti, avremmo scoperto senz’altro. Mi succede lo stesso con i fondi neri dell’IRI, poi arriva Mani pulite. Insomma, progressivamente ti accorgi che questo sistema non serve per riuscire a rendere giustizia. Io ho cominciato che la giustizia funzionava malissimo, me ne sono andato che la giustizia funzionava probabilmente ancora peggio. Mi sono trovato ad un certo punto come un idraulico che la mattina viene chiamato da un signore perché quando apre il rubinetto l’acqua non esce. Arriva l’idraulico, comincia a lavorarsi il rubinetto, smonta di qua, rimonta di là, cambia, sostituisce, non c’è niente da fare, l’acqua non arriva. Allora pensa “magari c’è qualcosa da guardare prima del rubinetto per fare arrivare l’acqua”. Segue le tubature, arriva in cantina, si trova davanti al rubinetto centrale, quello che porta acqua a tutti i rubinetti del condominio, ritira fuori i ferri, si rimette a lavorare, chissà quanto lavora ma alla fine torna in cucina, apre il rubinetto e l’acqua esce. Ecco, io per trentatré anni ho lavorato sul rubinetto della cucina. Per quanti sforzi si facessero, la giustizia funzionava malissimo. Ad un certo punto mi sono chiesto “ma non è che c’è qualcosa da guardare prima dei palazzi di giustizia, i tribunali, le corti d’appello, gli avvocati, i magistrati, gli imputati, le sentenze, eccetera?” Mi sono guardato in giro e ho trovato il rubinetto centrale che è la relazione che esiste tra noi e le regole, se non le capiamo. Se non riusciamo a comprendere il perché di queste regole, quelle che mettono al primo posto ciascuno di noi, se non le capiamo non le osserviamo e allora facciamo i disastri che stiamo facendo continuamente. Il problema è prima di tutto un problema di modo di pensare, poi viene l’amministrazione della giustizia, che deve essere però secondo me figlia del modo di pensare. Io di difficoltà ce ne avevo, caspita, come le hai avute tu ma per me era un dramma. Tutte le volte in cui, per fortuna non spessissimo, ma veniva, quando facevo il giudice istruttore, arrivava il pomeriggio una mamma con un bambino di tre anni, quattro anni, per mano e mi chiedeva il permesso di colloquio per il marito che era in carcere per rapina, se io avevo potuto trovare una legittimazione per il fatto che quella persona stava in carcere, a dove la trovavo la legittimazione ad aver tolto il padre a quel bambino? Più vado avanti e più vedo quel che produce il carcere. Il 69-70 per cento di recidiva vuol dire che due persone su tre che escono dal carcere commettono nuovi reati. E noi ci illudiamo che questo serva alla nostra sicurezza, ci illudiamo che serva alla nostra sicurezza. Ma a prescindere da questo, proprio la questione personale che riguarda le relazioni con gli altri in generale, da dove ti viene il potere di far male ad altri? Perché rompere le relazioni è comunque fare male. E allora per questo io vi dico “riflettiamo, vediamo un po’ se riusciamo, con il tempo, perché non è che domani si possa cambiare”. Però attenzione, è necessario che ci sia una meta, che si vada verso un obiettivo e un obiettivo preciso, non possiamo, come ci succede molto spesso di fare, dire “io voglio arrivare là” e poi prendere la strada che va da un’altra parte, perché se no non ci arriveremo mai.
PAOLO TOSONI:
La prima riflessione è che bisogna avere un obiettivo ma innanzitutto bisogna avere uno scopo comune e il fatto che anche negli interventi dei nostri ospiti sia emerso che il nostro scopo è quello di riaffermare coraggiosamente e senza sconti la dignità della persona, in qualsiasi situazione essa sia, questo è veramente ciò che ci unisce, laici e religiosi, cristiani o altro che si sia e questo è veramente un grande valore. E poi siamo tutti chiamati a lavorare, ognuno nel proprio ambito. Volevo chiudere con questa raccomandazione all’impegno che papa Francesco ha fatto il 23 ottobre 2014 alla Delegazione dell’Associazione Internazionale Diritto Penale. Sono poche parole ma che non possiamo dimenticare: “Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare, non solo per l’abolizione della pena di morte – sappiate che parlava a livello internazionale – legale e illegale che sia, in tutte le sue forme ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà”. E questo io lo collego con l’ergastolo. Nel Codice penale del Vaticano non c’è più l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di morte nascosta. Siamo tutti chiamati a collaborare affinché le cose che ci siamo detti questa mattina e oggi pomeriggio nel tempo possano diventare realtà. Grazie a tutti. Devo darvi un avviso: come sapete il Meeting si regge esclusivamente sul volontariato e ha costi significativi e quindi sollecito tutti a dare con estrema libertà, poco o tanto che sia, un piccolo contributo ai banchetti contraddistinti dalla sigla “Dona ora” per sostenere l’opera del Meeting. Grazie ancora e buona serata e grazie soprattutto ai nostri ospiti.