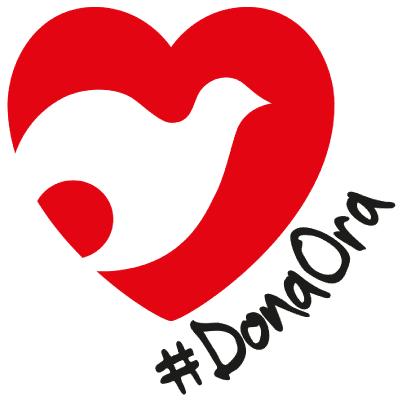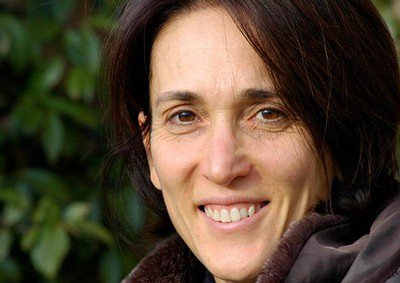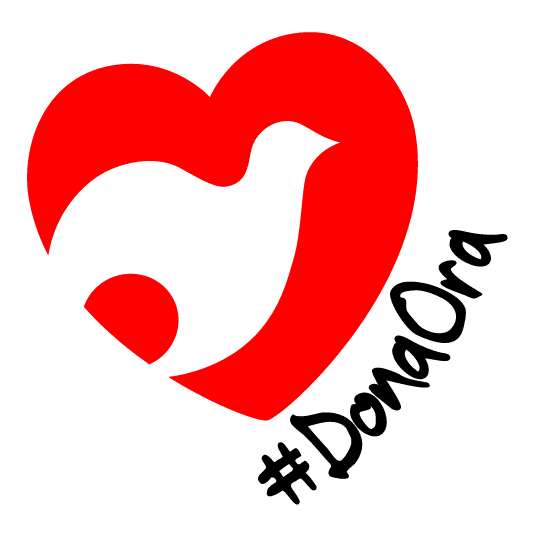Chi siamo
ESPERIENZE ALLA PROVA. INCONTRO CON…
Esperienze alla prova. Incontro con...
24/08/2011 ore 15.00Partecipano: Fabio Cavallari, Giornalista e Scrittore; Bernard Dan, Neuropsichiatra e Direttore de Höpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles; Mariangela e Riccardo, Genitori di Giulia Ribera d'Alcalá. Introduce Davide Perillo, Direttore di Tracce.
Partecipano: Fabio Cavallari, Giornalista e Scrittore; Bernard Dan, Neuropsichiatra e Direttore de Höpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles; Mariangela e Riccardo, Genitori di Giulia Ribera d’Alcalá. Introduce Davide Perillo, Direttore di Tracce.
DAVIDE PERILLO:
Allora, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questo incontro. C’è una positività nella realtà, una promessa di bene nella realtà, per il fatto stesso che esiste, così grande che per sua natura ha una forma a volte misteriosa, diversa dalla misura a cui siamo abituati. C’è un bene nella realtà che è tutto da scoprire. C’è una promessa di bene che va scoperta nella vita, che può essere scoperta nella vita. E nella storia, quando è entrato l’avvenimento cristiano, è entrata la possibilità di riscoprire continuamente questa positività, questo positivo che c’è nel reale. Possiamo scoprire, come ci ricordava il professor Esposito ieri, che la realtà è amica, che non un caso, ma il significato, il logos, diceva lui, è diventato amico delle circostanze. Allora, che cosa succede quando diciamo di sì a questo mistero? Che abbracciamo la vita, che possiamo abbracciare le circostanze, anche quando si presentano sotto forma di un imprevisto, magari un imprevisto doloroso. Questa è la storia di Giulia, che è al centro dell’incontro di oggi, dell’esperienza che mettiamo alla prova oggi. Giulia è la figlia di Mariangela Fontanini e di Riccardo Ribera d’Alcalà, ed ha questa caratteristica: che si è presentata nella vita, si è affacciata nella vita con un imprevisto, una malattia, una disfunzione cerebrale grave, seria, diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza. Quando ci si è accorti di questo, il consiglio dei medici che si stavano occupando della bimba è stato brutale: abortisca, perché non potrà mai essere felice, non potrà mai vivere una vita degna. E c’è un problema: che oggi Giulia ha otto anni, è viva, è felice, come vedremo dopo, come ci racconteranno loro, e contraddice quell’errata certezza. Allora noi vogliamo farci raccontare da loro, da Mariangela e da Riccardo, il percorso che ha permesso a loro di dire di sì a questo imprevisto e che cosa hanno imparato man mano dalla storia di Giulia. Che cosa stanno imparando oggi dalla storia di Giulia, come all’interno di questo percorso, proprio questo sì che viene detto alla realtà, a questa positività ultima del reale, permette che accadano incontri, scoperte. Uno degli incontri che hanno fatto loro è stato quello con il professor Dan, che vediamo qui alla mia sinistra e che vi prego di salutare con un applauso. Bernard Dan è un neurologo pediatrico di chiara fama e lavora a Bruxelles, presidente dell’Accademia Europea per la Disabilità Infantile, insomma è un medico di vaglia, non è un medico cattolico, ma di fronte alla storia di Giulia, si è imbattuto in qualcosa che gli ha cambiato la vita. In qualche modo è entrato nel suo modo di pensare, di guardare le cose. E quindi chiederemo anche a lui che cosa ha voluto dire, che cosa sta volendo dire per lui il rapporto con questa bimba. E un altro incontro, che è stato fatto man mano nella storia di Giulia, è quello con Fabio Cavallari, che invece è un mio collega, fa il giornalista, si è imbattuto in questa vicenda per raccontarla in un libro, di cui parleremo dopo. Ecco, a lui chiederemo che cosa ha voluto dire per lui, che cosa ha imparato lui, sta imparando lui nel rapporto con Giulia. Però, dato che la protagonista è lei, vediamola, anzitutto. Vediamo che faccia ha, che volto ha e che letizia c’è sul volto di questa bimba. Vediamola.
(VIDEO E MUSICA)
DAVIDE PERILLO:
Ecco, quella è la faccia e la vita della bambina che non doveva esserci, che non avrebbe mai potuto avere una vita felice, che non avrebbe potuto muoversi, vivere, ecc. Invece c’è.
Allora io volevo chiedere a Mariangela – che come Riccardo sono anche quasi colleghi: lavorano entrambi al Parlamento Europeo a Bruxelles – volevo chiedere, prima a Mariangela, che cosa ha fatto sì che di fronte a quella proposta così brutale, “è impossibile che viva”, lei invece abbia detto sì a Giulia, al Mistero che si presentava con il volto di Giulia. Che cosa le ha fatto dire sì a sua figlia, e che cosa è nato da quel sì? Mariangela.
MARIANGELA FONTANINI:
Grazie Davide. Comincio magari raccontando brevemente la storia di Giulia e quindi, nel seguito, poi, ti darò la risposta anche a questa domanda. La storia di Giulia comincia nel 2002. Noi vivevamo da parecchi anni a Bruxelles, per ragioni professionali, come hai detto tu, lavoriamo al Parlamento Europeo, io, mio marito e le nostre altre due figlie gemelle, Alessandra e Elisabetta, che sono qui ora, e che all’epoca avevano solo 6 anni. La nostra era una vita normale, una vita serena, fatta di soddisfazioni professionali ma anche di normali preoccupazioni di famiglia. In quegli anni, tra l’altro, abbiamo anche aderito ad una nuova proposta di maternità e paternità, nonostante una mia iniziale reticenza dovuta al fatto che, comunque, crescere due gemelle era stata un’impresa abbastanza faticosa, dovuta anche alla lontananza di quella che è la famiglia.
Nel luglio del 2002 succede l’imprevisto. Mi trovavo alla 12esima settimana di gestazione, quando ho rischiato un aborto spontaneo. Sono stata ricoverata in ospedale per più di un mese e in quel mese mi ricordo esser stato un mese di paura, di ansia, ma alla fine anche di una grandissima gioia, perché tutto sembrava essere rientrato e quindi il pericolo sembrava scampato. In realtà, quell’avvisaglia era stata solo l’inizio di una nuova storia, perché all’ottavo mese di gravidanza i medici, nel fare l’ultima ecografia, hanno riscontrato alcune anomalie e quindi mi hanno chiesto di fare una risonanza magnetica. Era il 23 dicembre del 2002. Ricordo molto bene questa data, perché subito dopo la risonanza l’annuncio della diagnosi è stato drammatico: il neurologo, che non è il nostro amico Bernard Dan ma un neurologo che avevamo conosciuto in precedenza, si è espresso con queste parole: “vostra figlia ha un gravissimo handicap. Nella migliore delle ipotesi sarà un vegetale. Nella peggiore delle ipotesi morirà alla nascita. Vi consigliamo, di conseguenza, l’aborto terapeutico”. E nel dire questo, aveva già fissato la data. Eravamo al 23 dicembre, e ha detto: “il 26 dicembre abbiamo fissato la data per l’aborto terapeutico”. Ovviamente, nel parlare di aborto cosiddetto terapeutico, ci ha anche spiegato per bene come avrebbe dovuto avvenire questo aborto: “effettueremo una amniocentesi, mediante la quale le funzioni del feto cesseranno e poi lei partorirà normalmente”. Uscita dallo studio di questo neurologo, io avevo già chiaro che comunque quella bambina sarebbe nata. Con Riccardo ci siamo guardati ed è bastato uno sguardo per dire, per capire che eravamo entrambi nella stessa direzione. Un grandissimo dolore si è impadronito di noi, ma insieme al dolore anche una grande tranquillità, perché per noi era certa la volontà di accogliere il dono della vita di Giulia. Più tardi, ripensando a quel momento, mi sono accorta come in realtà non mi sia mai trovata a pensare: perché questo è successo proprio a noi e non è successo a qualcun’altro? Mi sono limitata a restare davanti alla situazione, assumendone tutte le implicazioni, cioè senza togliere nulla a quella che era la fatica di un quotidiano che con Giulia non è semplice. Ma ciò ha generato in me una crescente ricerca di ragioni adeguate per poter sostenere questa fatica della contraddizione e posso dire che la nascita di Giulia ha fatto scaturire in me una grazia, una grazia perché era una cosa che non avrei mai scelto per me e è diventata nel tempo, invece, un’occasione di crescita, sia come donna, che come madre, che come persona.
Io e Riccardo abbiamo iniziato a mendicare la nostra preghiera in tutto il mondo, dopo questo avvenimento. Si sono mossi amici, si sono mosse comunità. Sono accaduti anche altri fatti, che poi Riccardo vi racconterà più nel dettaglio, che ci anno confortato, sostenuto, ma soprattutto confermato nella nostra scelta. Comunque, le più brutte previsioni sul parto sono state spazzate via il giorno della nascita di Giulia. Giulia è nata senza nessun problema. Era una bambina bellissima. Sull’immediato non si osservava nulla, alcuna problematica. Ma con il passare dei mesi, invece, le sue difficoltà sono emerse palesemente. Giulia non parlava, non si muoveva. Erano compromesse la parola e tutta l’attività motoria. Dopo un mese dalla nascita siamo tornati dal primo neurologo, quello che ci aveva annunciato la diagnosi terribile. E lui ha mantenuto lo stesso gelido distacco del primo giorno, perché nel momento in cui noi ci siamo indirizzati a lui facendogli delle domande precise, perché volevamo capire di più su quello che era successo, lui ci ha subito messo a tacere dicendo: “Voi non potete farmi altre domande, quello che vi ho detto è la realtà. Dovete attenervi a quello che vi ho detto”. Nel momento in cui io mi sono messa a piangere, perché ovviamente lo sconforto era tanto in quel momento, lui mi ha detto: “Le consiglio vivamente una psicologa, e possibilmente di lingua italiana, in maniera che possiate confrontarvi anche nella stessa lingua”. I rapporti con alcuni operatori del mondo medico possono essere molto dolorosi, ma la certezza di un disegno buono per Giulia è stata comunque per noi la presenza di volti amici che ci hanno accompagnato, che ci hanno aiutato, non solo dal punto di vista affettivo ma con un’amicizia che è diventata veramente operativa nel tempo. Infatti, fin da subito è stato chiaro che il problema non era subire passivamente questa situazione, ma stare davanti a questa situazione con tutta la nostra intelligenza e con tutta la nostra energia affettiva; così che la vita nostra e la vita di Giulia non fosse né infelice né triste, anche se questo ha comportato e comporta, vorrei dire in ogni momento della giornata, in ogni istante, di recuperare le ragioni per cui vale la pena farlo. Ci sono momenti difficili, ce ne sono tanti, ma una certezza e una serenità, di fatto, ci accompagnano sempre.
Un incontro importante è stato quello con il professor Bernard Dan, che è uno stimato professionista, che abbiamo imparato a conoscere, a apprezzare non solo per le sue doti e la sua professionalità ma soprattutto per il modo in cui lui è stato, personalmente, di fronte alla vicenda di Giulia, interrogandosi anche come persona. Non vi voglio dire altro, perché preferisco poi, più tardi, lasciare la parola direttamente a lui. Un altro incontro molto importante è stato quello con la Marilena Pedrinanzi, una specialista della riabilitazione, che ha saputo soprattutto ascoltarci, sostenerci, accompagnarci. Ha creduto in Giulia e grazie a lei è ricomparsa per noi la speranza, l’occasione di avviare un dialogo, di aprirsi all’ascolto. Lei ci ha suggerito, fin dai primi momenti, una terapia riabilitativa, un lavoro costante con Giulia per tutto l’arco della giornata. Un metodo faticoso, molto impegnativo per Giulia e per chi le stava accanto. Per esempio, a quattro mesi, come avete visto in una delle prime immagini, Giulia veniva messa a testa in giù su uno scivolo per quasi 80 volte al giorno per insegnarle a strisciare. Piano piano, con esercizi continui, ripetuti nell’arco della giornata, nell’arco della settimana, e con l’ausilio di moltissime persone, Giulia ha imparato a strisciare, poi a rotolare, poi a gattonare. Adesso Giulia si può mettere verticale sulle ginocchia. Se vuole qualcosa si muove e la cerca. Apre il frigorifero, se ha fame, prende le cose che vuole. E quindi, questo vi fa capire che, al di là della definizione di vegetale, siamo andati ben più lontani. Infatti, all’età di due anni, per poter seguire Giulia abbiamo fatto appello a dei volontari, imparando l’umiltà della domanda, l’umiltà di chiedere. Aprire le porte di casa ha significato anche aprire il nostro sguardo a prospettive e incontri inaspettati. Diciamo che l’imprevedibile ci ha costretto a un radicale adattamento, a una rinuncia, a una tranquillità della vita. Abbiamo cominciato con un appello in parrocchia e poi con un passaparola tra gli amici, gli amici del lavoro. Siamo arrivati ad avere più di 30 volontari che con turni di un’ora al giorno hanno iniziato a dedicarsi a Giulia. Sabato e domenica compresi. Sono nate delle amicizie molto belle, dei rapporti solidi, che hanno cambiato veramente la nostra vita. Chi è entrato in casa nostra è rimasto affascinato dagli occhi di Giulia, che sono stati soprannominati occhi di cielo, occhi che interrogano sul senso più profondo della vita, su quei perché, spesso sopiti, che albergano in ciascuno di noi. Giulia genera, posso dirlo veramente con letizia, un popolo attorno a sé. Un popolo che vede, che riconosce in lei una certezza, per il modo in cui lei avvicina le persone, comunica con loro, cerca di toccarle, cerca di parlargli attraverso dei suoni. E questo ci rende consapevoli, una volta di più, che Giulia ci è stata affidata, che non è nostra. Noi la dobbiamo accompagnare in un cammino, il cammino della sua vita, verso il suo destino, ma lei è un dono, un dono veramente per tutti. Ed è anche per questo che, il giorno della sua prima comunione, nel ricordino che abbiamo preparato per la prima comunione, abbiamo voluto inserire una frase di San Paolo, per noi molto significativa: “Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti”. A maggio Giulia ha fatto la prima comunione. È stato un momento molto bello, commovente. Tanto che adesso, ogni domenica, quando andiamo a messa, Giulia capisce questo gesto, spalancando la sua bocca quando intravede l’ostia nelle mani del sacerdote. E questo per noi rappresenta un ulteriore disegno di come sia stato giusto percorrere anche questo desiderio di bene per lei.
La ricerca del bene di Giulia ci ha posto, poi, in maniera certa anche di fronte a problemi di mentalità e di cultura. Giulia, infatti, non frequenta le scuole speciali riservate in Belgio ai bambini con disabilità, bensì la sezione italiana della scuola europea di Bruxelles. A lei è stato dedicato un progetto pilota. Un progetto pilota che va avanti da quattro anni, seppur con difficoltà crescenti, perché ovviamente l’handicap di Giulia è un handicap pesante. Ma a settembre Giulia inizierà la prima elementare. Giulia capisce, capisce tre lingue. Capisce l’italiano, lo spagnolo e il francese e risponde, se noi le parliamo in queste tre lingue. E questo proprio è dovuto anche a questa capacità che ha lei di reagire, di comunicare.
Un altro esempio del tentativo di integrazione di Giulia è stata la settimana di sci. Come avete potuto vedere dalle foto, ogni anno Giulia, per una settimana, partecipa ad una settimana di sci dove, con l’aiuto di istruttori specializzati, i ragazzi sciano per una settimana, cimentandosi alla fine in una bellissima gara di sci – li avete visti, erano tutti lì con la pettorina – dove tutti sono vincitori, perché hanno superato la sfida più grande, che è la sfida della vita. Per noi genitori è un’occasione di incontro e di condivisione con famiglie che hanno problemi simili ai nostri e da cui scaturisce, anche per noi, un’energia rinnovata, nuova, e una certezza che siamo sulla strada giusta. La realtà dell’handicap, che ci era del tutto estranea, ci è diventata così stranamente famigliare, pur restando un mistero impenetrabile. La vita di Giulia è un mistero. Dio è venuto non per eliminare la sofferenza, non per spiegarla, ma per riempirla della sua presenza. E Giulia parla di Dio a molti. Tanti sono i segni di consolazione che Giulia ci dà, al di là del suo evolversi in capacità motorie e cognitive. Ma se penso alla strada fin qui percorsa – e quindi mi ricollego ancora una volta a quello che mi chiedevi, Davide – non posso che affermare che la certezza che all’inizio ci aveva fatto dire di sì alla vita, in maniera forse impreparata, ora è ancora più grande e più forte, perché ragionevole e confortata da quanto ho potuto raccontarvi fino ad ora.
DAVIDE PERILLO:
Anche il prof. Bernard Dan si è imbattuto in Giulia, cosa ha voluto dire, che cosa vuol dire per lei questa scoperta? Prego professore.
BERNARD DAN:
Buongiorno. In effetti sì mi chiamo Bernard Dan, sono medico ed è così che ho incontrato Giulia, è così che ho incontrato la famiglia di Giulia. Li ho incontrati in uno studio medico, un luogo molto più intimo rispetto alla sala in cui ci troviamo oggi. Non sono abituato a parlare davanti a tanti amici, tuttavia ero stato preparato, mi avevano detto che a Rimini faceva molto, molto caldo, ma non avevo capito che si trattava di calore umano. Ancora una volta ho sentito raccontare la storia di Giulia insieme a voi, e quello che ho sentito – beh ho sentito parlare di grazia, di felicità, di sofferenza, di dubbi, ma anche di certezze, e di una strada, di un percorso che è stato fatto – è un racconto che si riferisce in modo specifico a Giulia, ma possiamo anche considerarlo il racconto unico di qualsiasi bambino e sicuramente dei bambini di Mariangela e Riccardo. La differenza qual è? La differenza forse è che qui siamo obbligati a riconoscere l’intensità, perché? Forse perché eravamo stati preparati diversamente, forse perché eravamo stati preparati da un discorso negativo, un discorso che sembrava togliere qualsiasi tipo di speranza, ma poi il prosieguo della storia, volente o nolente, è stato di grazia, di felicità, di dubbi, di certezze e di un percorso che continua. Quello che è stato detto a livello medico, è stato detto molto, molto presto, prima ancora della nascita della bambina, ed è stato detto grazie ai progressi della medicina. Questi progressi sono certo molto importanti, in quanto consentono di capire in che modo il cervello umano si sviluppa e come il bambino si svilupperà a sua volta. Il medico, il collega naturalmente ma che avrei potuto essere io, si trova in questa situazione, deve spiegare, deve decifrare al cospetto dei genitori quello che ha visto e si trova in una situazione che non è, come dire, presente, attuale ma è rivolta al futuro e allora a quel punto non si poteva parlare di Giulia, si poteva semplicemente parlare di ipotesi, proprio per essere aiutati a forgiare delle rappresentazioni, delle proiezioni rispetto al futuro. Il medico deve tradurre, deve tradurre nel linguaggio corrente e quello che è stato detto, quello che abbiamo sentito, era una metafora, la metafora che consisteva nel parlare di vegetale, di pianta. Questo evidentemente non si può mai applicare all’essere umano, sappiamo bene che esso non è una pianta, ma questa metafora sembra molto potente, ed ha un elemento tipico del gergo medico e riguarda lo stato vegetativo, una situazione in cui il cervello è talmente anormale che non ha nessun tipo di comunicazione e impedisce lo sviluppo di una vita di relazioni. E’ una questione molto pesante da capire, da prevedere, la verità è che in realtà non si è capito bene, lo avete visto bene su queste foto, in questo video, Giulia comunica, comunica in modo molto efficace. Quello che i progressi medici e scientifici hanno consentito a livello di conoscenze, è che lo sviluppo non è un qualcosa di predeterminato. Per molto tempo infatti si è pensato che lo sviluppo fosse iscritto nel patrimonio genetico e che per questo motivo un bambino non potesse certo mettersi a camminare appena nato. Ecco perché i bambini cominciano a stare seduti per esempio tra i cinque e gli otto mesi, e soltanto dopo questo periodo cominciano a camminare, diciamo tra i dieci e i diciotto mesi di età e così via naturalmente. Ora questo non è scritto nei geni, quello che è scritto nel patrimonio genetico sono regole molto generiche le quali evidentemente si mettono in moto secondo tre tipologie di regole. Innanzitutto per essere un fatto genetico, che cosa deve succedere a livello neuronale? Con quali cellule il neurone, per funzionare bene, deve collegarsi? Questa storia potrebbe bastare se parlassimo soltanto come nel passato, cioè che lo sviluppo umano è determinato dal patrimonio genetico, ma non è così, non è questa la verità, c’è un altro insieme di regole altrettanto importante e cioè l’esperienza, ovvero l’utilizzo pratico che viene fatto del cervello. L’esperienza è un modo di decodificare nel nostro cervello quello che viviamo, quello che sentiamo, e in quanto l’esperienza è importante, la medicina deve riflettere su come ottimizzare l’esperienza e proporre delle terapie. Ma ci sono anche delle situazioni non mediche che devono emergere per consentire esperienze che siano più ricche possibili. Sappiamo per esempio che il piacere è una cosa molto importante, lo abbiamo visto bene sulle foto di prima, il piacere aiuta a fissare in modo indelebile e personale quelle che sono le esperienze. Ho parlato di tre tipi di regole genetiche esperienziali, le esperienze, la vita quotidiana vorrei dire; il terzo gruppo di regole sono il caso, ovvero tutte quelle cose che oggi chiamiamo caso. Perché? Perché non le conosciamo, perché non sappiamo proprio come modificarle, come interagire con esse, per cui due persone con gli stessi geni, per esempio dei gemelli omozigoti che hanno fatto esperienze simili, possono svilupparsi in modo molto, molto diverso. E allora dobbiamo tener conto di tutti e tre questi aspetti. Questo significa anche che ogni vita deve essere, come dire, inventata, la vita dei bambini cosiddetti normali come pure quella dei bambini rispetto ai quali è stata fatta una diagnosi medica e questo ci fa capire che questo concetto di normalità è una concetto statistico, non è un concetto ideale, non si può dire c’è un modo di essere normali come sono le persone normali e se non si è così non si è normali. Viceversa ognuno di noi è unico e statisticamente la maggior parte delle persone, più o meno, è fatta nello stesso modo, e su questa base la società ci dice quello che è normale e ci dice anche ciò che invece statisticamente si allontana dalla norma. Allora qual è la responsabilità che incombe sulla società, qual è la responsabilità di coloro i quali, per esempio i medici, i terapisti, hanno ricevuto, come dire una responsabilità, un mandato rispetto a chi si allontana dalle statistiche, di ottimizzare l’accesso alla società? Se noi pensiamo che cosa è l’uomo, beh la questione, la domanda è complicata, ma una vecchia definizione, la definizione greca, la definizione greca dell’uomo come antropos politicon zoon, dice che l’uomo è un animale sociale, l’uomo è appunto un animale sociale, un animale che si definisce nelle sue relazioni con gli altri individui che sono come lui. Lo vediamo con Giulia, è così che l’abbiamo visto sciare oppure a scuola, e allo stesso tempo è così che dobbiamo riflettere specificamente su Giulia cioè come per Giulia riusciremo a garantire un accesso, attraverso lei stessa, alla società. Ora, che cosa ancora ci può riservare la medicina? Sicuramente molti progressi, ma vi prego, non cediamo alla tentazione di pensare che la medicina possieda una verità superiore alle altre che possiamo percepire, sempre ci saranno dei collegamenti ulteriori da fare. Quando andiamo dal medico, significa che abbiamo un problema, allora chi mi conosce bene sa che io non dico spesso la parola problema, preferisco dire sfida. Il problema è già una questione che richiede certe implicazioni, e allora io dico c’è un problema, si va dal medico e si cerca di risolverlo, se non ci si riesce allora ci si chiede se per caso non sia un problema medico e allora naturalmente si va dal medico, si racconta il proprio problema al medico e allora lui che cosa fare, ci ascolta, ci ascolta e traduce il problema in quella che è la lingua del medico, della medicina, cioè nel linguaggio della comprensione attuale della scienza. Naturalmente, però, questa traduzione non è letterale, è una traduzione molto selettiva, che prende elementi cercando di collocarli in categorie mediche proprio per poter utilizzare tutto quello che conosciamo dei problemi che abbiamo collocato nella stessa categoria. Allora per Giulia abbiamo esaminato il suo cervello, abbiamo visto che lo sviluppo non era abituale, era normale e forse era una polimicrogiria, forse era una lisencefalia, nomi, nomi di categorie mediche che non riguardano Giulia specificamente, bensì il rapporto che abbiamo con la medicina. Una volta che il medico ha collocato nella categoria medica il problema, può cercare di trovare una o delle soluzioni mediche, e allora attua un programma di cura, di presa in carico, il cui obbiettivo naturalmente è cercare di risolvere il problema in tutto o in parte. La vera domanda, il vero problema viene dopo, cioè questa risposta ha fatto progredire abbastanza le cose? Il problema è diminuito abbastanza? E allora, a quel punto ci lanciamo in una relazione di condivisione costante tra esperti che sono tutti membri di una stessa equipe, il capitano di questa equipe, di questa squadra, in questo caso è Giulia, i membri di questa squadra hanno ognuno un ruolo, la mamma, il papà, il neurologo, la fisioterapista, la logopedista, la scuola. Questa equipe, questa squadra va avanti in un rapporto dinamico, il cui obbiettivo è consentire a Giulia di essere al meglio se stessa. Il medico che cosa impara in tutto questo? Lui impara il suo mestiere, perché il mestiere di medico è un mestiere che non si finisce mai di imparare, tanto meno quando si finisce l’università; a quel punto, alla fine degli studi, il medico è abbastanza ben attrezzato per cominciare ad imparare ancora, ogni giorno, negli incontri, nel rimettersi in discussone. E oggi, che cerco di usare termini non puramente medici rispetto a questo processo, mi accorgo che anche questo è un apprendimento che sto facendo io, oggi, e nella condivisione che stiamo facendo oggi, in questo scambio di menti che oggi stiamo vivendo, ancora stiamo imparando qualcosa e questo può essere anche benefico, per Giulia, per me, magari anche per noi tutti e per molte persone con cui interagiremo, anche per me professionalmente, anche per gli altri bambini. Allora vi ho detto che sono molto felice di essere qui, ho caldo, ma questo è un calore molto sopportabile, estremamente gradevole e ne voglio ancora. Grazie.
DAVIDE PERILLO:
Avete visto che cosa genera una apertura di fronte alla realtà? Giulia è diventata la capo equipe di ricerca. E in famiglia? In famiglia cosa ha generato, cosa genera? Riccardo.
RICCARDO RIBERA D’ALCALÁ:
Vorrei aggiungere alcuni fatti, frutto della mia particolare esperienza, che rispondono in particolare a questa domanda di Davide. Ma vorrei cominciare con una frase, che voi conoscete, di Emmanuel Mounier, che può anche sintetizzare l’inizio della nostra storia. Nel giorno in cui veniva diagnosticata la grave malattia della figlia, a quanti dicevano: è toccata loro una grave sventura, Mounier replicava: “Invece non si tratta di disgrazia, ma siamo stati visitati da qualcuno di molto grande”. Anche noi, di fronte alla durezza della diagnosi prenatale di Giulia, siamo stati confrontati dalla grandezza di questa visita, che ci ha improvvisamente resi bisognosi, ci ha fatto realizzare la nostra finitudine, i nostri limiti, la nostra sproporzione di fronte a un avvenimento più grande di noi. Certo, la presenza di un grave handicap può essere percepita come una sventura, una condanna o come una occasione di scoperta, di una grazia, che bisogna però poter cogliere. Per poter sperimentare questa grazia, è stato necessario per noi, fin dall’inizio, un percorso, che ci ha visto bisognosi di tutto, mendicanti della preghiera, come ricordava Mariangela: effettuare innanzitutto una scelta, che è consistita nella rinuncia a quella aspettativa di normalità, di perfezione fisica, di riuscita, che nell’opinione comune sono sinonimi di felicità, nella rinuncia quindi a voler fare del nostro disegno umano la misura delle cose, nel superare questa psicologia della sventura, per stare con realismo davanti ai fatti, dei quali, in quel momento, non conoscevamo neanche tutte le implicazioni. E’ proprio a partire dall’incertezza oggettiva di questa vita fragile e all’incertezza della nascita di Giulia, che è iniziato per noi questo percorso, lungo il quale abbiamo progressivamente scoperto le ragioni di una certezza, che hanno assunto il volto di persone, di avvenimenti concreti, di incontri, attraverso i quali il Mistero ci ha rivelato il suo disegno buono per noi. C’è uno di questi incontri che ci è particolarmente caro, che ha marcato la mia esperienza, che vorrei raccontare, quello con Giovanni Paolo II. Perché in questo incontro abbiamo ricevuto dei segni premonitori di quello che era il disegno buono che il Signore ci aveva riservato. Dovevo accompagnare il Presidente del Parlamento Europeo – fa parte del mio lavoro – che era allora Pat Cox, in visita ufficiale presso la Santa Sede e l’udienza era fissata per il 3 gennaio 2003. Era poco più di un mese prima della nascita di Giulia. Con Mariangela abbiamo deciso di affidare la nostra attesa alle preghiere del Santo Padre, sapendo che Egli pregava per le intenzioni che gli venivano affidate, che gli venivano raccomandate. Però non era per nulla scontato che potessi parlargli. Di solito questo tipo di visite hanno un carattere strettamente protocollare, che si limitano ad una presentazione dei membri della delegazione. Ed era per questo che avevamo anche preparato un messaggio scritto, rivolto al Santo Padre, nel quale chiedevamo la sua preghiera. Invece, grazie anche alla sensibilità del Presidente del Parlamento Pat Cox, che conosceva la nostra profonda preoccupazione, io ebbi la possibilità di intrattenermi brevemente con il Santo Padre, esponendogli i motivi della nostra ansia. Giovanni Paolo II mi ascoltò, mi esortò con poche parole a restare fiducioso, a pregare, ci raccomandò a Maria, Regina della Famiglia e mi dette la sua benedizione. Un dettaglio: alla fine dell’Udienza, il Papa distribuiva a tutti, a ciascun membro della delegazione, un Rosario. Ce n’era uno in più, per mia moglie, per Mariangela, che Giovanni Paolo II volle donarmi personalmente. Venni colpito dalla delicatezza di questo gesto. A partire da quel giorno intensificammo la preghiera e la nostra attesa, che era stata fino allora caratterizzata da una grande apprensione, sia pur diciamo nella fede, si svolse con una maggior serenità. Per la prima volta sperimentammo quel clima di attesa gioiosa che caratterizza ogni nascita. Dopo la nascita di Giulia, ci giunse anche un messaggio dal Santo Padre, il quale si augurava che l’evento si fosse felicemente concluso e ci assicurava ancora una volta le sue preghiere. Ma, a parte questo episodio, è la nascita stessa di Giulia, poi il suo modo di essere, che hanno rafforzato in noi la consapevolezza che lei fosse un dono. E’ proprio la grandissima semplicità di Giulia, che non è dotata delle normali capacità cognitive, intellettive, che non parla, che si fa capire a gesti, il suo essere bisognosa di tutto, la sua capacità di aprire i cuori delle persone, che desta in noi uno stupore continuo, quotidiano. Ma Giulia ha una grandissima capacità di comunicare nell’ambito di una relazione affettiva e questa relazione affettiva è molto forte, parla alla gente, è quanto le basta per esistere come persona. Lei insegna costantemente a noi, alle nostre figlie, agli amici, la gratitudine per la vita, per le cose semplici, ed è lei che in fondo sceglie le persone, perché lei capisce molto bene le persone che si interessano veramente a lei, e con le quali interagisce e che ricompensa con il suo sorriso. Vorrei a questo proposito leggere la frase di una lettera inviataci da Luca, un ragazzo, amico di un nostro amico, amico di Marco, uno dei volontari, che è venuto a trovarci alcuni mesi fa, trascorrendo una giornata con noi. Leggo solo un brano di questa lettera: “Per quanto mi riguarda, sono profondamente grato, perché sono tornato cambiato, più certo, più lieto, anche se non meno pieno di casini e difetti, ed ora cerco di dirti perché. La cosa più eccezionale è stata conoscere Giulia e stare quel tempo con lei. Ho goduto del suo sguardo, di come capivo che mi voleva bene prima di ogni analisi, per il solo fatto che c’ero; mi sono sentito stimato per questo. Ho visto in lei la semplicità con cui accoglie la realtà e ne gode, perché la sente per lei, mentre io spesso ci muoio dentro perché frappongo i miei se e però, insomma la mia misura su me stesso e quindi delle cose”. Poi continua con altre considerazioni, diciamo, di questo tipo. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello che io chiamo il senso religioso di Giulia, che ha un rapporto molto spontaneo con tutto quello che vive, le accade, per tutto ciò che è bello e che è vero. Restiamo sempre stupiti da come lei rivolge lo sguardo, invia un bacio devoto con la mano al Tabernacolo o alle immagini sacre che vede spesso prima di noi. Delle volte ci accorgiamo che lei, magari non so, lancia un bacio con la mano e vediamo che lei ha visto una immagine magari di Gesù o della Madonna. Ma lo fa con quella familiarità e naturalezza con la quale ci si rivolge ad una persona viva e presente. Mariangela ha raccontato come Giulia ha risposto al nostro desiderio di farle ricevere la prima comunione; ma la vita con Giulia certamente non ci risparmia la fatica, la preoccupazione, la sofferenza per le crisi epilettiche di cui soffre e che si sono acuite negli ultimi tempi. Quello che ci colpisce di più è che quando sta male, non riesce a spiegarci bene quali siano i suoi sintomi; per noi questo è motivo di sofferenza. Esprimendosi in quel caso solo con un pianto, che per noi è inconfondibile. In questi momenti lei ci appare in tutta la sua fragilità e noi le stiamo accanto con affetto, con le cure, ma sperimentiamo anche per un momento il mistero del dolore innocente. Altro aspetto, che si riferisce anche alla domanda di Davide della vita di famiglia, è il rapporto con le figlie maggiori, con Alessandra ed Elisabetta, che sono ora quindicenni e che rappresentano una parte importante di questa esperienza. Avevano sei anni al momento dell’attesa di Giulia e ci colpiva come in quel momento pregassero con noi per la nascita della sorella. Vivono la presenza di Giulia con generosità e Giulia è sempre la prima ad essere presente agli incontri, essere presentata alle loro amiche. Ci viene da pensare spesso quanto è vero il rischio educativo. Giulia rappresenta un riferimento saldo proprio nel suo essere così bisognosa, ma al tempo stesso così felice. Spesso, in seguito a discussioni, diciamo pure litigi tra di loro, l’incontro con Giulia rappresenta sempre un momento di serenità, qualcosa che le riporta con i piedi sulla terra. Le nostre figlie fanno anche la loro esperienza nella compagnia dell’amicizia del gruppo di volontari che ci sostiene, che ci accompagna, che si è creato attorno a Giulia. Questi incontri hanno arricchito noi, ma sono diventati ugualmente occasione di segno per le nostre figlie. Mi riferisco in particolare agli incontri con gli amici, con i giovani universitari, che sono un aiuto per Giulia ma sono anche un esempio di verità e di freschezza proprio per le nostre figlie. Abbiamo detto che Giulia è un dono e dall’evidenza che Giulia è un dono deriva per noi un’altra conseguenza, della quale diventiamo sempre più coscienti: Giulia ci è stata affidata ma non ci appartiene; appartiene ad un altro ed ha una missione da svolgere anche nei confronti delle altre persone. Mi viene anche da pensare che noi crediamo di portare Giulia e in un certo senso è vero, perché lei dipende in tutto da noi e dagli altri, ma spesso ci rendiamo conto che è lei che porta noi tramite qualcun altro. E tramite questi segni e anche altri che potrei raccontare, per me è di un’evidenza quotidiana e tangibile che la promessa di bene che avevamo intuito al momento della nascita di Giulia, si è fatta sempre più certezza e che la nostra fede è diventata veramente esperienza. Una certezza elementare e che potrei dire di tipo ontologico, che è diventata sempre più sperimentabile nella realtà della nostra vita, nella realtà di tutti i giorni e non solo in relazione alla presenza di Giulia, ma anche con riguardo ai nostri rapporti di marito e moglie, alle figlie, alla famiglia, al lavoro e agli amici. Questi avvenimenti mi hanno cambiato profondamente, anche al punto di poter svolgere una testimonianza di questo tipo, cosa che non avrei mai immaginato di poter fare in passato: hanno ridestato la nostra umanità. Mi è sembrato allora particolarmente vero e concreto quel passaggio di Emmanuel Mounier che dice che occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina ma nasca dalla carne, che la verità si faccia quindi esperienza. Siamo stati chiamati a stare davanti a una provocazione che il mistero ci ha posto davanti, servendosi di modalità scomode che non avremmo mai scelto né immaginato, ma che oggi non vorremmo mai cambiare.
DAVIDE PERILLO:
Fabio Cavallari, che su Giulia ha scritto il capitolo di un libro, Vivi: storie di uomini e donne più forti della malattia, di Lindau. Tu hai avuto la fortuna di imbatterti in Giulia. Cosa vuol dire per te?
FABIO CAVALLARI:
Potrei rispondere con una frase ad effetto e dire che “Giulia insegna la vita”. Però non voglio e sicuramente saranno d’accordo con me Mariangela e Riccardo, voler erigere Giulia a un mito e i genitori a degli eroi. La loro storia, quindi non solo la storia di Giulia, ma la storia di Mariangela, di Riccardo e di tutti gli amici che hanno consentito tutto quello che avete sentito ora, tutta quella rete di protezione che si è stretta attorno a questa famiglia e ha reso possibile quanto sembrava impossibile, ebbene, io credo che questo sia stato il punto determinante. Non sono degli eroi, sono degli uomini. La storia di Giulia palesa una cosa semplice, anche se oscurata dalla modernità: l’uomo vuole vivere. L’uomo lotta per la vita: loro sono dei condottieri, delle persone che hanno condotto una battaglia dura, difficile e Giulia rende palese che quanto ci hanno raccontato negli ultimi anni, che la modernità ci ha in qualche maniera sottilmente fatto pensare, cioè che la vita ha senso solo se è si è perfetti, se si risponde a dei canoni che sono quelli tradizionali, è falso. E questo ce lo hanno ripetuto sia quando si trattava di vita nascente sia di quando si discuteva di tutte quelle situazioni che sono da considerare il fine vita. Bene, ci hanno detto che la vita doveva essere in una determinata maniera mentre la storia di Giulia rende palese che quell’affermazione, quella continua reiterata sottolineatura che la vita o è perfetta o è niente, è un’enorme, grandissima panzana! Ma il punto è uno, è che storie come quelle di Giulia non si raccontano perché non fanno notizia e lo sappiamo. Io, venendo in qua, ho incontrato almeno tre o quattro persone che mi hanno raccontato storie simili. E Mariangela e Riccardo ogni giorno trovano persone che raccontano esperienze di lotta difficile, dove condurre la battaglia diventa davvero il passo che si compie quotidianamente. Eppure non si raccontano, perché vivere in questo Paese non fa notizia. Se oggi in questa sala uno di noi si alzasse in piedi e dicesse, io voglio morire, avremmo i Tg di tutti i telegiornali; se tutti noi ci alzassimo e dicessimo, vogliamo il rispetto per il diritto della vita, probabilmente la cosa passerebbe come una sottolineatura degli estremisti di Comunione e Liberazione. E lo dico anche se io provengo da un’altra storia, provengo da un altro percorso, ma oggi la società è questa, oggi voler vivere non fa notizia. E negli ultimi anni ci hanno invaso anche mediaticamente con quella sottolineatura continua dove, di fronte a situazioni difficili o di bambini in difficoltà o di persone estremamente invalidate nel loro percorso, ci hanno detto: “ma tu vorresti vivere così? Ma se tu fossi in quelle condizioni?” Ebbene la domanda ci è arrivata a casa, magari seduti e tranquilli e nessuno di noi, nessuno di noi, umanamente potrebbe dire sì, io voglio vivere depotenziato delle mie facoltà, sì, io voglio vivere in condizioni difficili. Umanamente diciamo: voglio vivere pienamente. Non è mefistofelico dire voglio vivere bene, non è mefistofelico. Il punto è un altro, il punto è che si aggiunge a quella reazione istintiva che ti fa dire sì, voglio vivere bene, si aggiunge un discorso e sembra che quella domanda, “se tu fossi…”, diventi il grimaldello per un pensiero culturale. E allora attraverso quella domanda istintiva si tende a creare un pensiero culturale: o sei in condizione perfetta oppure non vale la pena vivere. Ma questa è un’astrazione intellettuale, non ha niente a che fare con la realtà. Ogni volta che ci confrontiamo con la realtà, ci imbattiamo in qualcosa di profondamente diverso: l’uomo vuole vivere, l’uomo è fatto per la vita, la morte è un fatto, non può essere un diritto. La morte è qualcosa che viene incontro inconfutabilmente, ma contro il desiderio dell’uomo. Il desiderio dell’uomo è il desiderio della vita e questo riguarda tutti, credenti e non credenti. Mi ha fatto impressione questo autunno, questo inverno, quando c’è stato uno spettacolo teatrale di Marco Paolini, un autore, un artista molto importante e bravo, che ha fatto uno spettacolo che si chiama “Ausmerzen: vite indegne di essere vissute”, e c’era la narrazione, il racconto di come in Germania, nell’epoca nazista, ma ancora prima di Hitler, poi con Hitler e ancora dopo, si sono uccise quattrocentomila disabili, ma non nelle camere a gas, prima ancora, negli ospedali psichiatrici, attraverso la compiacenza silenziosa di medici, di professori e di scienziati. Era la prova generale dello sterminio di massa. Uno spettacolo che è andato nei teatri, è stato ripetuto in televisione, ha avuto un grande successo. I grandi giornali hanno detto bene. Giustamente, dico anch’io bene, è giusto, bisogna fare memoria, giustissimo, bisogna fare memoria. Ma memoria di che cosa? Non ci si rende conto che quello che quel racconto, quella narrazione, dove in maniera quasi sottomessa, in una maniera non eclatante, si poneva fine alle vite di migliaia di persone, oggi è quello che si fa continuamente, ma non sotto l’egida del nazismo, attraverso il concetto del buonismo. Perché oggi c’è qualcosa di peggio ancora, c’è un’ipocrisia. Nessuno dice, tu devi morire, perché sarai uno in meno, perché costi troppo; no! Si dice, tu non dovevi vivere, Giulia non doveva vivere, perché non sarebbe stata felice. Il pensiero, che sottende un’idea prometeica, dell’eutanasia, è quello che ti fa dire, vivere in quella maniera non è buono per quella persona. Per cui siamo talmente buoni che poniamo fine a queste vite. Ma andatelo a dire a Giulia, andate a dire a Giulia se non è una persona felice! Certo non vi risponde come siamo abituati a rispondere. Anche questa cosa qua: noi siamo continuamente invasi da quest’idea, che se uno ci risponde con la bocca o con i segni, allora possiamo comunicare, altrimenti non comunica, non c’è comunicazione. Stessa cosa vale per le persone in stato vegetativo. Anche qui, non solo il termine vegetale, a mio avviso, va bandito quando si parla della persona umana, ma anche stato vegetativo. Oggi pensiamo che forse sarà meglio parlare di veglia non responsiva, ma stato vegetativo è qualcosa che sempre fa pensare alla disumanizzazione. E oggi la scienza addirittura ci sta dimostrando che alcune persone in stato vegetativo riescono a rispondere. Non rispondere con la bocca, non rispondere come siamo abituati a pensare, ma attraverso delle risonanze magnetiche funzionali, attraverso alcuni meccanismi nuovi, riescono a dare risposte. Quindi dobbiamo finirla di pensare che dobbiamo avere la risposta come siamo abituati ad averla. E’ ovvio, siamo qua perfetti, parliamo con tutte le possibilità che abbiamo. Ma la comunicazione di Giulia, e lo vedevate prima dai suoi occhi, lo vedevate prima nelle fotografie, come quella delle altre persone di cui ho raccontato in situazioni completamente differenti, sono la risposta a quella continua domanda: se tu fossi…? Bene tutte queste persone, tutte le persone che oggi, nel nostro Paese e non solo, vivono situazione di gravità, non stanno bussando alle porte per chiedere di morire. Stanno bussando alle porte casomai delle ASL per chiedere il diritto di cittadinanza al proprio vissuto. Chiedono di non poter fare code burocratiche pazzesche, di avere tutti gli ausili disponibili, di avere facilitazioni per poter vivere una vita dignitosa. E allora la qualità della vita? La qualità della vita è quella che a Giulia, i suoi genitori, riescono a farle avere ogni giorno con questa grande rete di protezione, senza la quale non sarebbe stato possibile creare nulla. Non pensiamo che uno Stato perfetto potrebbe risolvere tutto. In Belgio ci sono strutture per ogni malattia. Ci sono singole unità operative per ogni particolare problema; però manca una cosa. Se andate per Bruxelles, in giro per la città, difficilmente vedrete una persona disabile, difficilmente vedrete addirittura un anziano. Ebbene che cosa manca? Manca l’umano. E l’umano è quello che ha permesso a Giulia di essere oggi qua protagonista, anche se fisicamente non c’è. E io sono profondamente convinto che oggi più che mai sia profondamente necessario raccontare, fare una narrazione, perché queste sono le narrazioni della realtà, non facciamoci fregare dall’ astrazione intellettuale, da certi edulcorati discorsi dialettici. La verità la incontri quando la incontri con mano. Solo in questa maniera è possibile produrre una connessione sentimentale tra noi e tutti gli altri. Solo così è possibile costruire una comunità, grazie.
DAVIDE PERILLO:
Vedete, amici, ci sono le statistiche, le ipotesi, le teorie, le astrazioni, come diceva Fabio adesso, o il pensiero negativo, come diceva il professor Dan prima, e c’è la realtà. La realtà che è ostinata, è testarda, tenace. E ostinatamente ci ripropone sempre, trova sempre il modo di riproporci uno spiraglio a cui possiamo chinare la nostra libertà. A cui possiamo dire sì, se siamo leali con il nostro cuore, a cui possiamo dire sì, accolgo questo dono e da quando si è introdotto, da quando siamo stati visitati da qualcuno di grande, come ci ricordava prima Riccardo citando Mounier, la possibilità di questa lealtà col nostro cuore, col nostro desiderio e con la realtà è diventata stabile. Possiamo farlo, siamo continuamente richiamati a questa lealtà con noi stessi, col nostro desiderio di bene e con il bene che la realtà è e allora, quando siamo leali, accade quello che abbiamo visto raccontare. Inizia questo cammino, questo percorso di scoperta reale, per cui uno scienziato come il professor Dan si china a imparare da Giulia. E la medicina anziché essere una manipolazione, diventa un ottimizzare l’esperienza, un imparare dall’esperienza. Pensate a che percorso è questo, pensate a che possibilità di scoperta è, che cammino è. Avete visto, avete sentito, che cammino è per Riccardo e Mariangela la scoperta continua di certezza che fanno nella loro vita grazie a Giulia. Pensate che cosa è: ogni passo diventa più certo di quello precedente, ogni giorno diventa più saldo di quello precedente, la vita, l’esistenza diventa davvero un immensa certezza. In questo cammino, la cosa impressionante è che il tempo, il passare del tempo, come ci veniva ricordato anche ieri dal professor Esposito, invece di consumare, genera, genera, costruisce. Invece di spaventarci, la realtà e il tempo diventano amici, generano, generano un popolo, come quello di cui parlavano loro. Generano un percorso, come quello che hanno raccontato loro, generano delle scoperte scientifiche. Generano. E allora si diventa sempre più certi; essendo leali col proprio cuore, essendo leali con la realtà si può diventare sempre più certi. È questo che abbiamo scoperto e riscoperto anche oggi, grazie al racconto e alla testimonianza dei nostri amici. Allora l’augurio che faccio, l’augurio che ci facciamo, che faccio anzitutto a me stesso, è di essere aiutati da loro e da tutti gli altri amici che troveremo, in cui ci imbatteremo in questi giorni, di essere aiutati a poter guardare sempre di più questo fatto, questo avvenimento, che ci permette, ci aiuta ad essere leali con il nostro desiderio umano e con il bene che è tenacemente dentro il reale e quindi sempre più certi. Grazie.
(Trascrizione non rivista dai relatori)