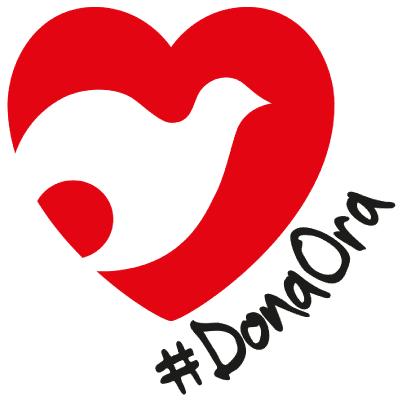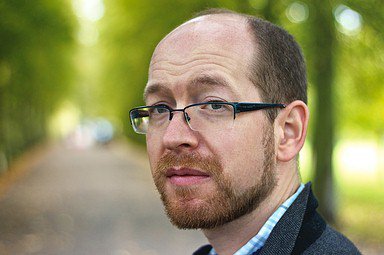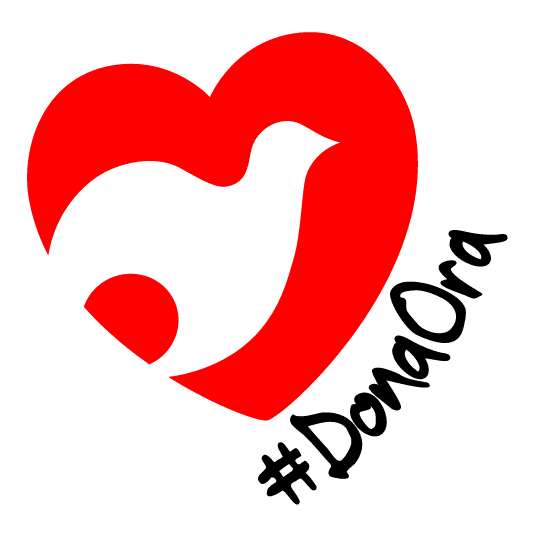Chi siamo
ESPERIENZE ALLA PROVA. INCONTRO CON…
Esperienze alla prova. Incontro con...
23/08/2011 ore 15.00Partecipa Andrew Davison, Tutor in Doctrine at the Westcott House in Cambridge. Introduce Stefano Alberto, Docente di Teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Partecipa Andrew Davison, Tutor in Doctrine at the Westcott House in Cambridge. Introduce Stefano Alberto, Docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Le origini
La prima volta che ho letto il nome di don Giussani, era in calce
a una breve citazione de Il rischio educativo. Fu sorprendente. Il
contenuto mi era familiare, ma non lo avevo mai letto espresso
con quella chiarezza e quella forza. Giussani ci stimolava a
non esaltare i concetti al di sopra della pratica. I concetti da
soli non bastano a contrastare gli attacchi alla nostra fede. I
concetti cristiani devono volgersi in pratiche dalle quali nasce
una forma del vivere cristiana. La dottrina resa pratica concreta
e comunitaria rende la fede stabile.
A quell’epoca ero impegnato nella stesura di un testo su
questo argomento. Quando lessi don Giussani ne Il rischio
educativo capii con certezza che avevo scoperto qualcuno di
importante. La sua puntualizzazione su concetti, pratica e
comunionalità sarebbe rimasta come un sottofondo a tutto
quanto sarei andato scoprendo in seguito riguardo al movi-
mento di Comunione e Liberazione.
Alla divina Provvidenza spesso piace far uso di un «evi-
denziatore». Quasi a confermarmi che dovevo approfondire la
mia conoscenza di CL, due diversi amici teologi vennero poco
più tardi a menzionarmi don Giussani. Poi un mio collega, un
fisico nucleare, mi chiese se potevo ospitare un suo amico per
qualche settimana. Questo amico si rivelò essere un membro
di CL, e andai con lui alla mia prima Scuola di comunità.
Lì cominciò il mio coinvolgimento con CL, perché lì
nacque la nostra amicizia. A Roma, in occasione di una con-
ferenza sui temi del discorso di Benedetto XVI a Regensburg,
incontrai Alessandra Gerolin e Pia de Simone (adesso sono
famose per aver cucinato per l’Arcivescovo di Canterbury
nella migliore «CL cuisine»). In verità, anche loro dovrebbero
trovarsi su questo palco a parlare con me, e con loro Samuele
e David, Guadalupe e Stefano, João, Beppe ed Elena, gli amici
che incontrai poco tempo dopo, a una conferenza svoltasi a
Nottingham sull’economia e la tradizione sociale cristiana, o
al Meeting due anni fa, o a Oxford o a Madrid.
Presto mi trovai a verificare come in ogni conferenza che
organizzavo fosse coinvolta CL. Dopo poco tempo questi amici
iniziarono a venirmi a trovare con regolarità per leggere e riflet-
tere insieme su un libro. Cominciammo con il primo volume di
Si può vivere così, sulla fede. Più avanti, quest’anno,vorremmo
volgerci a qualcosa del patrimonio della Chiesa d’Inghilterra,
per esempio L’idea di una società cristiana di T.S. Eliot.
Fervore e gioia
Tra le prime cose che mi hanno colpito del movimento, mi
soffermerò su due e sulla relazione fra loro, che è pure impor-
tante. Le persone del movimento sono zelanti e liete.
Cominciamo dallo zelo: voi siete una meravigliosa testimo-
nianza contro l’apatia. La grande attivista cattolica americana
Dorothy Day ci sfidava a vivere «come se la verità fosse vera».
Questa è anche la sfida di Giussani. Nella Chiesa c’è una
malattia, un «mal essere»: una malattia che è la noia. La gente
approva la fede cristiana, crede alla fede cristiana (anche se non
la conosce bene), va in chiesa (magari non tutte le domeniche e
non tutti i giorni festivi). Ma tutto questo, in fondo, non segna
una reale differenza. Il cristianesimo è una convinzione fra le
altre, una attività fra molte.
Don Giussani non ci ha forse detto che la fede cristiana o
determina tutto o equivale praticamente a nulla? La pratica
della nostra fede non può essere un’attività in più che si aggiun-
ge a tante altre. Al contrario, dovrebbe essere ciò attorno a cui
ogni altra cosa ruota. Il Credo non esprime semplicemente una
serie di concetti fra molti, ma quelli attorno ai quali ogni altra
cosa ruota. Potremmo dire che la fede cristiana o è qualcosa
per la quale uno potrebbe arrivare al martirio o, se non è così,
non l’abbiamo capita.
Il carisma di Giussani nel XX secolo è stato dirci che non
possiamo attraversare la vita da sonnambuli, accontentandoci
di un’adesione debole, di un cristianesimo malaticcio. Aveva
tanta fiducia nella fede che poteva dire: «Verifica se è vera!
Guarda se è vera!». Ciò comporta un rischio. Un invito reale
deve lasciare aperte entrambe le opzioni, che sia vera o che
non lo sia. È una strategia ad alto rischio, ma penso che lui
fosse consapevole che un cristianesimo tiepido è un rischio
ancora maggiore.
Gioia
Questo per quanto riguarda lo zelo. L’altra mia osservazione
concerne la gioia. Voi siete seri rispetto alla fede, ma non per
questo siete «seriosi», ossia gravi o solenni. Questo è un aspet-
to che va sottolineato e in qualche modo lodato. Per quanti
prendono il cristianesimo in modo serioso, la fede tende a
diventare facilmente piuttosto opprimente, arcigna, un po’
triste e faticosa agli occhi degli altri. Voi siete seri ma non
austeri, opprimenti, arcigni o estenuanti. Ciò che contraddi-
stingue voi di CL è la vostra gioia. Camminate con un passo
baldanzoso. Cantate. Al cuore di tutto questo sta il senso della
comunione. Come dice il salmo: «Come è bello, come è dolce
che i fratelli siano insieme in unità». Il cristiano è chiamato a
cantare tanto il Miserere che l’Alleluia, e voi li cantate entrambi,
ma giustamente l’Alleluia prevale. Voi cantate perché avete il
senso dell’avventura: il canto nasce naturale in quelli che sono
impegnati in un’avventura, in un cammino.
Per dirla in un’altra maniera, CL è un movimento orientato
verso il massimo, non verso il minimo. Per come lo vedo io,
don Giussani spingeva i suoi amici verso il bene non perseguito
attraverso una riduzione, ma attraverso un allargamento del
cuore e dello sguardo cristiano. Non era tanto preoccupato
di un comportamento a modo, quanto di proporre qualcosa
di attrattivo. Non voleva che il desiderio fosse soffocato ma
piuttosto voleva educarlo, così che si espandesse verso il suo
oggetto più vero, che è Dio stesso.
Tutto questo mi apparve con eccezionale chiarezza in uno
dei miei primi incontri con una donna del movimento, che in
seguito è diventata una grande amica. Quando era ragazza,
aveva cominciato a prendere sul serio Dio, la Chiesa, il peccato
e la redenzione. Aveva aderito a uno dei movimenti più famosi,
e più marcati in senso conservatore, della Chiesa cattolica.
Per un certo periodo, si era trovata aiutata nel suo percorso
cristiano. Ma dopo un po’ le era sembrato un ambito senza
gioia, in fondo diffidente, e poco fiducioso riguardo alla vita.
L’esistenza cristiana le veniva presentata come una serie di
regole per tenere lontano il peccato sino al compimento finale
della morte. Quando incontrò il carisma di don Giussani, si
rese conto che quello che aveva sperimentato prima era il
contrario della fede cristiana. Come ebbe a dirmi, imparò
da don Giussani che cercare Dio non consiste nel ridurre il
nostro desiderio. Al contrario il nostro desiderio non sarà mai
abbastanza grande, perché il suo oggetto vero è Dio.
Ecumenismo: il soggettivo e l’oggettivo
Mi avete chiesto di parlare al vostro Meeting. Io sono un
figlio della Chiesa d’Inghilterra. Quindi questo è un gesto
ecumenico. In verità, esso è la forma più vera di ecumenismo.
Oggi l’ecumenismo fiorisce quando ha la forma dell’amicizia. I
rapporti formali fra vescovi non registrano progressi; l’amicizia
fra vescovi sì. Le relazioni formali fra le Chiese languono, ma
fiorisce l’amicizia fra cristiani. Ecco perché CL, che è così
profondamente fondata sull’amicizia, può fare molto per
l’unità della Chiesa. Il vostro carisma è un dono particolare
all’ecumenismo, perché pone un accento caratteristico sia
sull’esperienza sia sulla verità della fede cristiana. Voi mettete
insieme il soggettivo e l’oggettivo. Non posso dire di avere
compreso fino in fondo questo accostamento, ma mi affascina
e mi colpisce.
Siete preoccupati dell’esperienza, di che cosa significhi per
una persona incontrare Dio qui e ora. Mi sembra che questo
attraversi tutta la vostra volontà di parlare ai cristiani di altre
confessioni, spingendovi verso le persone al di fuori dell’am-
bito cristiano, per arrivare a un «meeting per l’amicizia fra i
popoli». Si potrebbe definirla curiosità, ma merita un termine
più dignitoso. È una sorta di meraviglia; vi rallegrate dell’opera
dello Spirito ovunque si manifesti.
Il vostro parlare di esperienza mi preoccupava le prime volte
che vi incontrai. Quando ero adolescente io avevo lasciato la
Chiesa d’Inghilterra e avevo accostato una Chiesa Pentecostale
indipendente, nella quale l’esperienza era un punto centrale,
ma era poi divenuta a poco a poco sempre più un problema per
me dal punto di vista teologico. Si trattava di una esperienza
individuale, spesso irrazionale, addirittura incomunicabile.
Quando incontrai CL qualche anno fa mi sorse una doman-
da: l’accento da voi posto sull’esperienza era uguale a quello
dei Pentecostali? Posi questa domanda a un gruppo di spagnoli
al Meeting due anni fa. «No – mi risposero –, noi intendiamo
l’esperienza all’interno di un legame comunionale; non la
intendiamo come esperienza emozionale di un momento,
è una esperienza in atto verificata nel cammino comune di
cristiani.»
Ne fui rassicurato; la vostra insistenza sull’esperienza mi
aveva un po’ allarmato. Oggi credo che questo sia il fulcro di
quello che voi avete da offrire. Ed è anche parte di ciò che
rende CL ecumenica; voi valorizzate l’esperienza propria di
ognuno, che non è uguale a quella di nessun altro. Così la
mia «esperienza» di membro della Chiesa d’Inghilterra, di
sacerdote della Chiesa d’Inghilterra, e di teologo della Chiesa
d’Inghilterra, è qualcosa che vi interessa, qualcosa a cui guar-
dare con stupore.
Questo è il polo del soggettivo, ma voi avete i piedi altret-
tanto ben piantati nell’oggettività. Come può accadere? Siete
oggettivi perché avete fiducia in Dio e nella sua suprema ogget –
tività: che Lui è vero, in ogni senso, è il compimento del
nostro desiderio, l’origine di tutto ciò che è buono. Non
so proprio come possiate coniugare insieme soggettivo e
oggettivo come fate. Penso che siate semplicemente dei veri
cristiani platonisti: credete che ogni conoscenza soggettiva è
ultimamente conoscenza di qualcosa di oggettivo. E ciò che
potrebbe apparire quanto di più soggettivo ci sia, la nostra
esperienza di Dio, è esperienza di quanto di più oggettivo
esiste, perché Dio è la Somma Verità.
Da ultimo, a questo riguardo, vorrei volgermi a un altro
aspetto del pensiero di Giussani, ossia l’idea di preferenza. Non
sono sicuro di quanto chiaramente sia definito, o di quanto
importante sia per voi ufficialmente, ma ho visto che nella
pratica per voi è importante. Col termine preferenza voglio dire
che voi avete gli occhi aperti verso la circostanza particolare, il
compito specifico, e soprattutto la singola persona che Dio vi
dona. Uso il termine «dona» deliberatamente, perché indica
con precisione l’accogliere il mondo come dono di Dio e l’es-
sere aperti a discernere come si manifesta questo particolare
dono per ciascuno di voi.
Preferenza è una intersezione particolarmente importante
fra soggettivo e oggettivo. Essa è «soggettiva» in quanto uno
incontra la persona, questa persona, al suo livello più profon-
do, e quindi in un certo senso al suo livello più soggettivo; la
sua esperienza, la sua vita, la sua forza, i suoi problemi. Ma
in questo essa è davvero «oggettiva»: è attenzione proprio a
quella persona e non a un’altra, in tutte le sue caratteristiche,
accolta nella tua soggettività ma non piegata a essa.
Dal punto di vista teologico, compare qui qualcosa della
«pratica del momento presente» ma più ancora dell’idea ago-
stiniana di un ordine dell’amore, ordo amoris. Quando uno
cerca di amare ogni cosa in generale, può non amare nessuna
cosa in particolare. Voi invece amate davvero le cose e le
persone nel particolare. Riguardo alle persone, è un’analogia
con il vostro impegno nella sussidiarietà, nel particolare locale
rispetto all’anonimato dell’universale.
Per me, questa è la cosa più grande che ho ricevuto da CL,
singoli amici per i quali la mia esperienza è importante, come
la loro lo è per me. Questo evidenzia il tema ecumenico: sono
cattolici romani ma si rallegrano del mio essere anglicano – in
certi casi più di quanto non lo faccia io.
Affinità fra l’esperienza anglicana e Comunione e Liberazione
Il carisma del movimento ha dei punti di somiglianza con le
caratteristiche della Chiesa d’Inghilterra. Mi soffermerò su due
aspetti. In primo luogo, c’è qualcosa nel vostro porvi davanti al
mondo – alla politica, alla cultura, alla società – che mi è familiare
in quanto membro della Chiesa d’Inghilterra. Voi siete onnivori
nei confronti della cultura e della vita della mente. Apprezzo
molto l’affermazione di Giussani che ogni cosa realmente umana
è occasione per noi per fare esperienza di Dio. Basterebbero a
dimostrarlo le sue frequenti citazioni di brani poetici e il suo
amore per la musica. La Chiesa d’Inghilterra è molto «Chiesa
di musica e di poesia». Colpisce il fatto che Giussani citi la
poesia cosiddetta «secolare» tanto quanto quella religiosa, e che
la collana Spirto Gentil ospiti ampiamente concerti e sinfonie
e non solo opere apertamente «religiose». La poesia d’amore,
afferma, non è irreligiosa, né «secolare». Neanche una sinfonia è
«secolare». Anche il grande direttore italiano Toscanini era solito
negare la distinzione fra musica «alta» e «bassa»; diceva che ci
sono solo due tipi di musica, quella bella e quella brutta. Don
Giussani dice qualcosa di simile: non c’è una musica religiosa e
una musica secolare, o una musica teologica e una non teologica.
C’è solo bella musica o brutta musica, e tutta la bella musica è
musica di amore e di morte, di pianto e di dono, di tensione,
di sconfitta e di inattesa salvezza. Questi sono temi teologici,
sono temi religiosi, che possono e dovrebbero interessare ogni
persona che cerca Dio.
C’è in don Giussani, e nel movimento che ha fondato,
un gusto per la vita e per tutto ciò che è umano. Questo è
ancor più significativo per me, che ho attraversato una sorta
di protestantesimo ristretto e meschino quando ero ragazzo,
che mi ha reso sospettoso di ogni cosa. C’era un diavolo sotto
ogni pietra e una trappola in ogni opera d’arte. La maggior
parte della vita ci era proibita, vivevamo in una enclave cri-
stiana. Ricordo la mia anziana nonna anglicana che cercava
di indirizzarmi al bene citandomi il salmo e ripetendomi che
«del Signore è la terra e quanto contiene». Mi ci volle molto
tempo per ascoltarla. La Chiesa d’Inghilterra mi ha salvato dal
soffocare, quando l’ho riscoperta e l’ho trovata saggia, colta,
umana, senza paura. Trovo tutto questo in CL; anche se ci
sono differenze, vi si riconosce lo stesso spirito.
L’altra area di coincidenza che vorrei sottolineare è nella
possibilità di dialogo e di convergenza nel campo della poli-
tica. La Chiesa d’Inghilterra è una Chiesa politica in almeno
tre aspetti. In primo luogo, a livello locale, perché il parroco
è un membro centrale della comunità e contribuisce a farla
crescere nelle materie pratiche come in quelle religiose. In
secondo luogo, a livello nazionale, per il ruolo dei vescovi nella
Camera alta del Parlamento. E in terzo luogo perché membri
della Chiesa d’Inghilterra hanno prodotto opere significative
in campo politico.
È chiaro che il Regno Unito necessita di una rinascita della
vita politica. Basti considerare i recenti disordini scoppiati in
diverse città. Dovremmo davvero seguire i princìpi di sussidia-
rietà abbracciati con tanto impegno da CL. Di fatto, non vedo
altra via. Il risveglio della politica deve riguardare qualcosa più
che i partiti, e la democrazia deve riguardare più che non lo
stanco trascinarsi alle elezioni ogni quattro o cinque anni per
conquistare un voto che raramente segna una differenza.
Ricordo un intervento di un filosofo qualche anno fa
– non dirò di chi si tratta –, nel quale affermava che dovremmo
tenere la politica fuori dalla vita di ogni giorno. Pensai che era
quanto di più sbagliato potessi immaginare. La vita di ogni
giorno è proprio il vero campo della politica. Questo filosofo
aveva definito la politica un disastro; la politica per lui era per
definizione ciò che accadeva «al di sopra». Non poteva che
dissolversi in una lotta per il potere fra interessi acquisiti nei
salotti londinesi. La politica per lui era qualcosa da limitare
perché possiamo continuare la nostra vita normale. Ma mal-
grado noi siamo terribilmente individualisti – e io temo che
lui potesse esserlo – le nostre vite comuni sono vite vissute
insieme, e proprio per questo sono politiche. Mi colpiva il
fatto che i gesti quotidiani per eccellenza che i miei genitori
fanno con tutta la naturalezza di gente che vive una dimensione
pubblica, rappresentano l’essenza della vera politica: dare una
mano nel club di giardinaggio del paese nel caso di mia madre,
od organizzare la manutenzione dei campi da gioco nel caso
di mio padre; o il fatto stesso che lui guidi un’azienda dando
lavoro a delle persone, e faccia questo con buon animo. Questo
è l’inizio della politica, e si trova nella vita di ogni giorno. La
politica a Londra, o Roma, o Madrid, è immagine di questo,
e non l’opposto.
Passo il tempo dicendo alla gente, e in particolare agli
anglicani, di leggere la dottrina sociale della Chiesa cattolica.
Partite dalla Rerum Novarum, dico, e sarete conquistati. CL fa
propria questa tradizione. In pratica tutto quello che vedo di
promettente nel dibattito e nell’azione politica contemporanea
in Inghilterra, che vuol dire per lo più la dialettica fra Red Tory
e Blue Labour, riflette la visione di CL della sussidiarietà.
Insegnamenti per la Chiesa d’Inghilterra
Lasciatemi dire in conclusione che i cristiani di qualsivoglia
tradizione hanno molto da imparare da CL. Sottolineerò
due aspetti, strettamente correlati: l’amicizia e un dono per
l’evangelizzazione.
Il vostro è un movimento fondato pressoché totalmente
sull’amicizia. Se sono in grado di riconoscere il vostro carisma
è solo perché posso rendere testimonianza di un tessuto di
amicizie, che si è fortunatamente esteso sino ad accogliermi.
Nessuno può davvero conoscere CL come realtà vivente se non
conoscendola attraverso l’amicizia. Voi non chiedete a nessuno
di condividere in primo luogo le vostre idee. Voi invitate tutti
a condividere la vostra vita, se lo vogliono.
Ho osservato questo, e sono convinto che questo è il modo
giusto per comprendere la missione della Chiesa. Non invitia-
mo quanti sono lontani semplicemente e solo a condividere
certe idee cristiane (anche se personalmente sono entusiasta
delle idee). Invitiamo le persone a condividere la vita comune
della Chiesa. Se ciò che crediamo è davvero la fede cristiana,
allora probabilmente sarebbe impossibile comprenderlo al di
fuori della comunità della Chiesa. Redenzione, resurrezione,
speranza cristiana, queste cose devono essere sperimentate
nella vita della Chiesa prima di essere credute.
C’è un antico inno dell’ora di terza, attribuito al vostro
amato sant’Ambrogio di Milano, che si canta all’ora di pranzo.
Una strofa così recita:
Os, lingua, mens, sensus, vigor
confessiónem pérsonent,
flamméscat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.
Le labbra, la lingua, l’anima, l’intelletto,
la forza cantino una professione di fede,
l’amore s’infiammi focoso,
l’ardore accenda il prossimo.
Quando canto questi versi penso al movimento, al suo parlare
di amore e di fuoco, e del fuoco dell’amore che passa da una
persona all’altra. Di tanto in tanto mi trovo a incontrare per-
sone che si sono convertite attraverso il rapporto con CL. Il
più delle volte in Europa ciò significa riconversione a una fede
che avevano perduto o posseduto in modo parziale.
La vostra abilità di chiamare e richiamare persone alla fede
cristiana e alla Chiesa nasce dalla combinazione di molte delle
cose che ho menzionato in precedenza, ma in particolare da
due: dalla concreta e rischiosa offerta di «gustare e vedere»
(per citare ancora un salmo) e dal fatto che questo è un invi-
to a una comunità. Questi due elementi funzionano perché
operano insieme: potete invitare qualcuno a prendere sul serio
la fede perché prendete lui seriamente. Nessuno affronta il
rischio del cambiamento radicale se non dentro un’amicizia,
ma questo invito non è a un’amicizia senza Dio o priva di un
serio impegno comune. La mia preghiera per ciascuno di voi,
come la vostra per me, è che
Le labbra, la lingua, l’anima, l’intelletto,
la forza cantino una professione di fede,
l’amore s’infiammi focoso,
l’ardore accenda il prossimo.