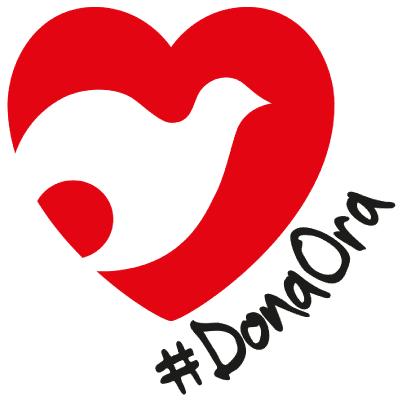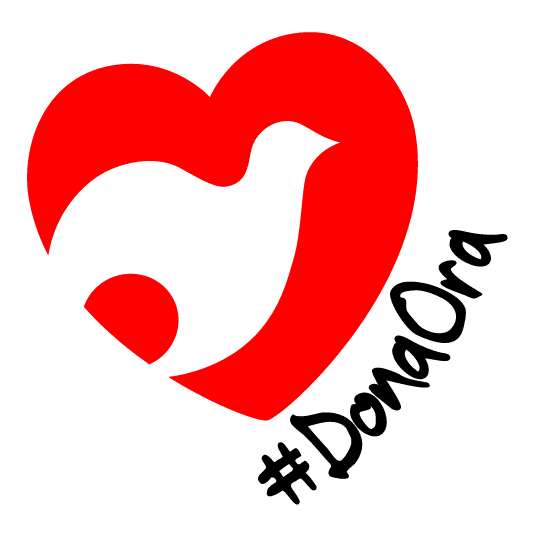Chi siamo
DEMOGRAFIA E NATALITÀ
In diretta su Askanews, Avvenire
Gian Carlo Blangiardo, Già Presidente Istat, Statistico e Professore Ordinario di Demografia, Università Milano Bicocca; Adriano Bordignon, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari; Matteo Rizzolli, Professore di Politica economica, Università Lumsa; Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità; Giuseppe Zola, Vicepresidente Associazione Nonni 2.0. Modera Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.
Coniugando la prospettiva etica, quella politica e quella statistica l’incontro mette in relazione i problemi che insorgono per lo sviluppo della democrazia quando la natalità di un Paese raggiunge tassi che rendono non più sostenibili elementi fondamentali del sistema nel suo insieme, e non solo quelli relativi al sistema pensionistico. Questi elementi verranno messi in luce dalle diverse relazioni al fine di prendere coscienza della drammaticità della situazione attuale e di delinearne alcune possibili soluzioni.
DEMOGRAFIA E NATALITÀ
DEMOGRAFIA E NATALITà
Martedì, 22 agosto 2023 ore: 19.00
Sala Neri Generali-Cattolica
Partecipano
Gian Carlo Blangiardo, Già Presidente Istat, Statistico e Professore Ordinario di Demografia, Università Milano Bicocca; Adriano Bordignon, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari; Matteo Rizzolli, Professore di Politica economica, Università Lumsa; Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità; Giuseppe Zola, Vicepresidente Associazione Nonni 2.0.
Introduce
Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.
Moderatore:
Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.
Violini. Buongiorno a tutti, questo è forse uno degli ultimi incontri della giornata, ce ne saranno poi nel dopocena, ed è un incontro che ha come titolo “Demografia e natalità”. È evidentemente un tema di grande rilievo, di grandissimo rilievo, il Meeting ne ha parlato in vari incontri, e anche un incontro che si è appena concluso, con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha chiuso proprio dicendo che questo grande tema verrà affrontato nell’incontro che stiamo per attivare. È un incontro che avrà diverse prospettive, ma l’elemento veramente importante, per cui comincio a ringraziare sentitamente, è la presenza di Eugenia Roccella, che è Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Introdurranno il nostro tema il Professor Gian Carlo Blangiardo, già Presidente dell’Istat Statistico e Professore ordinario di Demografia all’Università di Milano Bicocca, avremo poi il professor Matteo Rizzolli, Professore di politica economica alla Lumsa, Adriano Bordignon, neo Presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, e Giuseppe Zola, Vicepresidente dell’Associazione nonni 2.0. Siccome vogliamo tenere un ritmo sostenuto perché la tematica è quanto mai importante, e anche però estremamente problematica, do per prima la parola a Gian Carlo Blangiardo, che in un primo giro di riflessioni ci darà, insieme agli altri partecipanti a questo incontro, i tratti fondamentali della situazione in cui noi viviamo. Gian Carlo Blangiardo, Gian Carlo a te la parola.
Blangiardo. Grazie, buonasera a tutti. Io qui ho un foglio con dieci comandamenti, cioè con dieci osservazioni relative alla demografia, cioè quelle cose che è bene sapere. Cerco di mettere in fila una serie di dati per cercare di fare conoscenza e sensibilizzazione rispetto al problema. Il primo punto dice: negli ultimi nove anni si sono persi in Italia 1.561.000 residenti, cioè abbiamo cancellato l’equivalente della città di Milano più la città di Brescia, tanto per prenderne due che stanno in Lombardia. Quindi siamo di fronte a una caduta di popolazione che nella storia d’Italia si era verificata solo occasionalmente verso la fine della prima guerra mondiale. Dal 2014 regolarmente ogni anno sempre sempre meno. E questo è un primo dato di fatto che dovrebbe in qualche modo indurci a riflettere, perché un grande paese, se vuole continuare ad essere un grande paese, G6, G7, G8, G10, deve ovviamente avere anche una popolazione corrispondente. Ci sono paesi ricchi, il Lussemburgo per prenderne uno, però il Lussemburgo non è un grande paese, o il Principato di Monaco, e l’Italia quindi deve avere anche una popolazione corrispondente. Noi un po’ alla volta la stiamo perdendo. Il secondo punto dice: la responsabilità maggiore di tale tendenza deriva dal calo della natalità. Che è successo? 1.035.000 nati nel 1964, poi via via dalla metà degli anni ‘70 c’è stato un crollo, siamo scesi intorno alle 550/ 600.000, anni ‘80, anni ‘90, nel 95/96 valori di minimo di allora, leggera ripresa col nuovo secolo siamo arrivati a 577.000 nati nel 2008. Da allora, dal 2008 anno dopo anno regolarmente abbiamo sempre avuto meno nati ciascun anno rispetto a quello precedente. Quindi ogni volta sempre meno. Per capirci dal 2014 abbiamo tutte le volte, ogni anno, stabilito il record della più bassa natalità di sempre nella storia d’Italia, e ogni anno, l’anno successivo miglioravamo al ribasso questo record. Il finale della storia è che nel 2022, l’ultimo anno completo disponibile, abbiamo avuto 393.000 nascite, quindi siamo scesi sotto la soglia delle 400.000. Già detto è il valore più basso di sempre, e è chiaro che fa riflettere, perché uno dice però c’è un paese vicino che si chiama Francia, che ha una popolazione più o meno come la nostra, qualche milione in più ma insomma non fa una grande differenza, e di nati è arrivata a metterne in piedi 730.000, noi meno di 400.000, c’è qualcosa che non va. E questo è un’altro segnale credo importante. C’è una riflessione che faccio ed è il punto tre. Confrontando così, andando a vedere qualche dato, i dati storici del 1943, primo trimestre 1943, c’era la guerra, la vita probabilmente non era semplice. Nel primo trimestre del 1943 in piena guerra nacquero in Italia 243.191 bambini, nel primo trimestre del 2023, con condizioni di vita lo sappiamo tutti decisamente migliori, e certamente non in condizioni di guerra, sono nati 91.333 bambini, quindi 243.000 contro 91.000. Certo qualcuno dirà sì, ma era un’altro mondo, la condizione della donna, mille spiegazioni si possono dare, intendiamoci, però quello che mi fa riflettere è che in una situazione drammatica come era una guerra, peraltro non è che le cose andassero benissimo, ebbene, durante una guerra che andava maluccio, con la gente al fronte, eccetera, eccetera, c’era comunque un senso di futuro attraverso la natalità, che oggi nella pacifica Italia del 2023 c’è a livello di 1/3, si può spiegare ripeto in tanti modi, però è un elemento da prendere in considerazione. Quarto punto dice: il contributo dell’immigrazione alla natalità in Italia, è importante. È fuori discussione, non c’è dubbio, ma non è risolutivo. Le nascite nel 2012 un po’ alla volta erano salite fino ad essere 80.000 nati stranieri, nel 2022 gli 80.000 nati sono diventati 55.000, nonostante la popolazione straniera sia cresciuta. Per darvi un’idea il tasso di natalità, nati per 1000 abitanti, nella popolazione straniera nel 2004 era il 23,5 per mille, quindi 23,5 nati ogni 1000 abitanti, oggi, ultimo dato disponibile, è l’11 per mille, meno della metà. Che significa? che la popolazione straniera continua a dare un contributo importante, però inevitabilmente, per una serie di motivi che ormai bene o male conosciamo un po’ tutti, anche la componente straniera si sta adattando ad un problema che esiste e che in qualche modo va affrontato sia dagli italiani e forse, a maggior ragione, anche dagli stranieri che non hanno i nonni che danno una mano, come sentiremo probabilmente in seguito. Che succede dietro a tutto ciò? la prospettiva, secondo l’Istat la popolazione residente in Italia dovrebbe subire un calo di 2,9, tre milioni praticamente di residenti, nei prossimi vent’anni, di cui due milioni e mezzo in età 20-64, età lavorativa. Quindi se qualcuno dice che cosa potrà succedere ai conti previdenziali, sappiamo che la popolazione va a diminuire, ma che va a diminuire soprattutto in corrispondenza della componente che paga i contributi, quindi di quella produttiva. Questo è una riflessione, è un dato di fatto, non si può non tenere conto, anche nel fare delle scelte, anche di natura politica, che c’è sullo sfondo una situazione di questo genere. Nel contempo la popolazione in età 65 e più, negli stessi prossimi vent’anni dovrebbe aumentare di 4,7 milioni, e tra di essi, di questi 4,7, quasi 5 milioni, 535.000 unità sarebbero ultra novantenni, passano da 842.000, gli ultranovantenni, a 1.377.000, quindi sto parlando di fra vent’anni, quindi non chissà quando. Il calo della produzione in età attiva viene solo in parte moderata dalla componente straniera. La componente straniera, tutti sappiamo, i più giovani dà un contributo importante, i venti-sessantaquattrenni stranieri oggi sono circa il 10% della componente, sono circa 3,6 milioni di persone. Qui c’è un calcolo, un esercizio, se noi volessimo compensare la caduta della popolazione in età lavorativa, che andrà a prospettarsi nel futuro, e lo volessimo compensare attraverso i flussi migratori, avremmo bisogno di 531.178 immigrati netti ogni anno, con qualche conseguenza dal punto di vista di integrazione, mezzo milione di persone tutti gli anni sono indubbiamente difficili da integrare. Per rilanciare la natalità sarebbe necessario creare condizioni per favorire l’uscita e la formazione di una vita autonoma da parte dei giovani, perché? perché oggi ogni 100 residenti in età 30-34 anni, quindi non giovanissimi, quindi ogni 100, in età 30-34, che hanno una loro autonomia familiare, ce ne sono 444 che vivono ancora nella famiglia di origine, quindi più di quattro volte, e parliamo di persone che hanno 30-34 anni. Il problema è che nel ’91, questi sono i dati del censimento ’21, nel ‘91 il rapporto era ogni 100-152, non 444, quindi la cosa è decisamente, fortemente peggiorata. Ancora, e siamo quasi alla fine, occorrerebbe anche un intervento sul passaggio dei giovani alla genitorialità. Oggi, tra i 30-34enni, si calcola che per ogni 100 già genitori, parliamo sempre dei 30-34enni, per ogni 100 già genitori, c’è ne sono 279 ancora nella condizione di figli, entro la loro famiglia d’origine, con differenza di generi più sensibili, questo è molto più frequente nella componente maschile di quanto non sia nella componente femminile. Questa situazione è peggiorata in questi ultimi anni, soprattutto in corrispondenza dell’effetto covid in un certo senso, fino al 2018 comunque il valore era intorno ai 150-200, quindi sempre con una prevalenza maschile rispetto alla componente femminile. Sottolineo che occorrerebbe una campagna centrale sull’applicazione di un principio che è contrario a quello che si usava in Cina col figlio unico, là il discorso era: sposatevi più tardi, fate meno figli e fateli più tardi, qui dovremmo fare esattamente la stessa cosa: sposatevi un po’ prima, mettetevi in unione un po’ prima se preferite, fate un po’ prima i vostri figli, e magari ne fate un pochino di più.
Violini. Va bene, grazie allora seconda puntata questione economica, adesso abbiamo avuto il quadro generale, c’è la descrive Matteo Rizzolli a cui diamo anche a lui sette minuti ma togliendo i tre minuti in più che ha usato Gian Carlo Blangiardo.
Rizzolli.
Innanzitutto spreco subito alcuni secondi per ringraziare per questo invito, per essere qui con la Ministra e con tutti gli altri ospiti. L’idea è quella di raccontarvi brevemente che cosa sanno gli economisti della relazione tra economia e natalità. Ci sono delle slide. Innanzitutto gli economisti si sono occupati di questa relazione fin dagli albori. Thomas Malthus quello che teorizzava che la crescita delle derrate agricole crescesse linearmente mentre la crescita della popolazione crescesse esponenzialmente, conseguenza di ciò era, supponeva lui, una ricorrente carestia che avrebbe colpito l’umanità, lui era uno dei primissimi professori di economia, cattedra di politica economica nei primi anni dell’Ottocento. Da allora gli economisti si sono sempre occupati di studiare questa relazione. Il punto è che fino a tempi recentissimi, e qui ho una copertina dell’Economist di poche settimane fa, la questione si poneva sempre a che cosa succede, quando cresce la popolazione, all’economia, e gli economisti si dividono un po’ tra gli scettici, cioè la crescita della popolazione fa bene all’economia ma se cresce troppo velocemente non fa così bene, questo è stato il dibattito di 200 anni di studi economici. Solo di recente gli economisti hanno cominciato a focalizzare che il problema non è l’inverso, non è che tutto quello che succede quando cresce la popolazione succede al contrario quando la popolazione decresce, si presentano dei nuovi problemi, ci sono delle questioni nuove, che stiamo iniziando solamente ora ad esplorare. La prima cosa che vi voglio fare vedere è un’immagine di una città americana, Detroit, vi anticipo intanto cosa vedrete tra poco sullo schermo. Detroit è una città il cuore dell’industria automobilistica finché c’è stata un’industria automobilistica negli Stati Uniti. Ha toccato il picco negli anni 60, Detroit era una delle prime dieci città americane come popolazione, due milioni di abitanti, questa è una foto presa nel 2015 quando gli abitanti sono scesi a 600.000. Questo è un anticipo di quello che potrebbe succedere a un paese, o comunque a un’area che è in forte depopolamento, ovviamente in questo caso è andato via prima il lavoro e poi sono andati via i lavoratori, il caso che stiamo cominciando ad affrontare noi è quello del contrario vanno via prima i lavoratori perché non nascono più e di conseguenza vedremo che cosa succede al lavoro. Però guardate questa immagine, qui ci sono interi distretti, li vedrete, quei rettangoli verdi erano fino a pochi anni fa densamente popolati, erano tutte abitazioni, mano a mano che la gente se ne va, non se ne va in maniera ordinata, non è che si comincia dalle case più lontane e via via, se ne va qua e là, e interi quartieri questa città, che decadono letteralmente, con poche abitazioni popolate qui e là. E questo pone, a parte una questione di degrado e di criminalità, ma anche un tema che ha a che fare con la gestione delle infrastrutture, la municipalità di Detroit deve gestire acquedotti, linee autobus, e tutta l’infrastruttura pensata per una città di due milioni di abitanti, quando ne esistono molti di meno. Non a caso il Comune di Detroit è stato il più grande fallimento di una municipalità negli Stati Uniti nel primo decennio di questo secolo. La soluzione di Detroit? hanno cominciato a comperare le case delle persone che abitavano più lontane, le hanno riallocate alle più vicine al centro, e hanno cominciato a passare con i bulldozer sui quartieri che prima erano abitati. Questo è uno scenario un po’ apocalittico però è quello che è successo. Tre brevi flash su che cosa succede quando un paese diminuisce la propria popolazione. Ovviamente ci sono delle conseguenze sui conti pubblici, ne ha già accennato Blangiardo, ieri ne ha parlato il Ministro Giorgetti, so che anche prima Mantovano ha fatto un intervento, c’è un problema enorme di tenuta dei conti pubblici. Perché è vero che se nascono meno bambini si risparmia, sulle scuole, anche sull’assegno unico, ma se ne nascono di meno si risparmierà anche lì un pochino, ma il risparmio delle spese che non si fanno più per i bambini è molto più che compensato dalle spese che si fanno per la fascia anziana della popolazione, che è quella, lasciatemi usare questo termine, più costosa dal punto di vista dei conti pubblici, sanità, pensioni, eccetera. Quindi c’è un tema di conti pubblici, ma c’è un tema di infrastrutture, ve l’ho appena illustrato con l’esempio di Detroit, gestire delle infrastrutture di un paese pensate per 60 milioni di abitanti, non è la stessa cosa che farlo per un paese molto meno densamente popolato. Ci sono delle conseguenze per le imprese, sappiamo che le imprese, la vitalità di un’impresa dipende sia dal mercato interno, un grosso mercato interno solitamente aiuta le imprese a prosperare. Poi c’e l’estero, c’è l’export, l’Italia, guarda caso, stiamo diventando particolarmente bravi sull’export, non sarà che c’è un tema anche demografico in questo nostro cambiamento di specializzazione produttiva? ci insegnano le nostre imprese che sono problemi che si possono affrontare, ciononostante sono dei problemi. Una questione che sta emergendo nella ricerca è quella sull’innovazione. Un paese giovane ha imprese molto più innovative, è abbastanza intuitivo se ci pensate, un paese che invecchia ha imprese che rimangono specializzate in settori che rimangono più desueti e non è capace di inserirsi nei settori più innovativi. E anche qui penso che potremmo fare una riflessione sul perché l’Italia, ma anche l’Europa, manca dai settori più innovativi che invece vedono la forte presenza degli altri Stati, sto pensando a Stati Uniti ma anche alla Cina. Infine l’ultimo punto che voglio toccare è quello sulle famiglie, e in particolare sul risparmio delle famiglie. Oggi ci vantiamo, e giustamente, di essere uno dei paesi con il più alto tasso di risparmio delle famiglie, e questo giustamente è un grosso vanto. Dobbiamo sapere che però, secondo i dati della Banca d’Italia, otto volte il PIL nazionale è in risparmi privati delle famiglie, un’enormità, e il 55% di quell’ammontare è in realtà in case, in immobili, cioè quel valore lì è investito in immobili. Se gli immobili non vengono abitati, immaginate cosa succede al loro valore, sappiamo di quanti paesini nell’entroterra, soprattutto del Sud Italia, ma non solo, anche del Centro e qualcuno anche del Nord, ormai ci sono queste campagne di vendita dell’immobile a un euro, purché qualcuno venga a prenderselo, se lo sistemi e lo tenga attivo, diamo via gli immobili a un euro. Questo è lo scenario di quello che succede quando la denatalità colpisce duro su un paese, il valore dell’immobile crolla e con esso anche il risparmio delle famiglie, questo è un’altro degli aspetti che possono succedere.
Violini. Grazie, grazie infinite. Adesso do la parola ad Adriano Bordignon, Presidente nazionale del nostro Forum delle Associazioni familiari. Mi piace ricordare che abbiamo un fior di Parte prima, Titolo secondo, dedicato alla Costituzione, così faccio un po’ di propaganda anche alla mia materia, forse tra gli Articoli che si dovrebbero leggere un po’ più spesso.
Bordignon. È proprio così, nel senso che i padri fondatori di questo nostro paese hanno riconosciuto la centralità strutturale per il paese della famiglia, che è una centralità certamente economica, perché nelle famiglie si è creata solidarietà, ricchezza, impresa sociale, perché la coesione sociale negli anni è sempre stata portata avanti dalle famiglie, di solidarietà verso i fragili, gli ultimi, quelli più in complessità e anche il civismo di partecipazione, la partecipazione, l’impegno politico, l’impegno sociale, il volontariato, non l’abbiamo imparato in laboratorio ma l’abbiamo imparato molto probabilmente in famiglia. Cosa è successo? si è creato un corto circuito, l’Italia, che aveva messo la famiglia come un perno centrale per il presente e il futuro del paese, si è trovata per anni a disinvestire sulla famiglia. In realtà gli studiosi ci dicono che non si può dire che l’Italia nella sua storia abbia mai avuto un programma strutturato e perdurante di politiche familiari, e questo è stato proprio uno degli effetti che, a mano a mano, hanno eroso questa resilienza, questa capacità delle famiglie di far fronte alle complessità di un mondo che diventa più complesso. Ricordiamo che il tema della denatalità non è solo italiano, coinvolge tutto il mondo occidentale, tutta l’Europa, è una questione vasta, di carattere culturale, personale, come la persona si intende nel mondo. Ma, cosa succede? in Italia abbiamo i dati peggiori di tutta Europa, da tempo, ve l’hanno raccontato bene i nostri professori, in uno stesso contesto generale, culturale, economico, siamo riusciti a fare molto molto peggio di Francia, di Germania, dei Paesi Scandinavi, che pur oggi stanno vivendo delle complessità, ma si ritrovano di fronte a scenari migliori del nostro. Allora cosa ci hanno raccontato i nostri esimi professori? che noi siamo in una china che ha compromesso e sta compromettendo il futuro del paese, non è un decuius, una questione tra le tante, non è una questione di sfondo, lo faremo un giorno, è la questione dell’oggi, dell’ieri probabilmente, dopo dieci anni in cui, dodici anni, cos’è dal 2008 abbiamo avuto l’ultima impennata verso il basso, dove siamo stati i peggiori in Europa, noi non possiamo limitarci a fare piccoli aggiustamenti, dobbiamo fare dieci anni in cui siamo i migliori d’Europa, il paese di riferimento dell’Unione europea su questa tematica. E questa è la sfida, è la sfida che le famiglie si aspettano, quando ci chiamano, quando le associazioni ci coinvolgono, ci dicono noi siamo preoccupati, tanti giovani ci dicono noi vorremmo avere un figlio, due figli, gli studi dicono che siamo ancora sopra il tasso di sostituzione come desiderio, però alla prova dei fatti, alla realtà dei fatti, questo non accade, non succede, perché perdiamo proprio quello che aveva detto in prospettiva prima il professor Blangiardo, questa parola importante che è il futuro, speranza, sicurezza. Perché un progetto così importante come quello di mettere al mondo un figlio è certo un progetto non basato su calcoli, su programmazione, sui fogli Excel, su dinamiche di stabilire quanto percepirai nei prossimi anni. Certo è che l’insicurezza, l’incertezza lavorativa, una prospettiva non chiara, orienta le scelte, che potrebbero essere coraggiose, invece al ribasso. Tant’è che uno dei nostri amici studiosi, il professor Rosina, parla molto spesso di giovani sempre meno orientati al rischio, sempre più ipercauti, per scegliere famiglia bisogna essere coraggiosi, lo dice anche spesso il Papa, per fare famiglia bisogna essere coraggiosi. Però noi dobbiamo mettere in condizioni le famiglie che hanno queste potenzialità di tornare a svolgere il loro ruolo, il loro ruolo per la natalità, il loro ruolo per essere laboratori di umanizzazione, di creazione di nuovi cittadini, di essere protagonisti della vita civile del paese, non persone che si arrendono di fronte alle difficoltà, sono alla fine contente se i propri figli lasciano il paese perché trovano la sicurezza da altre parti, ma famiglie che lottano oggi e sono dentro un contesto in cui si sentono alleate al sistema paese, che comprende il Governo, il Parlamento, le attività economiche, produttive, il mondo dell’università. Oggi serve una grande alleanza strutturale per investire sulle famiglie, e partiamo però da un punto molto molto complesso, siamo come su una scala mobile che ci sta trascinando piano piano verso il basso. Non bastano piccoli passettini ma servono dei grandi passi in avanti, abbiamo tre spread principali rispetto ad altri paesi europei, l’hanno segnalato poco fa i nostri amici. Il primo è lo spread dell’occupazione femminile, abbiamo un’occupazione femminile assolutamente al di sotto degli standard di altri paesi europei, e ci sono molti molti motivi che portano a questo. La Ministra Roccella certamente questa cosa ce l’ha a cuore, ce l’ha in mente, le donne possono lavorare, è un patrimonio del paese fare in modo che le donne possano lavorare ma devono essere messe nelle condizioni reali di poterlo fare. C’è poi uno spread che è quello della autonomizzazione dei giovani, la destabilizzazione delle famiglie d’origine. I nostri ragazzi escono dalle famiglie d’origine molto molto più tardi che negli altri paesi, diventano protagonisti delle loro vite molto più avanti, e questo è un problema. Il terzo spread è il momento in cui questi giovani si trovano nelle condizioni di poter progettare di avere una vita familiare e magari un figlio, che è molto più avanti rispetto agli altri paesi europei. E voi sapete che la fertilità umana non è una linea orizzontale, va calando, e anzi in quest’epoca va calando molto di più. Queste sono tre sfide che abbiamo oggi, sono tante questioni da mettere in campo, serve energia, serve coraggio, ci consola che oggi si sia sentito in queste stanze, anche ieri, un grande desiderio anche da parte del nostro Governo di impegnarsi su questo, noi come famiglie, come Forum, ci siamo, ci mettiamo il coraggio, ci mettiamo l’entusiasmo, perché da qui c’è l’occasione di cambiare il futuro del paese.
Violini. Grazie, grazie, mi sembra che il quadro sia sufficientemente preoccupante per poterci attivare nella seconda parte del nostro incontro, in cui proveremo anche a identificare qualche ipotesi per uscire da questa situazione. Do la parola a Peppino Zola che ci dirà qualcosina sui nonni, vediamo cosa vuole dirci.
Zola. Lo dirò leggendo. Leggerò, ma per spiegare cosa c’entrano i nonni con questo tema, perché noi normalmente siamo ultrasessantacinquenni, siamo nella fase finale della nostra vita, non finale, nella fase di compimento della nostra vita, e quindi sembrerebbe che il problema non ci riguarda. Credo che ci siano almeno due motivi per cui invece ci riguarda, e per cui è bene che i nonni siano implicati in questa questione. Il primo motivo direi che è di ordine, scusate la parolona, di ordine ontologico, e mi spiego perché uso questa parola così grossa e così impegnativa. Ritengo che uno dei motivi per i quali oggi si fanno pochi figli, almeno nel nostro esausto Occidente, è che stiamo perdendo la coscienza di essere parte di una storia, che lega indissolubilmente tra di loro le diverse generazioni, stiamo perdendo la coscienza di questo legame, e con essa il desiderio di vedere continuare questa storia, di contribuire a perpetuare nel tempo quella discendenza, che nella tradizione ebraica, e poi cristiana, è sempre stata giudicata come una grande benedizione, e molti dei Salmi che recitiamo ce lo ricordano, ma anche la tradizione classica vedeva come un bene la procreazione. D’altra parte però, come recentemente sottolineato in un articolo di Lucetta Scaraffia, non si può non ricordare come l’attuale situazione sia stata determinata anche, non solo ma anche, da una precisa corrente culturale che nell’ultimo mezzo secolo ha dipinto come via maestra per la felicità, quella dell’unico figlio desiderato e della libertà di non avere figli. Dopo avere sottolineato come adesso è molto più difficile invertire il trend demografico, dopo che si sono trasformate da cima a fondo le condizioni della biologia e della riproduzione culturale della nostra società, la professoressa Scaraffia aggiunge che sarebbe ora che questa stessa cultura, se non vuole essere ipocrita, chieda scusa per l’abbaglio in passato. Ma queste scuse non sono ancora arrivate, personalmente ritengo che non arriveranno mai, e questo complicherà il lavoro positivo che dovremmo svolgere. Non a caso quando abbiamo costituito l’ “Associazione nonni 2.0”, abbiamo fatto riferimento nel manifesto fondativo alla nostra funzione specifica, che è quella di essere, anche nel mondo attuale così smemorato, custodi della memoria, e quindi capaci di essere attivi testimoni delle virtù e delle esperienze che, alle prove del tempo e della vita, si sono dimostrate utili e valide per affrontare le sfide personali e sociali del tempo presente, e tra queste sfide vi è quella fondamentale che riguarda proprio la procreazione. Sul nostro sito si può trovare il testo di un importante intervento sul tema dei passaggi tra le generazioni. La professoressa Eugenia Scabini della Cattolica, a proposito della catena generazionale familiare, dice che la generazione, come rapporto tra generante e generato, è talmente strutturale al nostro essere che la troviamo al centro della nostra identità. Infatti i generanti sono sempre generati, i genitori sono sempre figli, chi ha dato vita alla nuova generazione è figlio della precedente, e pertanto fare i conti con la tradizione non è un optional, vuol dire fare i conti con la propria storia familiare, e con il popolo, e con l’humus simbolico che l’ha nutrita. Quando si indebolisce il legame vitale tra le generazioni, si indebolisce la coscienza di appartenere ad un popolo e ad una storia, il che produce il disamore verso l’avventura più affascinante che il Signore ci ha affidato, che è quella di partecipare al suo genio creativo. Ancora la professoressa Scabini invita a pensare per generazioni, indicandolo come il primo compito culturale ed educativo degli adulti, io dico il compito fondamentale dei nonni. Occorre quindi incentivare alleanze tra adulti, perchè se è difficile trovare il maestro, quello carismatico che la vita concede poche volte di incontrare, è possibile però cercare e creare una fratellanza generativa tra adulti che condividono la stessa condizione di responsabilità verso la generazione successiva. Tale responsabilità è un compito che compete all’adulto in quanto tale, in primis a chi ha un ruolo educativo. Quindi il problema è quello di interrogare il passato, ma anche interrogare il nuovo che si affaccia, costruendo insieme nuovi patrimoni, un compito essenziale che, insieme ad altri fattori, può aiutare a far tornare il desiderio di vedere compiersi il miracolo della fecondità nelle giovani coppie. In questa prospettiva è fondamentale la funzione dei nonni, perché anche solo con la loro presenza fisica, essi sono una testimonianza viva che apparteniamo ad una storia, che viene da generazioni passate, e quindi apparteniamo ad un popolo che abbiamo la responsabilità di far continuare nella storia. Siamo confortati in questa direzione per l’insegnamento costante di Papa Francesco che in numerosissime occasioni ha sottolineato quanto sia importante la funzione educativa dei nonni sotto ogni profilo. Proprio in questi giorni in Portogallo, il Papa ha ripetuto in varie occasioni che occorre dare vita ad una alleanza intergenerazionale. Penso che dobbiamo tutti impegnarci in questa direzione, tutti, ognuno di noi, la cultura e la politica. I nonni infatti sono portatori di una visione amorosa della vita, che può dare speranza ai propri figli nel non avere paura, nel dare piena attuazione del compito generativo, per questo la presenza dei nonni aiuta la coscienza dei figli a non vivere il compito generativo come se fosse un nemico, e a smontare l’inaudito coraggio di non avere figli, per dirla alla Chesterton. Ricordando il tema di questo Meeting, si può dire che i nonni sono naturalmente amici del proprio ambito familiare, e quindi della più ampia società, è imprescindibile allora fare riferimento ad essi. Ma vi è un secondo motivo più pratico per il quale i nonni devono essere chiamati a dare il proprio contributo alla tematica di cui stiamo parlando. Il motivo è sotto gli occhi di tutti, i nonni, senza che alcuna legge lo preveda, senza che lo Stato onnipotente glielo chieda, aiutano in misure enormi i figli a mettere al mondo bambini e bambine, mediante i vari servizi che gratuitamente, quotidianamente mettono in atto per aiutare le famiglie che vengono dopo di loro. Una recente ricerca del census bureau americano ha dimostrato ad esempio che negli USA più di sei milioni di minorenni vivono a casa dei nonni, a conferma che essi sono essenziali per ridare forza alle realtà familiari. Quanti figli e figlie sono nati perché i genitori sapevano che poi sarebbero stati aiutati dai propri genitori, cioè dai nonni delle nuove creature. Questo è un dato imponente, anche perché il 70% dei nonni è autosufficiente, e quindi aiuta, ma questo è un dato taciuto, di cui la cultura e la politica devono prendere atto definitivamente. Cioè si deve prendere atto che in questa società i nonni costituiscono una componente spessissimo essenziale di ogni famiglia, e quindi tale componente deve essere maggiormente valorizzata e aiutata. Perché ad esempio non defiscalizzare gli aiuti economici che i nonni danno alle famiglie dei propri figli e dei propri nipoti, perché non permettere ai nonni di partecipare, su delega dei genitori, alle assemblee degli organi collegiali della scuola a cui spesso i genitori non possono partecipare per motivi di lavoro, perché non coinvolgere maggiormente i nonni nelle procedure dolorose che riguardano le famiglie in crisi, perché non valorizzare di più i nonni autosufficienti che possono sostenere quelli non autosufficienti sulla base del principio di sussidiarietà, cosa che la legge delega sugli anziani massicciamente statalista, ignora del tutto, perché non riprendere in considerazione sui temi pensionistici l’opzione donna, che permetterebbe a molte donne di svolgere con efficacia la propria funzione di nonne, perché non dare piena attuazione a quanto detto oggi, nell’incontro fatto proprio oggi, organizzato dalla rete delle famiglie, dalla rete “Ditelo sui tetti”, dove è stato chiesto che tutta la riforma del fisco, che è in atto proprio in questi mesi, tenga conto del soggetto principale e centrale della famiglia. Noi siamo certi che la componente familiare dei nonni può avere una parte importante nel ridare ai propri figli quella speranza che può sostenere la loro decisione di concepire figli, anche perché i nonni sanno per esperienza che la vita spesso è dura, ma sanno anche che essere sostanzialmente positiva, e che ogni difficoltà può essere superata, soprattutto in un contesto di solidarietà tra generazioni. I nonni trasmettono speranza ai figli e nipoti, è la speranza elemento essenziale per decidere di impegnarsi nell’opera generativa. La cultura e la politica ne tengano conto. Grazie.
Violini. Grazie, grazie infinite a Peppino Zola, il suo impegno politico non finisce mai, è sempre più vitale, e sempre più sfidante per noi che seguiamo le orme di questi giganti. Ancora un paio di interventi e poi chiuderemo con l’intervento della Ministra Eugenia Roccella. Il secondo giro parte ancora da Gian Carlo.
Blangiardo. Il secondo punto era, al di là del raccontare ciò che sta accadendo e le conseguenze che ne derivano, che cosa si potrebbe fare. Intanto dobbiamo mettere in conto che la strada è in salita, per due motivi. Primo perché coloro che devono fare i figli sono spesso i figli unici che hanno inevitabilmente avuto un tipo di formazione diversa dalle generazioni precedenti, e quindi sono anche forse meno propensi ad accettare certe situazioni più di sacrificio, e fare delle scelte prima di avere avuto le sufficienti garanzie che queste vadano in direzione giusta, e questo è un primo problema. Il secondo problema è più di tipo strutturale, e cioè le mamme. Oggi ci sono dodici milioni di donne in età feconda, nell’arco di quattro decenni avremo otto milioni di donne in età feconda. È evidente che se l’anno scorso sono nati 393.000 bambini, metà scarsa, un po’ meno della metà sono donne, sono bambine, queste saranno poi le mamme di domani, e meno ci sono mamme meno si può fare, a meno di accrescere la produttività individuale. Allora che fare per cercare di aiutare a realizzare quegli obiettivi, quei desideri, che come ricordava prima lui, sono ben presenti nella popolazione. Ebbene, aiutare ad assumere una maggior responsabilità i nostri giovani nel fare le scelte di autonomia e di vita di coppia, di genitorialità. In questo senso può esserci un aiuto da parte di alcune forme di intervento, adesso penso al discorso della casa, al discorso del lavoro, cioè siamo di fronte a situazioni nelle quali è ben chiaro quali sono i punti critici, si tratta di intervenire, dosando magari gli interventi compatibilmente con le risorse, per fare in modo che si cerchi di attenuare, se non proprio di eliminare, queste situazioni di natura critica. Il discorso della cura, ma i figli costano, i figli costano anche in termini di tempo, non solo in termini di soldi, quindi c’è il discorso del ben venga l’assegno universale, sono tutti passaggi che, se andiamo a confrontarci col passato, noi qualcosa, ne parlavamo venti-trent’anni fa, è cambiato negli ultimi anni, ed è cambiato in positivo. Io credo quindi che stiamo andando nella direzione giusta, è difficile però riuscire a continuare a proseguire anche per vari motivi, le stesse risorse. Quindi il discorso delle strutture di cura, il discorso del costo dei figli, il discorso di una partecipazione più generalizzata, di un atteggiamento culturale più positivo, cioè io ho detto in altre occasioni non dobbiamo passare da smettere di dire li volete? sono fatti vostri. No, sono fatti vostri ma sono anche fatti nostri, perché poi i vostri figli pagheranno le pensioni e la sanità a noi, anche a noi che non li facciamo. Quindi ben vengano anche situazioni fiscali nelle quali si dà la possibilità a chi fa i figli di avere diciamo pure posizioni di privilegio, semplicemente perché investono dei soldi nell’interesse collettivo e ci pagano sopra le tasse. Questo io credo che sia ingiusto, questo è un’altro elemento. Infine c’è questo obiettivo, negli Stati generali della natalità si diceva arriviamo al mezzo milione, partire da 393.000, e quest’anno probabilmente saremo ancora più sotto, sarà difficile, proviamoci. Per provarci dobbiamo chiamare all’appello tutti, quindi non è solo una questione dello Stato, lo Stato farà la sua parte, il Governo farà la sua parte, le Amministrazioni locali devono fare la loro parte, il privato sociale deve fare la sua parte, il mondo imprenditoriale deve fare la sua parte. Perché è giusto il welfare aziendale, con iniziative anche a carattere locale si possono ottenere dei risultati che possono avere degli effetti sulla comunità locale. Io credo che questo, anche all’imprenditore che si è realizzato, potrebbe dare una certa soddisfazione l’idea del vedersi riconosciuto un ruolo importante nella propria collettività. Allora dobbiamo chiamare all’appello tutte le forze che sono necessarie, ormai credo che si sia capito, è chiaro, cioè qui non c’è bisogno di continuare a ripetere i numeri che io vado ripetendo da tempo, perché ormai questi numeri sono entrati nella testa, cambia qualcosa ma la tendenza è chiara a tutti. Dobbiamo passare dalla informazione all’azione, abbiamo consapevolezza che c’è un problema, se questo problema richiede dei sacrifici qualcuno magari dovrà pagare qualche tassina in più, la paga se sa che serve, quando è il momento del bisogno gli italiani non è che si tirano indietro. Allora dobbiamo fare in modo che la conoscenza, i dati statistici e la consapevolezza, porti a questo tipo di atteggiamento. Io credo che queste iniziative, altre analoghe, abbiano proprio questo scopo, e mi auguro che si possa in qualche modo proseguire lungo questa direzione. Grazie.
Violini. Grazie. Allora anche qualche parola all’economista che ci aiuti a concretizzare questo percorso.
MATTEO RIZZOLLI. In ordine logico forse l’intervento di Adriano dovrebbe venire per primo, perché Adriano sicuramente quello che dirà in seguito ha a che fare con l’abbattimento del costo del fare i figli, cioè ci sono vari modi per farlo, in Italia abbiamo scelto recentemente di farlo tramite l’assegno unico. Vorrei dire che su questo do per scontato che questo va fatto, e va fatto meglio di come l’abbiamo fatto ora, e Adriano ci dirà delle indicazioni su come va fatto. Però io vorrei fare un passo in più, perché credo che nonostante questa sia una condizione necessaria, quella di fare l’assegno unico fatto bene, non sia una condizione sufficiente. Nell’ ’86 un demografo, un economista, scriveva questo articolo, nell’ ‘86 era un preveggente, si spiega col fatto che era ungherese, quindi l’Ungheria, come tanti paesi dell’est Europa, già vivevano l’esperienza della bassa natalità. Quindi si poneva questo problema di che cosa fare nei paesi a bassa natalità partendo dall’assunto che lui diceva: i dati ci dicono che i soldi non bastano, sono necessari ma non sufficienti. Allora lui viene fuori con quattro proposte, ve ne racconto due di queste proposte che hanno a che fare, sono proposte radicali, sono proposte visionarie, qualcuna forse potrà far sorridere, però vi invito invece a prenderle sul serio, perché forse è la radicalità di cui abbiamo bisogno oggi. La prima proposta che vi sottopongo è quella di estendere il voto ai minori, finora tutte le democrazie si dichiarano a suffragio universale, però ignorando il fatto che i tempi dove da noi il 16% della popolazione sono minori, in India il 40% della popolazione non vota sono cittadini ma non esprimono un voto. E questo ha delle conseguenze su come vengono spese, la finanza pubblica, ha delle conseguenze enormi sulla finanza pubblica, in Italia, stime di una Fondazione tedesca, per ogni 7 euro spesi su politiche che interessano le generazioni anziane, in particolare sanità e pensioni, se ne spende 1 sulle politiche che interessano le generazioni giovani, educazione, scuola, reddito di cittadinanza e politiche per l’impiego, 1 a 7 è la relazione, questo perché? sa benissimo la Ministra, perché elettoralmente non paga promuovere le politiche familiari, perché tanto i minori non votano, i pensionati votano, i minori non votano. Quindi paga elettoralmente molto di più fare delle proposte sulle pensioni. Ora come si fa a far votare i minori? l’idea è quella di dare ai genitori la rappresentanza, siccome i genitori si occupano dei minori seguendo tutti i loro interessi tranne il loro interesse politico, l’idea è quella di affidare ai genitori anche la difesa dell’interesse politico dei minori. Questa è la prima risposta, da approfondire ma lo farei molto volentieri se ci sono delle domande dopo. La seconda idea che riprendo, è emersa in un paio di passaggi, l’idea di opzione donna, cioè l’idea di collegare le prestazioni pensionistiche future alle scelte di fertilità oggi. Perché? perchè fare un figlio oggi vuol dire fare un contribuente di domani, che pagherà le pensioni sia di quelli che i figli li hanno fatti, sostenendo i costi privati per educarli, per crescere, sia di quelli che i figli non li hanno fatti. Collegare le prestazioni pensionistiche alle scelte di fertilità è un modo per rimettere la scelta di fertilità al centro di questo circuito sociale. Se mi permettete però rispetto a opzione donna, opzione donna com’è fatta? innanzitutto guarda al passato, alle scelte che sono già state fatte quarant’anni fa, che non possiamo più modificare. Chi quarant’anni fa ha deciso di non fare dei figli non è che con opzione donna può tornare indietro, quindi la prima idea potrebbe essere quella di guardare al futuro, un passare dalla logica dei diritti acquisiti, per cui dei diritti che potevamo permetterci in passato e adesso non possiamo più permetterci per le generazioni che vengono, passare a una logica di diritti acquisendi, magari le generazioni di oggi rinunciano a dei diritti e li consegnano alle generazioni che verranno. Per cui quelli che oggi fanno dei figli, decidono oggi di fare dei figli, tra quarant’anni matureranno questo vantaggio, questo potrebbe cambiare la natalità, ovviamente retroattivamente non la possiamo cambiare. La seconda questione che sollevo ha a che fare con perché opzione donna? le scelte di natalità si fanno in due, e se in due si cresce una famiglia, si crescono i figli che contribuiranno a pagare le pensioni di domani, questo vantaggio dovrebbe essere riconosciuto ad entrambi, non solo alle donne. Queste sono le due questioni.
Violini. Grazie, grazie anche di questi due spunti, il costituzionalista capisce che la strada è in salita ma ci si può lavorare, ci si può pensare, anche perché il fatidico articolo 31, e qui abbiamo autopromozione della materia, c’è scritto proprio che la Repubblica dovrebbe favorire famiglie numerose. Adesso penultimo intervento prima dell’intervento della nostra Ministra.
Bordignon. Io provengo da cultura contadina, abbiamo di fronte un campo che va coltivato a fondo con una necessità di avere risposte immediate, perché, come dicevamo, c’è un’urgenza che ci chiama, ma anche risposte di prospettiva. Quindi abbiamo bisogno di un po’ di orticoltura, cose che da subito danno un segno che facciamo un investimento, ma anche di piantare alberi, e avere il coraggio e la pazienza di lasciarli crescere, di curarli giorno dopo giorno, e di fare un investimento di lungo periodo. E’ questa probabilmente la richiesta che oggi viene fatta alla classe dirigente di questo paese, e come è stato ben ricordato non è solo chi sta al Parlamento o al Governo, ma è una responsabilità di tutti i corpi sociali intermedi, del mondo delle imprese, del mondo accademico, del terzo settore, è una cosa che ingaggia tutti quanti noi. Allora come Forum pensiamo che ci siano delle necessità stringenti e urgenti, certamente la leva economica che è stata toccata poco fa, è necessaria, ma per dire prima di tutto alle famiglie che il figlio non è un costo individuale della famiglia, ma è un bene per il quale si merita un investimento di una comunità. E questa è una scelta che va fatta da subito, da oggi, e ci sono molte prospettive, molti esempi anche, che sono stati messi in campo. L’assegno unico è uno di questi, deve essere migliorato, a nostro avviso deve essere reso più semplice, più generoso, più universale, più puntuale, perché a volte non arriva in tempo e mette in croce le famiglie. A fianco a questo abbiamo una stagione molto interessante, perché stiamo parlando di riforma fiscale, e consola e dà grande speranza sentire i nostri Ministri e Sottosegretari in questi giorni parlare di quoziente familiare, a rinforzare anche quello che Giorgia Meloni, il nostro Primo Ministro, ha detto in campagna elettorale, che ha convinto molti di noi dell’associazionismo familiare. Il tema del quoziente familiare per noi è importante, è una misura di equità fiscale verso le famiglie prima di tutto, e può essere anche uno spazio di investimento. Per quanto ci riguarda si chiami quoziente familiare, se opti per lo splitting alla tedesca, per il fattore di famiglia fiscale promosso da sempre dal Forum, in realtà a noi poco conta, per noi oggi interessa percorrere delle strade. C’è poi la via dell’organizzazione di questo paese, fare i genitori, diventare genitori è complicato, e quindi le leve dei giovani che diventino protagonisti della loro vita e aperti alla vita, è una delle leve da mettere davanti. C’è la questione dello studio, la questione dell’anticipazione del lavoro, la questione dell’abitare che sono essenziali. Noi dobbiamo fare di tutto per fare sentire i nostri figli benvoluti, attratti da questo paese, desiderosi di essere protagonisti qui. A fianco a questo, l’hanno ben detto, c’è la questione femminile. Le nostre donne troppo spesso hanno vissuto in un paese non essendo riconosciute nella loro funzione sociale, educativa, economica, di coesione, e sono state date troppo spesso per scontate. Questo è un passaggio che va portato avanti con una normativa, con provvedimenti che poi concorreranno a un percorso culturale. Ma dietro a tutto questo cosa serve? serve fare dell’Italia un ecosistema in cui le famiglie si sentono ben accolte, si sentono sostenute e valorizzate, protagoniste e soggetti sociali, non un mero conglomerato di individui. Per far questo la sfida è grande ed è lunga, il percorso prevede l’impegno di tutti noi, noi cosa dobbiamo fare? dicevamo prima dal passare ad essere i peggiori d’Europa nell’ultimo decennio, dobbiamo essere un punto di riferimento in questo senso. Allora io mi permetto di suggerire alla Ministra Roccella, e tramite di lei anche a Giorgia Meloni, di cogliere l’occasione e di convocare nei prossimi mesi una conferenza intergovernativa sulla natalità, che faccia dell’Italia il protagonista di un percorso di cambiamento per la nostra Unione Europea affinché il tema della natalità diventi una questione di tutti e tutto quello che si mette sulla famiglia e sulla natalità non sia una spesa ma sia un investimento e come tale venga trattato. Si tratta quindi di cambiare prospettiva rispetto alle famiglie e non riconoscere come un mero aggregato una figura di sfondo, né come un luogo di problemi, ma come la vera risorsa di questo paese laboratorio di umanizzazione prima di tutto, come dice Papa Francesco, luogo dove si cresce, si diventa ragazzi, cittadini adulti, dove si diventa protagonisti di scelte di responsabilità per questo paese e per queste comunità, e poi appunto fare in modo che ci sia un futuro davanti a noi, perché la natalità prima di tutto è una questione di speranza.
Violini. La parola adesso alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.
Roccella. Intanto vi ringrazio di questo incontro però avete detto tutto voi quindi a me resta veramente molto poco. Quello da cui possiamo cominciare è proprio dal fatto che in Italia siamo quasi sostanzialmente all’anno zero per le politiche per la natalità e la famiglia, e le pari opportunità, perché come è stato detto più volte le tre cose sono molto connesse, quindi la questione delle donne, del lavoro femminile e delle pari opportunità per le donne, è estremamente centrale per la natalità, e ovviamente anche per la famiglia. Quindi dobbiamo prima di tutto inserire il problema italiano in un contesto internazionale, noi dobbiamo sapere che, del resto l’ha già fatto il professor Blangiardo, che la questione del calo demografico non investe soltanto l’Europa, e neanche solo il mondo occidentale, investe ormai un po’ tutto il mondo. Leggevo recentemente un articolo molto interessante sulla questione coreana, cioè la Corea, che fino a 25 anni fa era un paese poverissimo, fra i più poveri, ha avuto uno sviluppo tumultuoso, e fino a 25 anni fa aveva in media sei figli per donna. Oggi, dopo 25 anni, credo sotto addirittura all’1, anzi lo 0,8, cioè sta peggio di noi, molto peggio di noi. E l’intera Europa, anche quella che ha investito tanto sulle politiche familiari, che ha investito per tempo sulle politiche familiari, come la Francia, che è la nazione che forse ha individuato il problema più precocemente, già negli anni ‘80, oggi, anche qui leggevo un altro articolo in cui si vede che, non solo è sotto il famoso tasso di sostituzione, cioè i due figli per donna, prima era 2.1 adesso è diventato 2, fra l’altro ho notato, quindi anche lì si sta cercando di abbassare la soglia, non solo è sotto il tasso di sostituzione, e veramente il welfare francese è davvero molto ricco e si è investito tanto su questo problema, ma continua a scendere di anno in anno, anche quest’anno la natalità continua a scendere. Quindi è un problema che non investe soltanto, insisto, il nostro paese, e perché? perché da tanto, tanto tempo ci sono politiche internazionali e c’è un clima culturale antinatalista. Rizzolli ha parlato delle politiche maltusiane, io ricordo che negli anni ‘80, cioè mentre la Francia più lungimirante iniziava le proprie politiche di sostegno alla natalità, il Segretario generale dell’ONU di allora, Perez de Cuellar, dava un premio alle politiche del figlio unico in Cina, politiche tra l’altro molto autoritarie, violente, che hanno provocato grandi sofferenze alle persone. E negli anni ’60, anche questo Rizzolli ha vagamente ricordato, in Italia c’era il Club di Roma, cioè un importante circolo di intellettuali di altissimo livello, scienziati e intellettuali di altissimo livello, che dicevano proprio che c’era uno squilibrio fra le risorse e la popolazione, e quindi per riequilibrare bisognava intervenire sull’unico punto su cui si poteva intervenire, perché secondo loro le risorse non potevano essere moltiplicate, pani e pesci non si potevano moltiplicare, e quindi bisognava frenare la crescita demografica, e intervenire con politiche antinatalista, e questo è stato fatto, è stato fatto in maniera estremamente pressante, pesante e diffusa. E adesso si è ottenuto anche un clima culturale in cui l’essere genitori, l’essere aperti alla vita, al futuro, alla speranza, alla solidarietà intergenerazionale, alla continuità fra i nonni e i nipoti, e quindi proprio all’idea che la vita non sia soltanto un consumo dell’ora e qui, che la vita non si esaurisca in quello che noi possiamo consumare giorno per giorno, ma che sia anche qualche cosa di proiettato nel momento in cui noi anche non ci siamo più, che ci siano continuità, e che questa continuità sia fondamentale proprio per la tenuta sociale, per la coesione sociale, per la capacità, per la solidarietà anche, che è un elemento fondamentale del nostro vivere insieme. Tutto questo si è smagliato, e oggi, dice giustamente Bordignon, però l’Italia dovrebbe essere l’avanguardia di un cambiamento, di un’inversione a U. Io penso che noi lo possiamo fare, che l’Italia, benché sia tra i paesi proprio che meno hanno pensato alla famiglia, un po’ perché la famiglia la davano per scontata, le analisi sul familismo morale di Banfield negli anni ‘60 o ’70, ‘60 mi sembra, l’idea che l’Italia fosse fin troppo familista, un po’ è stata data per scontata. Un po’ c’è stato anche un problema ideologico nei confronti delle politiche nataliste che ricordavano un passato che non piaceva, e quindi l’idea che le politiche nataliste fossero una cosa che non si poteva assolutamente tornare a mettere in campo, anche se in maniera estremamente diversa. Quindi noi abbiamo sofferto tutto questo, siamo più particolarmente di altri paesi all’anno zero, l’unica cosa che è stata fatta, è stata fatta sostanzialmente, l’unico provvedimento strutturale alla fine della legislatura scorsa, l’assegno unico, che oggi è sotto procedura di infrazione a livello europeo, che questo governo difende, che ha implementato, poi parleremo delle cose che abbiamo fatto e che faremo, però fino adesso non abbiamo fatto molto per la famiglia e ancora meno per la natalità. Possiamo diventare i leader, a livello almeno europeo, di un cambiamento di rotta? possiamo, possiamo. Prima di tutto io penso che sia importante che la Presidente del Consiglio sia una donna, lasciatemi essere femminista a modo mio, io penso che sia una donna, che sia una mamma, è importante perché lei fino in fondo vive e capisce le difficoltà che hanno le donne nella libertà di avere figli, perché c’è un problema fra il desiderio di avere figli, che rimane ancora alto, le donne dicono ancora che vogliono due figli, e poi il fatto di farli, poi non li fanno, e non li fanno perché c’è un problema di libertà, c’è un problema di difficoltà, di difficoltà di conciliare quello che oggi sono le aspirazioni delle donne, cioè al lavoro, alla realizzazione professionale, ma non solo. Io sono stata accusata, sono stata equivocata, su una cosa che ho detto che riguardava lo spritz, è stato proprio rovesciato quello che avevo detto, perché siccome era stato detto c’è un’alternativa fra lo spritz e i figli, sostanzialmente fra un modo di vivere, uno stile di vita, per raccogliere le possibilità anche di divertimento, che può offrire alla contemporaneità, e dall’altro invece l’investimento sui figli. E ho detto non ci deve essere questa alternativa, noi vogliamo che le donne possono avere i figli e anche lo spritz, cioè non vogliamo che avere figli sia un sacrificio, non vogliamo che avere figli sia una rinuncia, ma che invece sia una libertà possibile, una gioia in più, una felicità in più, perché la felicità, e tra l’altro c’è una ricerca recente, non mi ricordo, anglosassone, che scopre che avere figli dà in effetti felicità, ma va!? tutte noi, tutti i genitori sanno che avere i figli certo vuol dire anche tante piccole differenze rispetto allo stile di vita di chi non ha figli, ma vuol dire anche un grande arricchimento, un grande arricchimento interiore, come è sempre fare qualcosa anche per qualcun altro, e non solo per noi stessi. Possiamo quindi rovesciare le cose? possiamo. E abbiamo cominciato a farlo, abbiamo cominciato a farlo prima di tutto proprio con il mio ministero, è la prima volta che si è aggiunta la parola natalità alla parola famiglia e pari opportunità, e io insisto è un insieme fondamentale, mettere insieme queste tre cose è un programma di Governo. Lo abbiamo fatto adottando un criterio trasversale, Bordignon ha detto facciamo una grande conferenza, ma noi lo facciamo con ogni Consiglio dei Ministri questo, perché il criterio della trasversalità è quello che abbiamo adottato fin dall’inizio, cioè non delegare solo al mio ministero, che ogni volta lo ripeto, fra l’altro è senza portafoglio, quindi con un’autonomia di spesa veramente inesistente, non delegare solo al mio ministero il compito, immane che farebbe tremare le vene nei polsi, di invertire il calo demografico, di frenarlo perlomeno intanto, e di tornare a dare la possibilità, ad aiutare le persone nella libertà di procreare. Ma abbiamo usato un criterio trasversale, cioè tutti i provvedimenti devono avere al fondo il criterio dell’attenzione alla famiglia e ai figli, tutti i provvedimenti, ed è così, lo abbiamo fatto con la delega fiscale, in cui abbiamo inserito proprio questo criterio, adesso poi passeremo ai decreti attuativi, quindi adesso si vedrà nella pratica le scelte che faremo da questo punto di vista. Lo abbiamo fatto nel provvedimento che ha sostituito il reddito di cittadinanza, che è mirato proprio sui figli, sulle famiglie coi figli, anche perché dovevamo intervenire sulla povertà infantile, che è la povertà più devastante che ci può essere, quindi mirando proprio su questo. Lo abbiamo fatto in piccoli provvedimenti e in provvedimenti più grandi, di maggior peso. Lo abbiamo fatto aumentando l’assegno unico, implementando l’assegno unico, in particolare per le famiglie numerose, perché le famiglie numerose sono poche, ma i figli che vivono nelle famiglie numerose sono una percentuale più alta, perché ovviamente, essendo famiglie numerose percentualmente sono una percentuale maggiore di quanto siano le famiglie con due, tre figli. Lo abbiamo fatto, qui ho tutti i provvedimenti che abbiamo preso, posso leggerli tutti: la riduzione dell’Iva sui prodotti della prima infanzia, l’incremento dei congedi parentali che sono passati per un mese dal trenta all’ottanta per 100, poi la decontribuzione per l’assunzione di giovani e donne, i mutui agevolati per la prima casa, il rifinanziamento dei centri estivi, che vogliamo assolutamente rendere strutturale, lo faremo nella prossima finanziaria. Gli esperti ci dicono che per aumentare la natalità bisogna cercare di far sì che le donne che vogliono il secondo figlio, le coppie che vogliono il secondo figlio, in realtà possano averlo, quindi che bisogna intervenire sul secondo figlio. Quindi io proporrò nella prossima finanziaria un pacchetto proprio di facilitazioni per il secondo figlio. Ma dobbiamo andare oltre, perché per esempio c’è un problema di solitudine delle mamme, proprio perché spesso i nonni non ci sono, perché magari le donne vivono in una città diversa da quella dei propri genitori o dei genitori del compagno, dai suoceri, eccetera, e sono sole. Adesso stiamo cercando di elaborare una legge che accompagni le donne anche nella maternità. Tantissime ragazze ormai non hanno mai magari preso un bambino in braccio, perché non hanno sorelle, non hanno zie, non hanno quella rete di parentela che una volta assicurava anche il passaggio delle informazioni sulla maternità, e quindi era rassicurante, e serviva anche a dare i primi aiuti. Tutte noi sappiamo che quando abbiamo avuto il primo figlio in braccio, oddio che cosa succede se ha il singhiozzo, come va messo a dormire, di lato, di pancia, di sotto, piange perché piange, come si fa il bagnetto, sono cose che una volta venivano trasmesse attraverso proprio la rete di parentela e la rete delle informazioni fra donne, oggi questo è sempre più difficile. Il nostro problema è accompagnare le donne, perché noi abbiamo un welfare molto protettivo nei confronti della maternità, ma adeguato a modi di vivere, a modi di organizzare il lavoro, di organizzare la città, tempi della città e del lavoro, eccetera, che non sono più gli stessi, quindi dobbiamo adeguarci, noi non vogliamo tornare indietro, vogliamo proprio costruire il futuro. Chi, tra l’altro, vuole aumentare la natalità, spera in una nuova primavera della demografica, vuole guardare al futuro, e quindi vuole costruire modi e provvedimenti che siano adeguati all’oggi, che siano adeguati proprio ai nuovi stili di vita, e ai nuovi bisogni. Quindi un accompagnamento alla maternità, per esempio attraverso servizi a domicilio, attraverso qualcuno che viene a trovarti. In conclusione voglio dire soltantoche si possono fare tante cose, alcune le abbiamo fatte, penso anche a un provvedimento che è nel PNRR, la certificazione di genere per le imprese, al codice di autodisciplina per le imprese, perché il problema è proprio costruire un welfare aziendale, non costruire, spingere verso un coinvolgimento delle aziende e un welfare aziendale attento alla maternità. Perché parlo sempre della maternità, non perché non considero il ruolo prezioso dei padri o non considero che per fare una famiglia ci vuole una mamma e un papà, ma perché sono le donne però che aspettano il bambino, passano la gravidanza e l’allattamento al seno, e il parto, e tutto questo poi diventa un problema per la prosecuzione della carriera, per lo sviluppo della carriera, si pagano dei prezzi specifici, e quindi bisogna dare degli aiuti specifici. Come è stato detto più volte dobbiamo coinvolgere tutti, qui voi siete tutti esperti di sussidiarietà, bene è quello che ci serve, cioè ci serve un’azione di governo incisiva, trasversale e compatta, e certamente su questo ci saremo, ci siamo, ma serve anche un coinvolgimento di tutti, delle aziende, degli enti locali, dei comuni, di tutti i soggetti in campo. Solo se riusciamo a fare, ad ottenere questo coinvolgimento, a stimolare proprio la sussidiarietà, riusciremo a frenare l’inverno demografico e ad essere, come è stato detto, leader di un cambiamento culturale.
Violini:
Grazie Eugenia, davvero hai fatto un bellissimo intervento. Grazie, grazie infinite. Dobbiamo chiudere in fretta e furia perché il tempo è tiranno, come sempre al Meeting e in altre circostanze. Ricordo solo che il Meeting vive con il contributo di tutti, sussidiarietà, come appunto ci siamo detti, “dona ora” chi può, chi vuole contribuisca alla vita di questo evento. Grazie infinitamente agli ospiti, grazie alla nostra Ministra, e cerchiamo di lavorare. Ciao.