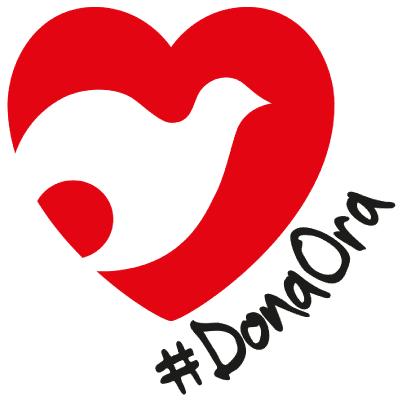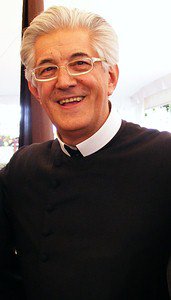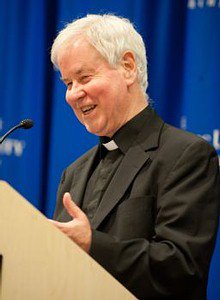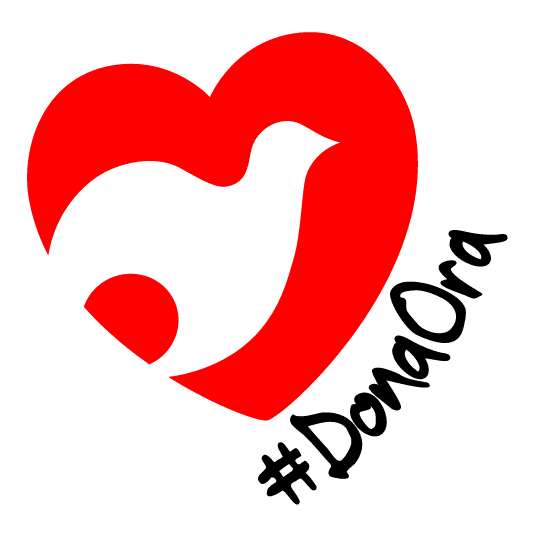Chi siamo
«COR AD COR LOQUITUR». LA CERTEZZA DI NEWMAN, COSCIENZA E REALTÀ
"Cor ad cor loquitur". La certezza di Newman, coscienza e realtà
22/08/2011 ore 15.00Presentazione della mostra. Partecipano: Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore Generale della Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii; Ian Ker, Fellow in Theology at the Oxford University. Introduce Javier Prades López, Decano Facoltà Teologica San Dámaso di Madrid.
Presentazione della mostra. Partecipano: Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore Generale della Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii; Ian Ker, Fellow in Theology at the Oxford University. Introduce Javier Prades López, Decano Facoltà Teologica San Dámaso di Madrid.
JAVIER PRADES LÓPEZ:
Raccogliendo la provocazione di Benedetto XVI, che nel suo viaggio in Inghilterra ha indicato il beato Newman come figura a cui guardare, soprattutto per la sua modernità, la mostra ripercorre l’itinerario della sua vita attraverso le tre conversioni che l’hanno caratterizzata, proponendo un percorso biografico e tematico da cui emerge come la coscienza sia stata la forza motrice di tutto il suo cammino verso la certezza della verità (ex umbris et imaginibus in veritatem, fece scrivere sul suo epitaffio) e come tale cammino abbia caratterizzato anche il suo essere educatore e amante della bellezza.
Sono con noi per guidarci in questo percorso Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore Generale della Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii e Ian Ker, Fellow in Theology at the Oxford University. Lascio subito la parola a Ian Ker.
IAN KER:
Quando Newman stava scrivendo la sua autobiografia teologica, la Apologia pro Vita Sua (1864), in cui voleva mostrare che la sua conversione al Cattolicesimo nasceva da uno sviluppo piuttosto che da una rottura, doveva senza dubbio avere avuto in mente il suo classico di teologia, Saggio sullo Sviluppo della Dottrina Cristiana (1845), che aveva scritto una ventina di anni prima. In quel saggio aveva parlato del processo di sviluppo della dottrina nella Chiesa; ora stava parlando dello stesso tipo di sviluppo di credenze dottrinali in un individuo. Similmente, quando arrivò a scrivere il suo magnum opus filosofico, Saggio a sostegno di una grammatica dell’assenso (1870) doveva senza dubbio avere avuto in mente il suo personale atto di assenso, venticinque anni prima, alla verità della Chiesa Cattolica.
Questo stato di certezza che infine raggiunse già nel 1845, lo descrive nel 1870 come la “percezione di una verità con la percezione che quella è una verità, ovvero la coscienza di sapere, così come espresso nella frase “Io so di sapere” oppure “Io so di sapere che so”, o semplicemente “Io so””. Il processo implica “l’accumulo di probabilità, indipendenti le une dalle altre, che sorgono dalla natura e dalle circostanze del caso particolare …. probabilità troppo fini per servire separatamente, troppo sottili e indirette per essere convertibili in sillogismi, troppo numerose e varie per una simile conversione, quand’anche fossero convertibili”. Ragionare nel concreto è diverso dalla logica formale, ma non è illogico. Newman insisteva: “solo non è più un’astrazione, ma portata nelle realtà della vita, le sue premesse essendo istinto con la sostanza del momento di quella massa di probabilità, che, agendo una sull’altra in modo da correggere e confermare, arrivano a una soluzione riguardante il caso individuale, il che è lo scopo originario”. Chiaramente, “un tale processo di ragionamento è più o meno implicito e, senza la diretta e piena avvertenza della mente che lo esercita… (essendo) la mente impari alla possibilità di un’analisi completa delle ragioni che la portano a una certa conclusione,…. (essendo) essa condotta e determinata da un corpus di prove che essa riconosce solo come intero e non nelle sue parti costituenti”. Essa, quindi, dipende da “prove che sono informali e personali, che sfidano i nostri poteri di analisi. E non possono essere condotte sotto il dominio della logica”. E così “i processi di ragionamento che legittimamente conducono alla … certezza sono, di fatto, troppo multiformi, sottili, di ogni genere, troppo impliciti, per permettere di essere misurati secondo una regola” poiché “essi sono, in fondo, personali”. Sono “personali” perché implicano “quel giudizio sopra-logico, che è la garanzia per la nostra certezza” e che “non è una parte costituente della nostra natura, ma una dote personale”. Quando noi sosteniamo di possedere certezza non logica in questioni concrete, “noi decidiamo, non che la conclusione deve essere ma che non può essere altrimenti. Noi diciamo che non riusciamo a vedere come potremmo dubitare, che è impossibile dubitare, che siamo costretti a credere…a partire da un senso di dovere, alla conclusione che abbiamo raggiunto”. Certezza, dunque, “non è un’impressione passiva che arriva alla mente dall’esterno…ma in ogni questione concreta…È un riconoscimento attivo di proposizioni che riconosciamo vere, e tale è il dovere di ogni individuo di esercitare l’offerta della ragione e quando la ragione impedisce di sapersi trattenere”. E Newman conclude che non c’è altra giustificazione per la nostra certezza al di fuori del nostro personale giudizio: “l’unico e definitivo giudizio sulla validità di un’inferenza in questioni concrete è sollecitato dalla personale azione delle facoltà raziocinanti, la perfezione della virtù che ho chiamato Senso Illativo”. Venticinque anni prima, nel 1845, Newman era giunto, quantunque lentamente, a questa “sicurezza intellettuale” sulla verità delle affermazioni della Chiesa Cattolica Romana. Nell’estate del 1839 aveva fatto esperienza dei suoi primi dubbi sulla cosiddetta Via Media, che lui stesso aveva collaborato ampiamente a sviluppare come guida del Movimento Trattariano di Oxford e che sosteneva che la Chiesa Anglicana era sia cattolica che “riformata”, ponendosi a metà strada fra Roma e Ginevra. L’occasione di questi dubbi iniziali era una inquietante analogia, che lo aveva colpito mentre studiava l’eresia Monofisita, fra questa posizione anglicana della “via media” e quella dei Monofisiti moderati, fra Roma e i più estremi Monofisiti Eutichiani. In seguito, nel settembre di quell’anno, la sua attenzione fu attirata verso una articolo sullo scisma Donatista nell’Africa del nord e fu dolorosamente colpito dalle parole taglienti di Sant”Agostino: “Securus judicat orbis terrarum” che Newman avrebbe tradotto liberamente come: “La Chiesa Universale è nel suo giudizio sicura della verità”. In altre parole, gli argomenti dei Donatisti erano vani dal momento che la Chiesa si era pronunciata contro di essi e la questione era chiusa.
I dubbi svanirono, ma avevano lasciato il segno. Nel febbraio 1841, Newman pubblicò il famoso o infame Trattato 90, in cui egli tentò di dare una interpretazione cattolica ai Trentanove Articoli, l’equivalente di un credo anglicano, che erano generalmente considerati come portatori del carattere intrinseco della Chiesa di Inghilterra. Il Trattato fu condannato sia dalla (allora) anglicana Università di Oxford, che in generale dai vescovi. Nel frattempo Newman aveva studiato ancora l’eresia Ariana e fu dolorosamente colpito dalla stessa analogia che lo aveva inquietato nella eresia Monofisita – poteva darsi che “gli Ariani puri fossero i Protestanti, i semi-Ariani fossero gli Anglicani e che Roma fosse ora quello che era stata ai tempi?”. E poi arrivò un terzo colpo: l’istituzione per motivi politici di un vescovato a Gerusalemme, alternato fra la Chiesa di Inghilterra e le chiese protestanti tedesche, un accordo che pareva chiaramente negare la cattolicità della Chiesa di Inghilterra. Nei due anni precedenti, Newman era ritornato sulla nota della santità, per provare che la Chiesa era una branca della Chiesa Cattolica; ora, egli accettò potenzialmente che la Chiesa di Inghilterra fosse scismatica ma che Cristo fosse ancora presente nei suoi sacramenti, mentre di fatto la Chiesa di Roma era corrotta e bisognosa di purificazione.
Ma le obiezioni dottrinali di Newman alla Chiesa Cattolica stavano gradualmente venendo meno. Nel corso del 1844 egli “pienamente… superò” le sue obiezioni alla dottrina e alla pratica di invocare i santi della chiesa Cattolica Romana. Trovò nella moglie del suo grande amico William Froude, Catherine, una confidente comprensiva con la quale poteva sfogarsi, rivelandole i pensieri che l’avevano così a lungo turbato. Aveva molte difficoltà, egli spiegò, riguardo alla teoria anglicana che la chiesa fosse “una”, perché era una “successione” in opposizione a “un regno, un corpo politico”. Pareva “molto irreale” – e per Newman il banco di prova della verità era la realtà – sostenere che, dal momento che ci poteva essere solo un vescovo e una Chiesa in un determinato posto, allora la Chiesa di Inghilterra, a causa della sua “successione”, aveva il “possesso”, quando tutti sapevano che la vera divisione fra le due chiese non era incentrata sulla successione ma sulla dottrina. Il fatto che gli Anglicani non avessero il sentimento di essere in comunione con la Chiesa Cattolica Romana quando erano in Paesi cattolici, mostrava che la teoria non poteva essere modificata – è un mero insieme di parole – i fatti la confondono. Poteva essere, egli domandò al suo amico John Keble, l’iniziatore del Movimento di Oxford, che si trovasse in preda a un’illusione, ma, nel caso, quale era il suo “difetto”? La verità era che le sue “convinzioni” continuavano tutte a crescere in una “direzione”. Gli pareva che Dio non lo avesse mai abbandonato ma lo avesse “condotto” passo dopo passo. Fin da quando i primi dubbi lo avevano assalito nel 1839, egli aveva tentato di condurre una vita più rigorosa. E sentiva di poter dire “con certezza che per molti aspetti il mio cuore, la mia condotta sono migliorati nel corso di questi cinque anni”, anche dal punto di vista di aspetti per cui aveva pregato per essere illuminato e guidato. Se quello era vero, “dunque la domanda mi assale, perché la Provvidenza avrebbe esaudito le mie preghiere su questi aspetti e non quando ho pregato per avere luce e guida?” Per di più la tentazione più grande era di stare nella Chiesa di Inghilterra.
“La perdita di amici che grande male è questo! La perdita di posizione, di nome, di stima – una tale umiliazione di me stesso – un tale trionfo per gli altri. Non è cosa orgogliosa “disdire” ciò che ho detto, tirare giù ciò che ho tentato di costruire. E ancora, ciò che mi trafigge davvero, la inquietudine della mente che un cambiamento da parte mia potrebbe causare in tante altre persone… le tentazioni alle quali molti sarebbero stati esposti di scetticismo, indifferenza e persino infedeltà”.
D’altro canto, temeva il pensiero di avere la responsabilità di far abbandonare ad altri la via della Chiesa Cattolica Romana, “coloro che hanno avuto una chiamata per aggregarvisi”. Per quanto tempo doveva aspettare? – “Ho combattuto contro questi sentimenti in me stesso e negli altri abbastanza a lungo”. Egli temeva che “una sorta di “latitudinarianismo” e liberalismo potesse essere la fine di coloro … che io sto tenendo lontani da Roma”. Talvolta, in verità, si sentiva “a disagio” con se stesso – “un carattere scettico e tutt’altro che lontano dalla mia natura – e si può capire che ci ricada considerandolo un giudizio”. Egli concluse la sua lettera come l’aveva iniziata: “Sto vivendo un’illusione, destinato a credere in una bugia?”. C’era “qualche sottile sentimento o tentazione” che non riusciva a “identificare” ma che lo stava influenzando? E in questo caso, Dio non gli avrebbe mostrato di che cosa si trattava? “Mi ha condotto fin qui per poi distruggermi nel deserto?” – un deserto perché Newman aveva dato le dimissioni da Pastore di St. Mary the Virgin e aveva predicato quello che sarebbe stato il suo ultimo sermone da anglicano nella chiesa di Littlemore, allora un piccolo paese fuori Oxford ma parte della parrocchia di St. Mary, dove viveva con alcuni compagni in isolamento. Nella sua Apologia Newman avrebbe scritto: “ora non era la logica che mi portava avanti …. È l’essere concreto che ragiona…l’uomo intero si muove; la logica messa sulla carta è solo il resoconto di questo”. Con Keble si chiede se forse, in alcun modo, una sorta di fallimento morale sia responsabile del suo stato d’animo; ma non solo la sua coscienza è chiara, può di fatto indicare una reale conversione morale da quando ha iniziato ad avere dubbi nel 1839. Ora, a Catherine Froude egli spiega che c’è anche stato uno sviluppo teologico (“l’uomo intero si muove”). Aveva sempre creduto nello sviluppo dottrinale nella Chiesa primitiva. Ma poi nel 1837, nelle sue Conferenze sugli Uffici Profetici della Chiesa, ebbe la concezione di una “Tradizione Profetica” esistente all’interno della Chiesa, che poteva aprire la possibilità di uno sviluppo “in ogni momento”. Ed ora, nel 1843, nel suo sermone per l’Università, La Teoria dello Sviluppo nella Dottrina Religiosa, si era spinto ancora oltre, affermando che “sviluppi non sono solo spiegazioni del senso del Credo, ma ulteriori dottrine che sono implicite e sorgono dai suoi articoli”. Era un “argomento o teoria” a cui egli aveva tentato di dare forma scritta per anni, almeno dal 1836. Era vero che non “aveva percorso tutta la dottrina che è necessaria” dal punto di vista Cattolico Romano, ma lo stesso non aveva “avuto difficoltà a ricevere il sistema nella sua concretezza”. Era “di gran lunga più certo” che la Chiesa d’Inghilterra fosse scismatica, piuttosto che gli sviluppi dottrinali Cattolici Romani fossero “non veri”. Ammesso che “non si trovavano espressi nella Chiesa primitiva” tuttavia c’erano “sufficienti tracce di essi in essa tali da riconoscerli e darne prova basandosi sull’ipotesi che la Chiesa avesse un guida divina, benché non sufficienti per essere provati in sé”. Inoltre c’erano “più prove nell’Antichità”, per alcune dottrine Cattoliche Romane, di quanto ce ne fossero per alcune dottrine che gli Anglicani a loro volta consideravano – per esempio “per la necessità dell’Unità piuttosto che la Successione Apostolica – per la supremazia della Sede di Roma piuttosto che per la Presenza nell’Eucaristia – per la pratica dell’Invocazione piuttosto che per certi libri nel presente Canone delle Scritture”.
Giunto a questo punto, Newman era “circa” altrettanto certo che la Chiesa di Inghilterra non fosse “parte della Chiesa” di quanto qualsiasi cosa in cui credeva; davvero era certo che “la battaglia” contro questa convinzione stava “danneggiando la sua fede in generale, e … stava mettendo una patina di scetticismo nella sua mente”, a tal punto che egli era “spaventato” e non riusciva a dire dove sarebbe finita, se egli avesse “osato ignorare una voce” che gli aveva per “così lungo tempo parlato”. Era persino spaventato quando viaggiava di poter morire prima di poter fare ciò che doveva fare. Aveva aspettato a lungo ed era pronto ad aspettare una “prova decisiva” che non si stesse ingannando, ma “se portato al limite della vita”, egli supponeva che “si sarebbe sentito in dovere di agire così come è in generale più prudente, date le circostanze”. Per diversi anni si era comportato come “una persona che si dà dei pizzicotti per essere sicura che non sta dormendo o sognando”. Sentiva di aver fatto tutto quello che poteva per disperdere quella che poteva essere una “illusione ingannevole” ma non riusciva a “scuotersela di dosso”. Altri avrebbero potuto provare a spiegarla brevemente – come gli amici di un “paziente malato di tisi” che “mostrano che nessuno dei sintomi si può associare a cause varie tranne la malattia fatale”. Lo stesso, non poteva dire di avere ancora raggiunto la “certezza” – ma “si stava avvicinando” e davvero era ormai “certo che l’avrebbe raggiunta prima o poi”. Questo grande filosofo della mente non poteva fare a meno di essere affascinato persino nel bel mezzo del suo tormento mentale, causato dal lavorio della sua mente. Come poteva rendere “giustizia” ai suoi “ragionamenti”: “essi non sono presenti – l’impressione resta, ma il processo argomentativo è come un’impalcatura che si toglie quando la costruzione è completata… non riuscivo a ricordare tutti gli elementi che avevano contribuito a formare le mie convinzioni, né potevo rappresentarlo ad altri con la stessa forza con cui si erano presentati alla mia mente. Le conferme stesse sono in generale delle coincidenze che risultano da certi percorsi del pensiero o da fatti che richiedono una certa struttura mentale per essere riconosciuti…”.
Questa comprensione sottile della mente potrebbe, in assenza dei riferimenti autobiografici, risultare direttamente dalla Grammatica dell’Assenso.
Tuttavia non gli pareva di avere ricevuto nessuna “chiamata” a lasciare la Chiesa d’Inghilterra. E aveva anche “un grande terrore di procedere guidato dai sentimenti per paura che potessero portarlo fuori strada”. Riusciva solo ad agire per “senso del dovere”. E c’era un altro fattore che tipicamente Newman vedeva come parte del processo che conduceva alla certezza: malgrado avesse “pochi dubbi” su dove sarebbe stato “alla stessa ora fra due anni”, la sua “immaginazione” non riusciva ad “abbracciare l’idea”. Così l’immaginazione a sua volta deve essere capace di concepire l’inevitabile secessione verso Roma, prima che la certezza potesse essere raggiunta. Ritirandosi da Oxford, aveva “obbedito a un urgente e imperativo richiamo al dovere”. Ma che sarebbe stato se tutti i suoi sacrifici fossero stati dedicati “a un sogno”? Restava nella Chiesa d’Inghilterra solo a causa di “un timore di essere preda di un’illusione”. Ma le “ragioni per le quali io credo tanto quanto ci insegna il nostro sistema, devono portarmi a credere di più – e non credere di più corrisponderebbe a cadere nello scetticismo”. E tuttavia continuava a sentire di doversi “mettere alla prova ulteriormente” – anche se non era conscio di avere omesso nulla nel tentativo di rompere l’incantesimo, se si tratta di un incantesimo”. Ciò nondimeno, anche con un miracolo, egli dubitava di poter avere “convinzioni più chiare” di quelle che già possedeva. No, sarebbe diventato un Cattolico Romano “domani”, se non fosse stato per la “paura che ci sia qualche difetto segreto che è all’origine della mia credenza, che mi tiene in questa posizione di attesa”. Egli non aveva “alcuna” fiducia che stesse “agendo per fede o amore”, benché non riuscisse a “individuare motivazioni cattive”. Semplicemente non riusciva ad “analizzare” la sua mente – “mi sento molto irreale”.
Nel febbraio del 1845, i capi dei college votarono di sottomettere al corpo dirigente dell’Università la censura formale del Trattato 90. Newman non se ne preoccupò per nulla: era per ogni scopo un “uomo morto” e le autorità universitarie non potevano fargli del male. In verità, ammetteva che sarebbe stato contento “parlando egoisticamente” se la censura fosse passata – “A lungo, davvero, ho cercato circostanze esterne che decidessero del mio percorso – e non desidero che questa luce del giorno sia ritirata”. Ma tutto ciò sarebbe davvero bastato per farlo andare a Roma? Poiché non aveva ancora una sufficiente certezza di azione: “non riesco a distinguere se sono sospinto da ciò che mi pare chiaro o da una senso del dovere”. Nell’aprile stava leggendo la autobiografia di recente pubblicazione del sacerdote spagnolo ex cattolico Blanco White, che era divenuto una pastore anglicano ed era giunto a Oxford dove era diventato amico di Newman. Il libro mostrava come Blanco avesse abbandonato la sua fede nella divinità di Cristo e avesse finito per diventare panteista. Newman vedeva evidenti debolezze morali nell’autore, che rendevano ragione del suo graduale abbandono del cristianesimo. Aveva anche lui dei difetti sconosciuti a se stesso, che erano responsabili del suo presente stato d’animo? Che cosa, tuttavia, l’autobiografia dimostrava eloquentemente era che “per essere coerente un individuo deve credere più o meno di quanto era abituato a credere”. Malgrado avesse raggiunto una certezza potenziale che la chiesa di Inghilterra fosse scismatica, Newman continuava a credere che essa avesse la Successione Apostolica e sacramenti validi. Alla fine del 1844 aveva deciso di scrivere un Saggio sullo Sviluppo della Dottrina e poi, se alla fine di questo lavoro “le mie convinzioni a favore della Chiesa Romana non fossero state più deboli, di fare i passi necessari per essere ammesso nel suo gregge”. Il progetto gli era rimasto in testa dal marzo di quell’anno. Sfortunatamente, nel giugno del 1845 dovette confessare a Cahtherine Froude che aveva “perso… o meglio, consumato diversi mesi questa primavera a lavorarci in maniera tale da non farne una redazione diretta. Ho dovuto rivedere il mio piano e ciò che diventerà alla fine non posso prevederlo”. Le diceva solo che sarebbe stato un “oscuro lavoro filosofico… contenente poco di interessante e molto di deludente”. Così l’autore di uno dei più celebrati classici di teologia licenziò il suo prossimo lavoro! In ogni caso, il suo nuovo libro, Newman lamentava, gli era “costato”, pensava, più “impegno e ansia” di qualsiasi cosa avesse mai tentato. Aveva scoperto di avere “molti più materiali” di quanto “sapesse impiegarne”.
La difficoltà era di dare a questi materiali una forma e anche di chiarire “nella mia mente il principio che avrebbero dovuto seguire”. “Trascorsi due mesi leggendo e scrivendo senza risultato… non ho davvero speranza che sarà terminato prima dell’autunno – ammesso che ci arrivi. Non ho ancora scritto una frase, mi pare, che stia in piedi anche vagamente. Forse si diventa ipersensibili anche allo stile man mano che si va avanti con la vita… Il nostro tempo è così diviso qui, che non ho a disposizione più di 6 o 7 ore al giorno per lavorare ed è davvero stancante. Dubito di riuscire a fare di più. Ora lo sto scrivendo per la prima volta e ho fatto tre capitoli su 4 o 5. Oltre a riscrivere, ogni parte deve essere definita ed elaborata come se si trattasse di una statua da plasmare. Procedo come una persona che ha una caviglia zoppa, che non procede e arriva alla fine del suo viaggio”.
Entro il luglio 1845, poté fiduciosamente e tranquillamente dire ad un amico che non riusciva a vedere alternative fra l’abbandonare il Cristianesimo o entrare nella Chiesa Cattolica romana. Rifiutava di “credere solo a ciò che i nostri Riformatori avevano deciso con le loro teste che dovessimo credere – devo credere o di meno o di più. Se il Cristianesimo è uno e lo stesso in ogni tempo, allora io devo credere non ciò che i Riformatori hanno estratto da esso, ma ciò che la Chiesa Cattolica pensa”. “Perché” chiedeva “avrebbe dovuto credere solo a ciò che la Chiesa Inglese mi autorizza a credere e nulla più?”. La sfumatura di sarcasmo denota una nuova fiducia e suggerisce che infine egli aveva raggiunto quella piena certezza che è “sapere di sapere”.
Il libro era ancora incompleto in agosto ed egli era incapace di “sistemare il capitolo finale e più importante”, che aveva scritto “diverse volte invano”. Mai prima di allora aveva scritto e riscritto nulla così tante volte. Ma finalmente, alla fine di settembre, spedì quello che aveva già scritto agli stampatori. La “Premessa” al libro porta la data del 6 ottobre ed ha un postscriptum: “Dal momento che ciò che leggete sopra è stato scritto, l’Autore è entrato nella Chiesa Cattolica”. Era sua intenzione e suo desiderio portare il suo volume alle stampe prima di decidere di compiere il passo finale. Ma quando si è trovato ad un certo punto della stampa, riconobbe in se stesso una convinzione della verità della conclusione, a cui la discussione conduce, così chiara da rendere inutile ogni ulteriore decisione. Il libro non era quindi “una composizione finita”. Così come Newman avrebbe spiegato nella sua Apologia, “prima di arrivare alla fine decisi di essere ricevuto e il libro rimane nello stato in cui si trovava in quel momento, incompleto”. Finalmente sapeva di essere certo. E il 9 di ottobre del 1845, Newman fu ricevuto a Littlemore nella Chiesa Cattolica dal Beato Dominic Barberi, il missionario Passionista italiano.
EDOARDO ALDO CERRATO:
Cari amici, non vorrei sottrarre a Newman neppure pochi minuti, ma salutando i presenti alla luce del motto newmaniano “Cor ad cor loquitur”, permettetemi di dire che tra di essi vedo alcuni che sono miei amici ad un titolo specialissimo, poiché con essi, in tempi e luoghi diversi, ho avuto la grazia di condividere esperienze di fede – e di fede “che diventa cultura”, per dirlo con Giovanni Paolo II – esperienze che considero patrimonio prezioso della mia vita. Con alcuni di questi amici ho condiviso pure la partecipazione al Meeting per non pochi anni, prima che gli impegni del mio incarico mi rendessero difficile essere qui in questi giorni di agosto. Sono esperienze che porto nel cuore, come essi sanno e come ho avuto modo di dire, nel giugno scorso, a Roma, a Emilia Guarnieri.
Trovarmi qui, da questa parte della sala, vi confesso che mi intimorisce, ma la gioia di condividere con voi questo momento vince anche i ragionevoli timori. Grazie per la vostra amicizia!
Nel mio intervento non accennerò agli aspetti – ampiamente studiati e consegnati a numerose e pregevoli pubblicazioni – del pensiero di colui di cui già il ven. Pio XII disse: “Non dubiti, Newman sarà un giorno dottore della Chiesa”. Lo confidò a Jean Guitton, che ricordo di aver incontrato, qui al Meeting.
Mi soffermerò su una realtà che nella vita di Newman può apparire “minore” rispetto alla sua grandezza di pensatore, ma è una realtà che caratterizzò, invece, e profondamente, la metà di quella vita, dal 1847 alla morte, i 43 anni che Newman visse nell’Oratorio di San Filippo Neri, come discepolo del santo a cui il Meeting nel 1995 dedicò una splendida Mostra.
D’altra parte, proprio questo la Mostra si propone, di “ripercorrere il cammino della vita di Newman […] da cui emerge come la coscienza sia stata la forza motrice di tutto il suo cammino verso la certezza della verità”.
La vita!
“Anche negli scritti apparentemente più teorici – ha sottolineato Roderick Strange – Newman è una personalità che si è lasciata guidare da avvenimenti interiori ed esterni […] Fu sempre più interessato alla realtà che alla teoria. Si occupava di ciò che realmente accadeva” (R. STRANGE, John Henry Newman. Una biografia spirituale, Lindau, Torino, 2010, passim).
Newman stesso, infatti, nel Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana (1845), sostenne che una dottrina, una teoria, un enunciato mostra la sua effettiva vitalità quando diviene un “principio attivo”; attivo non solo nel senso che genera nell’uomo una nuova contemplazione o una rimeditazione: soprattutto nel senso che si traduce in azioni, in iniziative di applicazione. In tal senso, secondo Newman, si può affermare senza incertezze che il cristianesimo è stato sempre vitale. Nel sua Grammatica dell’assenso (1870) egli rileva che l’assenso nozionale (che è di tipo intellettuale e si configura come adesione teoretica ad una proposizione assertiva) è più debole di quello reale, che ha la capacità di sollecitare affetti, sentimenti, passioni, può coinvolgere la volontà, può generare azioni. Solo quando una dottrina muove l’aspetto affettivo, pratico, dell’uomo, essa si sviluppa nel corso del tempo e diventa forza storica.
E ancora, nella Grammatica dell’assenso, Newman afferma: “Il processo razionale che ci è più naturale non è da proposizione a proposizione, ma da cosa a cosa, dal concreto al concreto, da oggetto totale a oggetto totale” (G. A. 213-214).
Della vita di Newman il prof. Ian Ker – da insigne studioso – ci ha presentato le “conversioni”: la scoperta che Dio e l’anima sono reali, e che la presenza di Dio può essere percepita con la stessa concretezza e certezza con cui si percepiscono le realtà esteriori, gli oggetti della vita comune, i volti degli amici; la consapevolezza che la fede non si esaurisce in un’esperienza di dialogo intimistico con Dio ma diventa intelligenza della realtà; la scoperta che Dio ha deciso di “intromettersi negli affari umani” creando un luogo reale – la Chiesa – della sua presenza.
Sul percorso tracciato da queste conversioni si situa la vocazione oratoriana di Newman, la sua risposta ad una chiamata – quella all’Oratorio – che fu così importante da indurre uno studioso, il card. Jean Honoré, a parlare, anche a questo riguardo, di “conversione” (cfr. J. HONORE”, Newman. La fidelité d’une conscience, Chambray, 1986, pp. 14-16).
Newman oratoriano, dunque.
“Amo un vecchio dal dolce aspetto, – egli scrisse in riferimento a san Filippo – il suo pronto sorriso, l’occhio acuto e profondo, la parola che infiamma uscendo dal suo labbro quando non è rapito in estasi…”. E questo “amo…” ci fa comprendere che la scelta di Filippo Neri e dell’Oratorio filippino da parte di Newman – come ha sottolineato bene il padre Murray – non è stata una semplice scelta strumentale, ma una un elemento decisivo nel ricco percorso esistenziale di Newman.
A Leone XIII che, appena eletto, gli offriva la Porpora e che continuerà a chiamare Newman “il mio cardinale”, indicando in questa decisione le linee fondamentali del suo pontificato , Newman rispondeva: “Da trent’anni sono vissuto nell’Oratorio, nella pace e nella felicità. Vorrei pregare Vostra Santità di non togliermi a san Filippo, mio padre e patrono, e di lasciarmi morire là dove sono vissuto così a lungo”.
L’Oratorio era per lui, secondo la più autentica tradizione filippina, la sua casa: house e home … Ho letto recentemente un bel libro del caro amico Mons. Massimo Camisasca: “La casa, la terra, gli amici”. Grazie, don Massimo!
Giunto a Roma per il Concistoro, padre Newman scriveva al suo vescovo: “Il Santo Padre mi ha ricevuto molto affettuosamente stringendo la mia mano nella sua. Mi ha chiesto: “Intende continuare a guidare la Casa di Birmingham?”. Risposi: “Dipende dal Santo Padre”. Egli riprese: “Bene. Desidero che continuiate a dirigerla”, e parlò a lungo di questo”.
Newman fu affascinato dalla bellezza della sua vocazione: la descrisse nei suoi scritti oratoriani – presentati al pubblico italiano, lo scorso anno nella edizione di Cantagalli dell’opera di padre Murray, Newman the Oratorian – ma anche l’Apologia pro vita sua, forse la più famosa delle opere di Newman, si apre e si chiude con il ricordo di san Filippo e della sua Congregazione.
Che cosa, di Padre Filippo, affascinò John Henry Newman, spingendolo a scegliere l’Oratorio come forma e metodo della sua vita sacerdotale nella Chiesa Cattolica?
Newman lo espresse con un termine: “gentilezza”, nel quale vide l’armoniosa sintesi di tutto il mondo interiore del santo fiorentino, divenuto romano senza cessare d’essere quel che era: una dote iscritta nel temperamento di Filippo, ma cresciuta nella forte e dolce comunione con la presenza viva di Gesù Cristo, di cui Filippo ripeteva: “Chi vuol altro che non sia Cristo, non sa quel che si voglia”. Nella amicizia con Cristo fiorì la sua matura personalità, la singolare libertà di spirito che caratterizza Filippo, la sua intelligente discrezione, il convinto rispetto per le doti di ognuno, la sapiente semplicità, la gioia che Goethe, cogliendo in profondità lo spirito del santo, con stupenda sintesi definì “gioia pensosa”.
La scelta oratoriana compiuta da Newman – che tornò in patria portando con sé il breve del 1847 con cui il beato Pio IX istituiva l’Oratorio in Inghilterra, dando a Newman facoltà di propagarlo in quella nazione – è dettata dall’amore per la proposta di vita che venne da san Filippo Neri e che Newman visse intensamente e che lucidamente descrisse nei Sermoni sulla Missione di san Filippo Neri (Birmingham, 1850), nelle Lettere inviate da Dublino nel 1856 alla sua comunità, ed anche in alcune splendide preghiere.
L’Oratorio si affacciò sul suo orizzonte fin dal momento dell’ingresso nella Chiesa Cattolica, quando Wiseman lo persuase a ricevere l’ordinazione sacerdotale, suggerendogli l’Oratorio come la forma di vita più idonea a lui ed ai compagni che lo avevano seguito.
Sostenuto dalla convinzione che la sua vita doveva svolgersi in una comunità caratterizzata (cito Jean Honoré) “da un acuto senso della cultura e dal gusto innato per l’umanesimo”, “dal rispetto verso le persone e dal rifiuto di ogni coazione” (J. HONORE”, Itineraire spirituel de Newman, Paris, 1963, p. 162), Newman dedicò un anno al discernimento sulla propria vocazione: quello che trascorse a Roma dall’ottobre 1846 per prepararsi, con alcuni compagni, all’Ordinazione: già nel gennaio 1847, visitò l’Oratorio – che gli richiamò la sua esperienza dei Colleges universitari inglesi – e con il fedele amico St. John, per chiedere luce su quella vocazione, si recò per nove giorni al sepolcro di S. Pietro, dedicandosi, nel contempo, a studiare le Costituzioni e la storia dell’Oratorio. All’inizio di febbraio la decisione era presa: dopo l’Ordinazione sarebbero stati iniziati alla vita oratoriana dai Padri della Chiesa Nuova.
La figura di S. Filippo Neri, di cui già nel periodo anglicano Newman aveva qualche conoscenza, si fece a lui più familiare: “Mi ricorda in molte cose Kable – scrisse da Roma alla sorella Jemima – i due condividono la stessa totale avversione all’ipocrisia, il carattere gioviale e quasi eccentrico, un tenero amore agli altri e il rigore con se stessi”.
E al Prefetto di Propaganda Fide scrisse: “Abbiamo scoperto un cammino intermedio tra la vita religiosa e una vita completamente secolare; il che si adatta perfettamente a ciò di cui sentiamo il bisogno”.
Il 21 febbraio il progetto riceveva l’approvazione del beato Pio IX.
Ritornato in Inghilterra, nei sermoni predicati alla Comunità già tracciava della vocazione oratoriana una panoramica così esauriente che non sarebbe stata superata dalle successive acquisizioni.
Filippo Neri è colto da Newman nella sua originalità di “vir prisci temporis”, uomo del tempo antico: uno, cioè, in cui torna a farsi presente con evidenza l’origine del cristianesimo, l’inizio da cui tutto è sgorgato. Senza proclami ufficiali, in tutta semplicità, il suo Oratorio aveva assunto, infatti, il volto della comunità apostolica, come testimoniano, tra i primi, Cesare Baronio e Francesco M. Tarugi: “Sembrò riapparire, in relazione al tempo presente, il bel volto della comunità apostolica”.
La comunità oratoriana fu perciò per Newman: “…dodici preti che lavorano insieme: ecco ciò che desidero. Un Oratorio è una famiglia e una casa. Ciò che mantiene l’armonia comune è la delicatezza e la reciproca sollecitudine, la deferenza e la gentilezza, il mutuo apprezzamento, la conoscenza del modo di essere degli altri…”.
La “via” tracciata da padre Filippo è tutta contenuta in sintesi già nel “Proemio” delle Costituzioni: “…Il Santo Padre Filippo […] era solito dirigere con paterno afflato lo spirito e la volontà dei singoli suoi figli, secondo l’indole di ciascuno, stimandosi pago di vederli accesi di pietà e ferventi nell’amore di Cristo. Solo gradatamente e con garbo, andava sperimentando ed accertando come manifestazione della volontà del Signore ciò che, per diuturna esperienza, gli risultava essere loro congeniale ed utile, giorno per giorno, al raggiungimento della santità. Ed egli affermava con persuasione che questo genere di vita era realmente quanto mai adatto ai Sacerdoti secolari ed ai Laici, e conforme alla volontà divina”.
Una comunità di preti, dunque, totalmente dediti a Cristo, una vita familiare impostata sull’attenzione ed il rispetto della singola persona, la cui indole propria è un valore da potenziare nel bene e da formare alla luce dello Spirito, in un atteggiamento responsabile di autentica libertà che non solo non si oppone al cammino comune, ma diventa ricchezza all’interno della Comunità; senza dimenticare quel “gradatamente” (pedetemptim) e quel “con garbo” (suaviter) che sono preziosa lezione di realismo nell’opera di formazione condotta da padre Filippo.
La secolarità che la Congregazione garantisce, dentro una vita familiare ordinata, è una qualità, uno stile, che possiamo definire disposizione d’animo a percepire dall’interno le inquietudini dell’uomo; una disponibilità a stare nel mondo abitandolo, non beneficandolo dall’alto senza condividere le sue ansie: come ha fatto Gesù Cristo che non è stato un benefattore dell’umanità, ma si è incarnato, si è messo con noi, al nostro passo. Una secolarità che è il contrario del clericalismo, se per clericalismo intendiamo estraneità, arroganza, falsi complessi di superiorità, paternalismi avvilenti.
San Filippo Neri e l’Oratorio facilitarono a Newman anche la felice sintesi tra pietà e cultura di cui egli trovò un’altissima espressione nell’“Umanesimo devoto” di san Francesco di Sales, fondatore dell’Oratorio di Thonon prima di essere fatto vescovo: non è di poco rilievo che proprio da una lettera del santo savoyardo Newman abbia tratto il motto del suo stemma: Cor ad cor loquitur: stupenda espressione del principio fondamentale della vocazione cristiana: una chiamata all’incontro personale con Dio in Cristo; un incontro che sfocia nel rapporto autenticamente personale con gli uomini… “Il compito del nostro Istituto è di parlare al cuore”, già aveva detto uno dei primi discepoli di Padre Filippo, il card. Tarugi.
Per Newman “la parola non si comunica per pura ed esclusiva via astratta ma per i rapporti concretamente creati da una interiore affinità; dal momento che si conosce non solo con la mente, ma con tutta la persona, e quindi con l’affectus, secondo l’affermazione di Gregorio Magno: Amor ipse notitia, l’amore è in se stesso fonte e principio di conoscenza: amare è conoscere” ( I. BIFFI, John Henry Newman. Dicevano che fosse troppo liberale, in “L’Osservatore Romano” – 20.05. 2009).
Gli anni della vita oratoriana di Newman, tutti quelli che egli visse nella Chiesa Cattolica, furono per lui decisamente segnati da prove dolorose venute dall’esterno e anche dall’interno della Chiesa: attraverso di esse Newman si lasciò condurre, alla scuola di padre Filippo, fino alle vette dell’umiltà, a quella “mortificazione della rationale” che Filippo insistentemente insegnava e che non significa affatto rifiuto della coltivazione dell’intelligenza (la quale, nell’Oratorio, può estendersi, e si estese a tutti gli ambiti del sapere), né degli affetti umani (dal momento che la comunità oratoriana è fondamentalmente un’amicizia cristiana), e neppure un rifiuto dei beni temporali: è la rinuncia alla “voluntas propria”, all’autosufficienza, al fine di essere liberi senza essere indipendenti, solidali nella comunione.
L’Oratorio di san Filippo Neri – scrisse Louis Bouyer – “nasce dall’incontro, in san Filippo, tra un’anima eccezionalmente interiore e una mente eccezionalmente aperta” (Un Sacrate romain. St. Philippe Néri, Paris, 1978; traduzione italiana: La musica di Dio. San Filippo Neri, Milano, 1980, p. 101): sta qui la vocazione oratoriana a cui Newman si sentì chiamato e alla quale rispose con dedizione generosa e fedeltà creativa.
Tutta la sua storia – non solo i grandi momenti di essa – è stata un movimento di conversione; e ogni tappa raggiunta fu un traguardo e, al tempo stesso, un nuovo inizio, una dedizione scaturita dall’amore per Cristo che è l’Inizio perenne, l’Inizio su cui si fonda ogni nostra ripresa!
“Ex umbris et imaginibus in veritatem” volle scritto sul suo epitaffio: dalle ombre e dalle apparenze nella Verità…
Ombre ed apparenze non sono l’esito della vita: la meta è la Verità: “in veritatem”: non solo “ad veritatem”, ma “nella Verità” poiché la Verità non è un’idea: è una Persona, quella di Gesù Cristo vivo e presente nella sua Chiesa, incontrabile in un cammino di crescita che – Newman diceva – “è la legge della vita”.
“E l’esistenza diventa una immensa certezza”!
In quell’“e” iniziale del titolo del Meeting c’è anche tutta l’esperienza di Newman.
Grazie!
JAVIER PRADES LÓPEZ:
Sabato sera, a Quatro Vientos, il Papa ci ha insegnato che le difficoltà sopravvenute non possono evitare l’accadere del vero, anzi tirano fuori, fanno venire a galla con più chiarezza ciò che è di valore. E anche oggi questa piccola interruzione che abbiamo dovuto soffrire non può oscurare la ricchezza di contenuto e la finezza con cui padre Ian Ker e padre Cerrato ci hanno preso per la mano e ci hanno guidato nel percorso che Newman ha fatto per raggiungere la certezza. Che cosa abbiamo visto, che cosa abbiamo avuto davanti agli occhi in questo pomeriggio? Come due affreschi, come due ante di un dittico, con le due metà della vita di Newman. Padre Ker ci ha fatto cogliere lo spessore del dramma e la luminosità del dramma di John Henry Newman, fedele alla verità fino a riconoscere la verità della chiesa cattolica ed entrarvi. Padre Cerrato ci ha mostrato lo sviluppo della vocazione di Newman, vivendo l’oratorio di San Filippo. Con quali strumenti ha potuto Newman fare il percorso della sua vita? Abbiamo visto una ragione legata alla totalità dell’uomo e in paragone continuo con il reale. Un uomo in grado di dire: “questo è vero e io so che è vero” e che si paragona con tutti i dati che vengono fuori nella realtà sia nella chiesa antica sia nella vita contemporanea di Newman. Si vede che Newman ha raggiunto la certezza perché è stato capace di sacrificio. Chi è incerto non sacrifica nulla, perché non sa. Newman prima di diventare cattolico, e dopo anche, ha pagato di persona perché la verità non si cristallizzasse in dottrina ma nascesse dalla carne. Ha fatto un cammino, non si è aspettato un miracolo automatico o meccanico. “Neanche se avessi visto un miracolo”, diceva Newman “avrei raggiunto una convinzione più profonda”, ma ha fatto questo lavoro di paragone con lealtà nei confronti del reale. E come si vede alla fine, dove si traduce questa sua certezza non intellettualistica, non accademica? Nel fatto che lui sa ripetere con San Filippo: “chi vuole altro che non sia Cristo non sa quel che si voglia”. Ecco il test di un uomo certo che sa quello che vuole e lo cerca appassionatamente nel quotidiano, nella casa, aperto al mondo. Io mi auguro che la mostra, che è a nostra disposizione, il Meeting e la nostra vita, siano anch’essi caratterizzati da questa certezza di sapere quello che vogliamo, dall’esperienza di vivere una casa, di essere aperti al mondo. Ringraziamo di cuore padre Ker e padre Cerrato
(Trascrizione non rivista dai relatori)